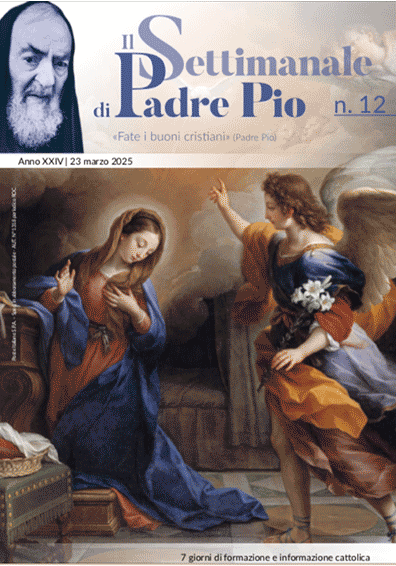Il demone del denaro
dal Numero 26 del 30 giugno 2019
di Riccardo Pedrizzi
Ai giorni nostri il mondo della grande finanza presenta un meccanismo analogo a quello della Rivoluzione francese, la quale inghiottì tra le sue spire coloro che ne furono i protagonisti. Oggi perseguire la ricchezza richiede dedizione totale, ma è difficile sopportare un’esistenza che non concede altro che il potere...

«Si è molto ragionevolmente osservato che la rivoluzione francese guida gli uomini più che questi non guidino la rivoluzione medesima»... «Gli scellerati stessi i quali par che regolino la rivoluzione, vi entrano solo come semplici strumenti, ed appena pretendono di dominarla, cadono vilmente»... «Robespierre, Callot o Barrère, non pensarono giammai stabilire il governo rivoluzionario ed il regno del terrore, vi furono portati insensibilmente dalle circostanze»... «Finalmente, quanto più si esaminano i personaggi della rivoluzione più attivi in apparenza, tanto più trovasi in loro qualche cosa di passivo e di meccanico».
Questo scriveva il grande pensatore cattolico controrivoluzionario Joseph de Maistre sulla rivoluzione dell’“Ottantanove” che aveva distrutto e divorato coloro che avevano messo in moto il meccanismo infernale.
Così sta accadendo ai nostri giorni anche per i guru della grande finanza. Chi ha creato, cioè, un sistema dove contano soltanto le performance dei profitti; dove bisogna raggiungere i risultati ad ogni costo e costi quel che costi; dove i mercati danno giudizi inappellabili sul brevissimo tempo, giorno per giorno, se non ad “horas” ed a frazione di minuto; dove per raggiungere gli obbiettivi assegnati non si esita a fare truffe planetarie ed a distruggere i risparmi di una vita di lavoro dei piccoli risparmiatori e persino le pensioni di anziani ed invalidi; chi ha creato questo mostro, che si chiama “mondo della finanza”, alla distanza non regge e la fa finita, suicidandosi, uccidendosi.
Negli ultimi anni l’intero settore finanziario è sotto shock, la crisi ha svuotato i portafogli e scosso le coscienze anche degli stessi operatori del mercato, che spesso hanno messo in discussione la propria vita travolta dall’ansia del successo e dalle lusinghe del facile guadagno.
Qualche anno fa, nel 2013, in Svizzera, un episodio apparentemente marginale aprì la strada a un fenomeno che si fece ben presto preoccupante. Un top manager, il cinquantenne Carsten Schloter, tedesco, chief executive officer del gruppo delle TLC Swisscom (che controlla l’italiana Fastweb) si suicidò nella sua abitazione, nei pressi di Friburgo, lasciando uno scritto illuminante: «Non puoi stare connesso con il lavoro ventiquattro ore su ventiquattro, non puoi cancellare la famiglia, non puoi scordare i figli, non puoi dimenticarti della vita». Ma già precedentemente in un’intervista aveva dichiarato che gli era «sempre più difficile scalare di una marcia la mia esistenza», ammettendo inoltre di temere di «finire senza accorgertene in un loop di attività compulsiva».
Dopo Shloter, a distanza di qualche mese, fu la volta di Pierre Wauthier, direttore finanziario del colosso assicurativo Zurich. L’uomo, 53 anni, fu trovato morto nella sua casa nel cantone di Zug. Lasciò moglie e due figli.
Precedentemente nel dicembre 2008 era stata la volta di Alex Widmer, amministratore delegato della Banca Julius Baer e poi di Adrian Wohler, cinquantatreenne, amministratore delegato dell’azienda dolciaria Ricola, che si era anch’egli tolto la vita nel novembre 2011. Tutti questi manager sarebbero stati affetti dalla Sindrome da burnout, la patologia che colpisce a seguito di ritmi di lavoro stressanti e per sovraccarico da stress. Questa patologia colpisce anche i gradi intermedi, come capitò, sempre nel 2013, con il suicidio dello stagista 21enne Moritz Erhardt, trovato morto dopo 72 ore di lavoro consecutive in Bank of America.
Qualcuno però riuscì a fermarsi sul baratro, come Joe Hogan, direttore generale di Abb, che nelle stesse settimane in cui, in quell’anno maledetto per i manager, si succedevano suicidi apparentemente inspiegabili, annunciava le sue dimissioni perché «stressato», dichiarando di voler dedicare «più tempo alla mia famiglia e alla mia vita privata», e rinunciando così ad uno stipendio milionario; o come Peter Voser, manager di successo in Shell, o ancora come il numero uno della Lloyd’s, Antonio Horta-Osorio, che chiese due mesi di aspettativa «per insonnia e sovraffaticamento da lavoro». Furono anni terribili per i grandi manager della finanza, fin dal 2008, inizio della grande crisi europea.
Ma lo stress da responsabilità, che colpisce perfino negli ovattati uffici in parquet d’acero della ricca e riservatissima Svizzera, continua a mietere vittime ancora oggi, come dimostra il suicidio nel 2016 di Martin Senn, amministratore delegato di Zurich Insurance: poco o nulla aveva insegnato, evidentemente, il “sacrificio” di Pierre Wauthier. Ma ci sono tanti altri esempi che confermano la difficoltà di sopportare una vita che non concede altro che il potere. Anche per le donne, costrette a dividersi tra la vita privata e l’affermazione di se stesse nel pubblico. Uno per tutti: quello della manager inglese, Danielle Saul, che si è impiccata nel 2016 per il terrore di restare single a vita mentre tutte le sue amiche, meno impegnate, si fidanzavano o si sposavano. E il suicidio (ammesso che non sia un omicidio) del manager di Mps David Rossi, forse per la vergogna degli scandali in corso?
La verità è che in questi ultimi decenni perseguire la ricchezza non è più nemmeno cercare il piacere, ma diviene una vera e propria “vocazione”; infatti “i signori dell’oro” godono della propria ricchezza meno dell’ultimo dei loro dipendenti e dei loro operai.
«Fiat productio, pereat homo», diceva giustamente Sombart. E così l’“uomo economico” fa del guadagno, degli affari e del rendimento un fine senza il quale la vita è del tutto priva di significato, e non comprende che «se le cose, il denaro, la modernità diventano centro della vita ci afferrano, ci possiedono e noi perdiamo la nostra stessa identità di uomini» e «Chi corre dietro al nulla diventa lui stesso nullità» (papa Francesco, Giornata dei catechisti, 29/09/2013). Il Santo Padre, ha confermato così quanto già detto nel corso dell’intervista a Civiltà Cattolica che «l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali» e, poi, ha ribadito ancora le parole pronunciate qualche giorno prima nel corso dell’omelia della Santa Messa presso la Casa Santa Marta: il denaro «ammala la nostra mente... ammala anche il pensiero». Il Santo Padre cioè non si stanca di metterci in guardia, avvertendo ciascuno di noi che se si sceglie la via del denaro «alla fine sarai un corrotto» perché il denaro «ha questa seduzione di farti scivolare lentamente nella tua perdizione».
Un monito che ha ripetuto negli anni, fino al messaggio quaresimale del 2017 sull’avidità del denaro, «la radice di tutti i mali». «Essa è il principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all’amore e ostacola la pace».
È accaduto inoltre, ai nostri giorni, che al principio tradizionale della limitazione del bisogno entro il quadro di una economia normale, cioè di una equilibrata economia di consumo, si è sostituito il principio della accettazione e dello sviluppo del bisogno stesso nella forma di una civiltà del lavoro e poi, e soprattutto, della macchina.
Si è arrivati ad un punto in cui il rapporto fra bisogno e lavoro è del tutto capovolto: non è più il bisogno che chiede il lavoro, ma è il lavoro (la produzione) che ha bisogno del bisogno. In regime di superproduzione, perché tutti i prodotti siano venduti, occorre che i bisogni dei singoli lungi dall’esser ridotti, siano mantenuti ed anzi moltiplicati, in modo che sempre più si consumi e si tenga sempre in moto il congegno che, se si inceppa, porta inevitabilmente ad una di queste conseguenze: o la guerra come mezzo violento per raggiungere una maggiore potenza economico-produttivo-lavoratrice; ovvero la disoccupazione (disarmo industriale) con la conseguenza di produrre crisi e tensioni sociali.
Fino a ieri ci si muoveva però, nonostante tutto, nell’ambito dell’economia reale. Infatti fino agli anni ’90 era il capitalismo industriale a prevalere. Tra General Eletric o General Motors e Golman Sachs erano le prime che contavano.
La finanza era al servizio dell’economia reale, cui tuttalpiù ne era alleata. Oggi le logiche e gli interessi dell’una e dell’altra sono invece in conflitto. La finanza compete con l’economia reale e le sottrae risorse. Fondare un’impresa, conquistare un mercato, lottare con il fisco e le banche, è un conto e richiede sacrifici, investire i propri soldi in un hedge fund o in un private equity e incassare la rendita è un altro ed è più facile. In particolare il PIL mondiale oggi arriva a 82/85 mila miliardi di dollari mentre i derivati OTC (Over the counter, cioè al di fuori di ogni contabilità regolamentata e trasparente) raggiungono i 633 mila miliardi di dollari: una distanza che aumenta sempre più e allontana la finanza dall’economia reale.
Questa caduta inarrestabile verso la degenerazione dell’economia e della finanza è iniziata da quando si è affermata la concezione secondo la quale ciò che conta è solo la materia. Se l’uomo è solo una macchina (antropologia illuminista), se non esiste se non la materia (materialismo), se non esiste lo spirito nell’uomo, nella storia allora contano solo i beni economici. E se i beni economici sono i veri ed unici “valori”, l’economia da mezzo si trasforma in fine. Nasce così l’economicismo secondo cui l’unica prospettiva è quella economica, l’unica ragione di vita è il risultato economico. Ed allora se ci si mette su questa china si può anche trascurare l’economia reale e privilegiare quella virtuale. Purché si guadagni.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Lo sposalizio della Beata Vergine Maria e il sacramento del Matrimonio
- 4 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 5 Le missioni straordinarie della beata Edvige Carboni
- 6 Alla ricerca del treno bianco
- 7 Degni più del Cielo che della terra
- 8 Il Matrimonio: un sacramento ormai sconosciuto?