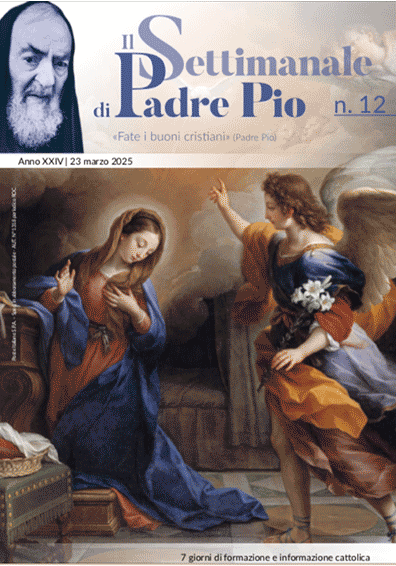Primavera di Praga, Primavera ghiacciata
dal Numero 40 del 21 ottobre 2018
di Giuseppe Butrimo
A cinquant’anni dagli eventi, rileggiamo una dolorosa pagina della storia comunista della Cecoslovacchia, quella che pose fine al sogno di un “comunismo dal volto umano” e insegnò al Paese a scrollarsi di dosso il giogo del comunismo.

A maggio di quest’anno ricorreva il quarto centenario dell’inizio della Guerra di Trent’anni: una ribellione poco gloriosa che cominciò a Praga. Oggi ricordiamo una ribellione ben diversa: nobile e gloriosa, sebbene destinata ad una tragica fine.
Dall’altra parte della cortina
Se è vero che il Sessantotto fu una ribellione, è altrettanto vero che ci furono ribellioni diverse a seconda dei luoghi. Come si sa, con la fine della seconda Guerra mondiale l’Europa si trovò divisa in due da quella che Winston Churchill definì «cortina di ferro». Mentre l’Occidente festeggiava la sconfitta della tirannide nazista, l’Europa dell’Est poteva solo contemplare gli sbirri comunisti che prendevano il posto di quelli nazisti: per chi veniva bastonato cambiava ben poco...
Il comunismo ebbe (come ogni tirannide che disgraziatamente perdura per più di qualche decennio) le sue fasi. Non entrando in troppi particolari, e restringendo il nostro campo d’interesse ai Paesi sottomessi al giogo rosso nel 1944-’45, possiamo dire che la prima, e la più terribile, di queste fasi – lo stalinismo – terminò (salvo l’eccezione dell’Albania) nel 1956, col famoso intervento di Kruscev. Stalin era morto da oltre tre anni e tuttavia il suo regime perdurava. Nel 1956 il nuovo capo dell’Unione Sovietica volle dire “sì al comunismo, no agli abusi”. Kruscev stesso aveva personalmente sulla coscienza qualche decina di milioni di vittime dell’Holodomor in Ucraina, ma ovviamente nel 1956 non si parlava degli abusi di Kruscev. Il cattivo in quell’occasione fu solo Stalin (e quelli tra i suoi collaboratori che Kruscev era riuscito a far fuori). Il comunismo, che in mezzo mondo era già apparso come la tirannide genocida più terribile di tutta la storia, andava salvato ad ogni costo!
Ben presto lo capirono gli ungheresi che nello stesso autunno del ’56 tentarono un cambiamento più profondo. E non giovò a nulla il fatto che quel tentativo fu promosso da alcuni membri del partito stesso. Il Paese venne invaso dai sovietici, e il comunista-riformatore fallito, Imre Nagy, venne giustiziato.
Dub?ek, Svoboda, libertà
Ma forse col passar del tempo e con un generale e continuo indebolimento della tirannide, le cose sono cambiate? Nella primavera del 1968 una prova simile a quella ungherese capitò alla Cecoslovacchia: e sicuramente non senza l’influsso di quel clima di ribellione che pervadeva l’altra parte dell’Europa. Il nuovo capo del partito comunista cecoslovacco, Alexander Dub?ek, rappresentava quello che certi ottimisti sognavano da tanto tempo: “il comunismo col volto umano”. A dire il vero, si poteva anche sperare che le riforme da lui avviate potessero portare alla caduta totale del comunismo. Basti pensare allo scioglimento dell’ufficio della censura, fondamentale per il sistema della menzogna e della propaganda che vigeva nei Paesi comunisti. La società risorgeva velocemente e gli orizzonti apparivano davvero promettenti. Tutta la prima metà dell’anno aveva portato nuove e continue riforme che concedevano più libertà ai cittadini: l’esempio di Praga veniva guardato con invidia da altri Paesi. Fu costretto alle dimissioni il presidente (carica comunque inferiore rispetto a quella del primo segretario del partito) Novotny, l’ultimo dei comunisti “duri” nel governo. Al posto suo veniva nominato un militare molto popolare, eroe della seconda Guerra mondiale, Ludvik Svoboda. Nomen omen, si potrebbe dire, perché “Svoboda” in ceco significa “libertà”.
Tutto ciò che accadeva a Praga non poteva non preoccupare sempre più vivamente i capi dell’Unione sovietica. Certamente, i comunisti volevano apparire come gente che ama la pace (basti pensare ai famosi congressi per la pace organizzati dopo la fine della guerra con la partecipazione di molti “utili idioti” come ad esempio Picasso), che rispetta i diritti umani... Ripetevano che la “democrazia popolare” (così si chiamavano le dittature comuniste) costituisce «la forma più alta della democrazia». Il beato cardinal Stepinac rispondeva d’esser d’accordo, a patto però che si aggiungesse un’altra sillaba: cosicché si sarebbe trattato della più alta forma di “demonocrazia”.
Orbene, il premier sovietico Brezniev e i suoi compagni demonocratici dovevano pur intervenire. Altrimenti la peste di Dub?ek avrebbe potuto diffondersi in tutto il blocco, finendo col disfarlo. Ma cosa fare, se Dub?ek era capo proprio dello stesso partito comunista? Si trattava, insomma, di un esponente di spicco della loro «forma più alta». Peggio ancora, la “Primavera di Praga”, così veniva chiamata questa esperienza politica, veniva appoggiata anche all’interno del mondo comunista. Non tanto per amore di quel poco di libertà che essa concedeva ai cechi e agli slovacchi, ma piuttosto per le discordie sorte con coloro che decidevano a Mosca. Così i dittatori di Romania e di Albania dichiararono la loro solidarietà con Dub?ek.
In quell’anno, che vide anche violente proteste in Polonia, dove a marzo ci furono parecchi morti; in quell’anno di proteste e rivoluzioni a Parigi, Berlino, Milano, l’Unione Sovietica aveva bisogno di mandare un chiaro messaggio: dalla sua parte di cortina di ferro il Sessantotto non sarebbe passato. E così nacque la famosa “dottrina di Brezniev”, ovvero “dottrina dell’indipendenza limitata”. Certo, si rispetta l’indipendenza della repubblica popolare cecoslovacca: ma la si rispetta nei giusti limiti, cioè finché ella è totalmente sottomessa ai compagni di Mosca.
Nostalgia della Moldava
Il 21 agosto 1968 la Primavera finì. Il sogno di un “comunismo con il volto umano” svanì, e il Paese, nella notte ancor buia, venne destato dal bel sogno con il rumore di seimila carri armati che lo invadevano da quattro parti: Germania Est, Polonia, Ungheria e direttamente dall’Unione Sovietica (frontiera ucraino-slovacca). Fu l’operazione “Danubio” che doveva riportare la Cecoslovacchia sul binario di un comunismo più sovietico. Verso Praga marciavano mezzo milione di soldati. Sopra il Paese volavano ottocento aeroplani da guerra. Fu l’operazione militare più grande nella storia europea del Dopoguerra.
Cosa si poteva fare? Il popolo sperava di esser aiutato da oltrecortina. Ma gli americani decisero che la cosa più pragmatica da fare era non fare niente: altrettanto decisero gli altri Paesi liberi.
Ci sono pervenute le drammatiche registrazioni dalle radiostazioni cecoslovacche, che continuarono a dare notizie degli eventi fino al momento della presa da parte degli invasori. Fino all’ultimo trasmise la Radio di Praga, ove si svolse l’unica, seppur piccola, battaglia di quel tragico 21 agosto. L’esercito cecoslovacco non combatteva: i capi dello Stato non diedero l’ordine di combattere (in effetti sarebbe stato superfluo considerata la sproporzione delle forze; e poi non si sapeva nemmeno prevedere come si sarebbero comportati i generali, appartenenti anch’essi alla classe governante comunista, di fronte all’invasione dei “fratelli”). Combatterono, dunque, gli abitanti di Praga. Distrussero tre carri armati russi, a costo di diciassette morti. E mentre davanti alla radio si combatteva, dalla radio – con lo sfondo delle grida e degli spari – ancora ci si appellava al mondo libero, chiedendo l’aiuto, chiedendo l’intervento. Invano. La Moldava, il nostalgico capolavoro di Bed?ich Smetana e assieme il segnale della radio, suonava in quel giorno ancor più nostalgicamente. Con gli ultimi appelli dello speaker si spegneva una grande speranza.
E quando il segnale radiofonico della Moldava finì, qualche altra voce venne a servire ai cechi, agli slovacchi e al mondo intero una nuova dose di propaganda comunista, ringraziando i sovietici per il loro intervento fraterno.
Barzelletta triste
Dopo il “Danubio”, la Cecoslovacchia per i successivi vent’anni rimase sottomessa a un regime più duro rispetto agli altri Paesi. Particolarmente severa era la censura. In una barzelletta eloquente di quel tempo, alla frontiera si incontravano un polacco e un ceco: “Come va?”, chiedeva il polacco. “Non posso lamentarmi...”, rispondeva il ceco con la faccia estremamente triste.
La “Primavera di Praga” non rimase però senza frutti. Forse anche grazie a quella lezione dolorosa, ventun anni più tardi non si pensò più a un “comunismo più umano”, ma si operò la “decomunistizzazione” (che nel caso della Cecoslovacchia fu sicuramente più profonda rispetto non solo a quella dei Paesi post-sovietici, ma anche, ad esempio, rispetto a quella della Polonia).
- 1 Alla scuola della Sacra Famiglia
- 2 Un santo 2025? “Vademecum” spirituale per non perdere la rotta
- 3 Il Natale e l’Eucaristia Il piccolo Agnello nato a Betlemme
- 4 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 5 Maria è mia Madre
- 6 Lo sposalizio della Beata Vergine Maria e il sacramento del Matrimonio
- 7 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 8 Tra terra e Cielo San Pio e il tempo natalizio