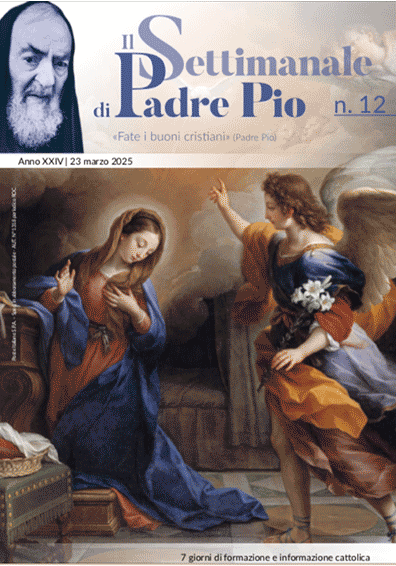Amore alla propria Congregazione
dal Numero 49 del 13 dicembre 2015
di Padre Ludovico Colin
È molto stretta la relazione che corre fra il Religioso e il suo Istituto. La più piccola azione del consacrato, materiale come spirituale, ha risonanza nell’andamento generale della sua Congregazione. Il suo amore verso l’Istituto deve concretizzarsi sotto vari aspetti.

La gratitudine, la venerazione, la sottomissione fedele sono sentimenti che si riassumono e si condensano nell’amor filiale. È ammissibile che un Religioso non senta altro che indifferenza e freddezza davanti alla madre sua, la Congregazione? Sarebbe un figlio malvagio, un estraneo in mezzo ai Confratelli; un ramo secco ancora unito al tronco, ma senza linfa e che un colpo di vento farà cadere un giorno o l’altro. «Io amo ciascuno di voi – diceva sant’Alfonso ai suoi figli –, come me stesso, o piuttosto più di me; tuttavia, quando mi accorgo che uno di voi non ama più la Congregazione, mi vedo costretto, mio malgrado, a congedarlo, anche se fosse mio fratello» (1).
Ci possono essere degli Istituti illustri e venerandi, più ricchi d’uomini, di opere, di prestigio e santità che la nostra Famiglia religiosa, e noi saremo i primi a rallegrarcene e a riconoscerlo. Ma noi dobbiamo riservare alla nostra Congregazione il più profondo affetto e la più sentita devozione, anche se è meno in vista, proprio perché troviamo in essa quello che non c’è nelle altre.
«Le Figlie della Visitazione parleranno sempre con molta umiltà della loro piccola Congregazione e preferiranno le altre ad essa nella stima e nell’onore, ma daranno alla loro una preminenza nell’amore... Così le donne devono preferire i loro mariti a qualunque altro, non nell’onore, ma nell’affetto; così ciascuno predilige la sua patria agli altri paesi e l’ama e la stima più d’ogni altra terra; così il nocchiero ha caro il vascello più degli altri, benché più ricchi e meglio attrezzati. Con franchezza riconosciamo che altre Congregazioni sono migliori, più ricche e più eccellenti, ma non più amabili e più care per noi, perché il Signor nostro volle che trovassimo la Patria, la barca e lo sposo nel nostro Istituto» (2).
L’amore per l’Istituto è nello stesso tempo affettivo ed effettivo: amore di cuore e di opere: «diligamus... in opere et veritate» (1Gv 3,18). Chiunque ami la sua Congregazione assume un duplice dovere: favorirne, con tutti i mezzi, la diffusione, il fervore, la potenza di apostolato e per conseguenza, combattere ed evitare tutto ciò che formerebbe ostacolo e pericolo per la sua esistenza, la sua vitalità e la sua fecondità.
Un Ordine possiede una triplice vita: intima, sociale e apostolica.
La vita intima risulta dal fervore e dalla santità di tutti i sudditi in generale e in particolare. Dal punto di vista soprannaturale un Istituto vale secondo l’eccellenza delle anime che lo compongono.
La vita sociale risiede nell’unione stretta e attiva dei suoi membri. Ogni Congregazione è una società; ora ciò che dà forza e consistenza ad una società è la coesione e l’unità. «L’unione fa la forza», mentre «ogni regno diviso è destinato alla rovina e le case crollano una sull’altra» (Lc 11,17).
Un duplice principio assicura agli Istituti la pienezza della loro vita sociale: l’autorità e la carità. L’autorità dirige, comanda e mantiene l’ordine con la sottomissione di tutti; la carità apporta pace e gioia e forma il vincolo dei cuori. Vinculum caritatis.
Di qui l’importanza assoluta dell’obbedienza e della fraternità d’animo nello stato religioso.
Ogni Congregazione, al fine principale che è la santificazione dei suoi membri, aggiunge un Fine secondario che è ancora essenziale, cioè lo spirito di conquista, le attività dello zelo entro l’ambito stabilito dalla Regola e dalle Costituzioni.
Tale collaborazione alla redenzione delle anime e alla estensione del Regno di Dio costituisce la «Vita apostolica». Di fronte a questa triplice vita intima, sociale e apostolica quale dev’essere l’attitudine e l’influsso d’un Religioso veramente affezionato al suo Istituto?
«La vita sociale non è che una rete di multiformi relazioni, un incrocio di azioni e di reazioni in mezzo alle quali non si può nemmeno concepire un’attività isolata e separata dalle altre. Qualunque passo noi tentiamo di fare, qualunque gesto noi abbozziamo, la solidarietà è lì, pronta a collegare la nostra iniziativa e la nostra azione alle iniziative e alle azioni dei nostri fratelli; e ogni più segreto pensiero, ogni più fuggevole desiderio ha una risonanza così vasta che lo spirito non sarà mai capace di misurarne l’estensione» (3).
Così avviene nelle società religiose, dove ogni membro, con la sua mentalità e con la sua moralità, con le parole, con gli atti, con lo spirito di regolarità e la sua attività apostolica, esercita, magari a sua insaputa, un influsso buono o nefasto, talvolta assai considerevole sul corpo intero dell’Istituto. Tale ascendente è più eccellente e profondo nel Religioso che ami appassionatamente la sua Congregazione. «Mie care sorelle, se noi avessimo mille vite, noi dovremmo spenderle tutte per accrescere quest’opera. Quale sventura se la Compagnia fosse sminuita per nostra colpa... Sorelle, chi potrebbe assistere alla distruzione di questa Compagnia, senza fondersi in lagrime! Dovremmo morire di crepacuore, se ciò avvenisse» (4).
Le Congregazioni devono apprezzare sopra ogni cosa la pienezza della loro vita soprannaturale, radice e linfa della loro vita sociale e apostolica. In realtà un Ordine conta meno per il numero dei suoi membri, delle sue case e l’espansione delle sue opere, che per lo spirito religioso, per il suo valore morale e la sua potenza di santità. L’anima eccelle sul corpo.
Povero quell’Istituto che si estende e si arricchisce a spese delle sue virtù che languiscono: «Potentia quidem et divitiis maior, sed virtutibus minor facta sit» (San Girolamo). Il detto di Bossuet sulle Nazioni si applica pure alle Congregazioni: «I popoli esistono fin quando dalla loro moltitudine possono uscire dei Santi». Quando un Istituto non produce più dei Santi, è destinato a scomparire, perché non ha più ragione d’essere.
Ogni Religioso che ami il suo Ordine sa che il suo dovere primo e principale è di mantenervi e accrescere la vita soprannaturale con il suo fervore personale. Il più importante servizio che un soggetto possa rendere al suo Istituto e la più bella testimonianza di affetto e di fedeltà che possa dare alla Madre sua è di essere tra i Confratelli il tipo del perfetto Religioso, una di quelle anime che hanno adottato come linea di condotta la riflessione d’un filosofo e il consiglio di santa Teresina: «Agisci in modo che la tua condotta possa diventare regola universale di azione».
La devozione alla propria Famiglia religiosa trova la sua formula nella legge della edificazione, del «buono zelo» (Regula sancti Benedicti, c. 72). “Aedificare”: è una parola felice e molto espressiva. “Aedificare”: significa costruire e non demolire; elevare e non abbassare; sviluppare e non soffocare. Ora, ogni Religioso, ci pensi o no, nella vita quotidiana lavora a edificare o a demolire il suo Istituto; ad elevarlo o a rimpicciolirlo; a fortificarlo o a sgretolarlo. Ogni azione è una pietra aggiunta alla costruzione, oppure un colpo di piccone contro il muro. E chi sono quelli che edificano e quelli che demoliscono?
Sono buoni costruttori i Religiosi che osservano con fedeltà la Regola, che vivono umili, poveri, casti, obbedienti, raccolti, e hanno la forza di trascinare con il buon esempio, opponendosi agli abusi che tentano di penetrare anche nelle migliori comunità.
Sono demolitori tutti coloro che, pur non essendo cattivi, rimangono soggetti volgari, rilassati; quei Religiosi a metà che snervano la disciplina regolare, inquinano lo spirito primitivo e favoriscono la decadenza. Tra tutti i nemici delle sacre Istituzioni, questi sono i peggiori, perché vivono in casa (5).
Note
1) Opere ascetiche, t. XII, p. 288.
2) I veri Trattenimenti.
3) P. Bureau, L’indiscipline des moeurs, c. 6, pp. 308-309.
4) San Vincenzo de’ Paoli, Opere, t. IX, p. 686.
5) Ivi, t. XI, p. 443.
- 1 Alla scuola della Sacra Famiglia
- 2 Un santo 2025? “Vademecum” spirituale per non perdere la rotta
- 3 Il Natale e l’Eucaristia Il piccolo Agnello nato a Betlemme
- 4 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 5 Maria è mia Madre
- 6 Lo sposalizio della Beata Vergine Maria e il sacramento del Matrimonio
- 7 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 8 Tra terra e Cielo San Pio e il tempo natalizio