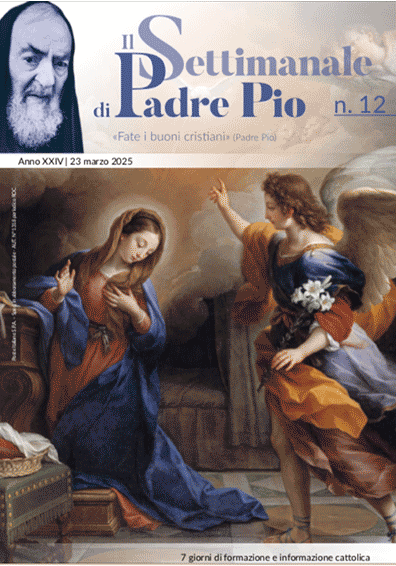La saggezza degli antichi
dal Numero 42 del 26 ottobre 2014
di Fabrizio Cannone
Nei detti dei Padri antichi è ravvisabile una sapienza che riflette, almeno in parte, la luce della Sapienza eterna. Curiosa, interessante e ancora valida, ad esempio, è una massima sul matrimonio tratta dal poeta greco Esiodo.

Tutti i grandi Padri della Chiesa (secoli I-VI), sia orientali che occidentali, hanno studiato, stimato e tenuto in gran conto la saggezza degli antichi, ovvero il sapere accumulato dai secoli precedenti al Cristianesimo che non raramente rifletteva quella luce che «illumina ogni uomo» (Gv 1). È noto che il Dottore Angelico stimasse particolarmente il grande Aristotele, definito per antonomasia il Filosofo; ma dovrebbe ricordarsi che lo stesso Tommaso amava leggere e studiare anche altre importanti figure del passato come Platone, Cicerone, gli stoici e Plotino, e nelle sue opere vi sono moltissime citazioni di autori pagani classici, e perfino di filosofi ebrei ed arabi. Ma anche i 4 Dottori principali della Chiesa latina (Girolamo, Agostino, Ambrogio e Gregorio Magno) e i 4 Dottori della Chiesa d’Oriente (Atanasio, il Crisostomo, Basilio e Gregorio di Nissa) abbondano di rimandi ai filosofi pre-cristiani. Come mai? Si potrebbe dire, giustamente, che la somiglianza tra la filosofia cristiana e le varie filosofie pagane dovrebbe essere assai inferiore alla dissomiglianza tra le stesse vista la novità assoluta del Cristianesimo, con l’irruzione del Verbo tra di noi e la rivoluzione a 360° che ha apportato alla cultura e all’umanità. E questo non è falso. Però i grandi Patres non la vedevano esattamente così e cercavano anche nelle filosofie più antiche del paganesimo, specie greco e romano, degli elementi di continuità con il Vangelo, quasi dei semi del Verbo già misteriosamente sparsi e da far fruttificare senza far troppo rumore. In altre parole, è vero che Gesù innova e presenta in modo assolutamente diverso il rapporto tra uomo e Dio, tra uomo e uomo, e tra uomo e natura; ma è anche vero che i migliori pensatori dell’evo antico, nelle loro più alte intuizioni, raggiunsero delle vette di sapienza che non debbono essere annichilite (o trascurate) dall’avvenimento cristiano, ma solo perfezionate e purificate.
E questo soprattutto per quel che concerne il ragionamento filosofico-morale, in cui varie scuole pagane, come lo stoicismo, arrivarono a vere e proprie dimensioni di razionalità precristiana. La fede poi non abolisce la ragione, né la grazia di Dio distrugge la natura, né il cristiano sopprima l’uomo razionale: ergo, tutto è grazia, sia la grazia propriamente detta, dataci da Dio attraverso suo Figlio, sia, in senso lato, la natura umana e la razionalità, preesistenti all’Incarnazione e non completamente guastate dal peccato di Eva (contro il delirio di Lutero). Altrimenti, sarebbe come dire che un buon chirurgo debba essere cristiano per esercitare bene l’arte medica o che un calciatore abbia bisogno della fede per giocare bene: no, la fede non serve ad operare e a togliere un tumore, né a realizzare gol. Così, anche senza la fede si può giungere a Dio per via razionale e se si arriva sino a Dio si può arrivare pure alla spiritualità e all’eternità dell’anima, all’idea del giudizio dopo la morte, della bruttezza del peccato (almeno inteso come atto contro la ragione) e alla stima delle più nobili virtù umane (come la forza, il coraggio, la pazienza, la bontà, ecc.). In effetti nei filosofi classici, per esempio nelle Lettere a Lucilio di Seneca troviamo elogiate le virtù naturali e cristiane, con un’enfasi e una retorica degna di un Crisostomo o di un predicatore!
Una sola citazione, di rara bellezza, basterà ad illuminare il discorso fin qui fatto. È tratta da Esiodo, poeta greco dell’VIII secolo a.C., noto soprattutto per il poema Le opere e i giorni. Secondo lo studioso Federico Roncoroni «le massime e i precetti cui nel poemetto Le opere e i giorni affida i suoi insegnamenti morali sono animati da una profonda religiosità, da un alto senso di giustizia e, soprattutto, da un grande amore per il lavoro, visto, insieme con la laboriosità e con la fatica, come l’unico mezzo atto a garantire agli uomini equilibrio, benessere e felicità». Insomma un autore di sicuro interesse.
Ebbene nella sua opera principale Esiodo ha scritto molte massime degne di nota come queste: «A chi conosce la verità e la proclama Zeus dà la felicità»; «Spesso un’intera città paga le colpe di un solo malvagio»; «Le cose rubate non fanno ricchezza»; «Non guadagnare soldi malamente: i soldi guadagnati malamente sono soldi maledetti»; «Vale poco l’uomo che ora ha un amico e ora un altro»; «Se sparli di qualcuno, aspettati di sentire presto anche cose peggiori sul tuo conto», ecc.
Ma vorrei soffermarmi su una sua riflessione sul matrimonio che, sebbene attualissima, pare tolta da un predicatore del medioevo. «L’età giusta per sposarti è quando non sei molto lontano dai trent’anni né li hai superati di molto [quindi 25-35]. Colei che scegli, sia donna da quattro anni e vada sposa al quinto. Sceglila vergine, in modo che tu le possa insegnare costumi virtuosi. Scegline una che abiti dalle tue stesse parti e, prima di prenderla in moglie, valuta tutto per bene, se non vuoi far ridere i tuoi vicini. Quanto al resto, sappi che per un uomo non c’è niente di meglio che avere una moglie saggia e niente di peggio che averne una cattiva».
Sull’età del matrimonio penso che non ci sia molto da dire, ma che si possa tranquillamente convenire con Esiodo: essendo il matrimonio una scelta indissolubile e fino alla morte certamente non vada troppo anticipata. Oggi poi a 20 anni si è di norma poco maturi per scegliere bene e i 25-30 anni appaiono preferibili per un uomo. Che la donna ne debba avere alcuni in meno, come si evince dal costrutto, non è affatto una sciocchezza, né pare superato. Anzi i 4-5 anni a cui fa riferimento Esiodo potrebbero indicare il periodo del fidanzamento e anche questo lustro è oggi di importanza capitale: né giova tirare troppo per le lunghe (eterni fidanzati) ma neppure voler abbreviare troppo la frequentazione per saltare le tappe. Bisogna conoscersi a fondo e il tempo indicato dall’Autore pare oggi non riducibile.
Quanto alla verginità della sposa il discorso si farebbe delicato e non vogliamo dire molto, tranne questo: se perfino un pagano loda la purezza dei costumi, specie nel sesso femminile, ciò è indice di quel buon senso naturale che proprio i cristiani, per primi, dovrebbero avere. Oggi, sappiamo tutti, senza falsi moralismi ipocriti, qual è l’andazzo della gioventù italiana ed europea... Dobbiamo però favorire una cultura dell’attesa e della pazienza, senza arrivare a scandalizzarci di ciò che succede comunemente. Tutte le mamme cristiane dovrebbero fare un grande sforzo educativo per instradare al meglio i loro figli e soprattutto le loro figliole: dalla serietà delle ragazze dipende, in positivo e in negativo, la moralità degli adolescenti e dei giovani. Le madri cattoliche debbono criticare il velinismo, il cubismo (delle cubiste), le star musicali oscene e le attrici impudiche. Senza pruderie ma anche senza concessioni. Se Esiodo, che non conobbe il Verbo, parla di “costumi virtuosi”, cosa dovremmo dire noi cristiani?
Sul fatto di prendere in sposa «una che abiti dalle tue stesse parti», si potrebbero sollevare dispute e contumelie, come se si trattasse del noto detto, mogli e buoi dei paesi tuoi. Ma abitare nelle stesse parti può significare altro. Oggi, non ha senso, specie in città, voler sposare di preferenza quella della porta accanto poiché magari ha idee sulla famiglia e sulla vita distanti anni luce da noi. Questo abitare gli stessi luoghi va visto come una frequentazione di idee e paesaggi (interiori) dello stesso tipo: due cristiani, anche se nati e cresciuti in contesti diversi, possono abitare meglio assieme proprio perché i loro cuori abitano già la stessa isola di grazia, che è la Santa Chiesa. In tal senso, davvero è bene fare opera di discernimento e cercare chi condivide idee, sentimenti, ideali e religione. Sposarsi per sposarsi, senza valutare tutto ciò, per mero sentimentalismo o per non restare soli è sbagliato e spessissimo doloroso. Non basta aver ricevuto il Battesimo per dirsi cristiani, bisogna condividere gli ideali del Vangelo, soprattutto sulla concezione della famiglia e dell’educazione dei figli. Altrimenti si fa cilecca!
Condivisibile è poi la conclusione dell’aforisma esiodeo: nulla per un uomo è meglio che avere per moglie una donna saggia (e per una donna avere un marito savio) e nulla v’è di peggio del contrario. Esserne convinti, 2700 anni dopo Esiodo, è segno di saggezza e porta alla prudenza nelle relazioni umane, specie tra ragazzi e ragazze in vista della famiglia.
I divorzi e le separazioni, le liti e le violenze domestiche non piacciono a nessuno, ma pare impossibile oggi costituire un matrimonio durevole. Ispirarci alla saggezza degli antichi deve essere la norma per chi non vuole vivere secondo la logica mondana.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale