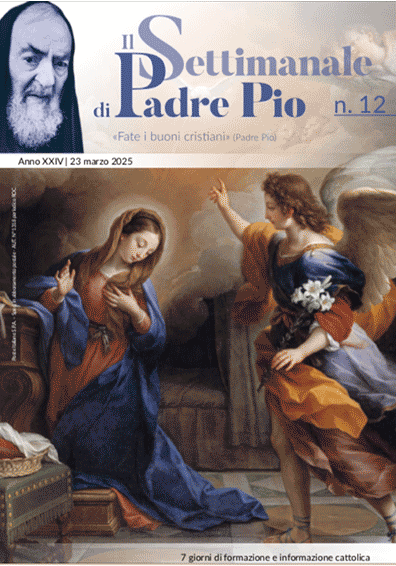La Soddisfazione
dal Numero 5 del 2 febbraio 2014
di Padre Angelomaria Lozzer, FI
Di grande importanza sono le preghiere o i piccoli impegni di penitenza che il sacerdote dà in Confessione dopo l’assoluzione! La cosiddetta “soddisfazione” è parte integrante del Sacramento ed è bene compierla il prima possibile.

I nostri doveri riguardo alla soddisfazione
1) Il primo dovere è quello di accettare e volentieri la penitenza che ci viene imposta.
a) Le opere che comunemente si impongono come penitenza sono la preghiera (come l’ascoltare una Messa, la Via Crucis, il Santo Rosario, altre preghiere vocali...), il digiuno o altre pratiche di mortificazione corporale o spirituale (come l’astenersi da qualche divertimento, cibo preferito...), l’elemosina ed altre opere buone corrispondenti alla qualità ed al numero dei peccati.
Queste tre specie di opere soddisfattorie corrispondono alla radice delle tre grandi concupiscenze o passioni: la superbia, l’avarizia e la lussuria. Nell’orazione infatti ci umiliamo, mortificando così la superbia; col digiuno, privandoci di qualche cosa lecita e piacevole ai sensi, mortifichiamo la lussuria e la sensualità; con l’elemosina mortifichiamo l’avarizia.
Quello che ci viene imposto dunque è il vero rimedio ai nostri mali e per questo dobbiamo accettarlo volentieri.
b) Si pensi che un tempo, quando il fervore tra i cristiani era alto, la Chiesa procedeva, rispetto ad adesso, con molto più rigore nell’imporre la penitenza ai peccatori. Le opere soddisfattorie richieste erano grandi, faticose e lunghe. Per i delitti maggiori non si concedeva nemmeno l’assoluzione se non in pericolo di morte e dopo una vita trascorsa nella più rigorosa penitenza. I Canoni Penitenziali della Chiesa milanese, per esempio, prevedevano che chi compiva un’opera servile in giorno di festa, dovesse fare penitenza per tre giorni a pane ed acqua, chi frodava nei pesi e nelle misure per venti giorni e chi chiacchierava in chiesa durante gli Uffici divini, per dieci giorni. Inoltre, a chi teneva balli in giorno di festa e davanti alla chiesa erano richiesti tre anni di penitenza e lo stesso dovevano fare quelli che avevano ingiuriato i propri genitori.
Per i peccati più gravi, come l’omicidio, l’adulterio, l’apostasia, vi erano poi le penitenze pubbliche. Ci si doveva vestire con abiti meschini, cospargersi di cenere, cingersi di cilici, e piangendo i propri peccati si doveva domandare perdono con segni di vero pentimento.
Verso la metà del secolo III i peccatori pubblici erano divisi in quattro classi che segnavano l’iter per poter essere assolti. All’inizio si entrava tra i Piangenti, che dovevano stare, anche nei rigori della stagione, fuori della Chiesa a supplicare i fedeli che entravano di pregare per loro. Poi si passava agli Ascoltanti, che potevano entrare in Chiesa per ascoltare la lettura dei Libri santi e le istruzioni, ma dovevano uscire prima dell’Offertorio al pari dei catecumeni e degli scomunicati. C’erano poi i Prostrati, che potevano trattenersi in Chiesa, avvicinarsi all’altare, ma sempre in ginocchio, e potevano rimanervi solo fino all’oblazione della Sacra Vittima. Infine c’erano i Consistenti, che potevano stare in piedi, potevano unirsi alle preghiere dei fedeli, ma non potevano partecipare all’offerta né comunicarsi in pubblico. In tutto questo tempo dovevano poi astenersi dai conviti, dalle conversazioni, e dovevano macerarsi con digiuni...
Oggi i confessori non impongono più penitenze così gravose come d’altra parte i peccati esigerebbero, e questo, non perché la Chiesa abbia cambiato opinione al riguardo, ma a motivo della debolezza fisica e morale in cui oggi versa la cristianità. La Chiesa, piuttosto che correre il rischio di allontanare i fedeli da questo Sacramento, con pericolo di vederli dannati per non aver voluto confessare i propri peccati e averne voluta fare la debita penitenza, preferisce piuttosto concedergli il perdono con l’onere poi di doverli espiare in purgatorio.
L’obbligo di fare una penitenza corrispondente alla gravità dei peccati quindi rimane in vigore come lo era un tempo. Se non lo si farà qua lo si dovrà fare poi di là nell’altra vita.
c) Le opere soddisfattorie più efficaci per scontare il nostro debito con Dio sono comunque quelle imposteci dal confessore, perché ricevono dai meriti di Gesù Cristo uno speciale valore. Quindi, anche se piccole, acquistano un grande valore agli occhi di Dio che le riguarda come opere dello stesso Figlio Unigenito, condonandoci buona parte, se non tutta, della meritata pena temporale.
Se poi la penitenza che ci viene imposta dal confessore non fosse per noi davvero fattibile, è lecito e anzi doveroso farlo presente in modo tale che possa essere mutata con un’altra.
2) Il secondo dovere che abbiamo nei confronti della soddisfazione è quello di eseguirla, perché mancare volontariamente di farla è sempre peccato: mortale, se fu data in espiazione di peccati mortali; veniale, se fu ingiunta per peccati veniali.
3) La penitenza va poi eseguita con esattezza, sia riguardo al tempo (nel giorno o nell’ora stabiliti) , che al luogo (chiesa, casa...), che al modo stabilito dal sacerdote; senza modifiche e quanto prima possibile. In altre parole bisogna fare la penitenza tale e quale è stata imposta, senza variarla di propria testa, e con quello spirito di umiltà, di dolore, di devozione e di raccoglimento che è richiesto dall’atto che si compie. Nel fare la penitenza dobbiamo perciò conservare il pensiero di voler soddisfare alla divina Giustizia, rinnovando il dolore dei nostri peccati.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Lo sposalizio della Beata Vergine Maria e il sacramento del Matrimonio
- 4 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 5 Alla ricerca del treno bianco
- 6 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 7 Degni più del Cielo che della terra
- 8 Il Matrimonio: un sacramento ormai sconosciuto?