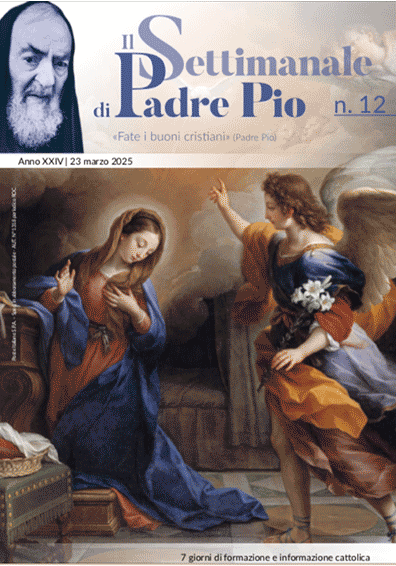Un detective analizza i Vangeli
dal Numero 31 del 2 agosto 2020
di Padre Angelomaria Lozzer
Nelle mani del detective J. W. Wallace i Vangeli diventano un caso giudiziario. Ecco l’inchiesta, condotta secondo i criteri della scienza forense, che ha portato l’esperto Detective dall’incredulità alla fede.

Abbiamo già parlato in un articolo precedente del detective J. Warner Wallace e del suo libro Alive: a cold-case approach to the Resurrection, in cui investiga dal punto di vista forense sulla Morte e Risurrezione di Cristo. Ora lo vorremmo seguire in quell’altro suo viaggio indagatorio, ben più ampio, che lo ha portato alla conversione cristiana: la testimonianza dei Vangeli.
Certo, portare i Vangeli in un’aula di tribunale, di fronte a una giuria, può sembrare alquanto irrispettoso, ma di certo in queste pagine non si vuole mettere in dubbio l’autenticità, la veracità e l’integrità dei santi Vangeli, né si vuole seguire il dubbio metodico di cartesiana memoria; al contrario, si vogliono indossare i panni dell’avvocato che intende non solo scagionare gli Evangelisti da qualsiasi accusa di falsità e fantasia che il mondo gli attribuisce, ma anche dimostrare tutto il valore probativo di quella testimonianza.
Sì, perché «la fede viene dall’ascolto» (Rm 10,17). La fede è la risposta libera a Dio che si rivela, ma la sua Parola giunge a noi per mezzo della mediazione dei suoi testimoni. E questa fede, che noi abbiamo ricevuto, dobbiamo a nostra volta trasmetterla agli altri. Eppure, assistiamo ogni giorno a una continua perdita della fede tra il popolo, fede che sembra vieppiù sgretolarsi e affievolirsi. Ciò che gli Apostoli hanno annunciato e insegnato fino dare la vita, oggi sembra essere gettato nel grande calderone del mito e del fantasioso. Anche in ambito cattolico, dove alta dovrebbe conservarsi la fede, in fondo ciò che conta sembra essere l’insegnamento che possiamo trarre dai Vangeli, più che la realtà dei fatti stessi, separando pericolosamente quello che è il contenuto teologico da quello storico. Ma se i fatti nel Vangelo sono davvero soltanto delle allegorie, vale ancora la pena spendere la propria vita per esso? La fede nel Dio fatto uomo, che gli Apostoli hanno visto, toccato, udito, ha ancora il suo senso?
Noi crediamo fermamente che i Vangeli sono stati ispirati da Dio e che attraverso questi Dio ci parla e ci comunica la sua Parola, la sua Volontà, la Verità che è Lui stesso. Ma con ciò non possiamo negare che essi sono anche libri storici, che ci narrano fatti realmente accaduti, visti e testimoniati da coloro che ne furono testimoni. Basti citare qui il prologo di san Luca: «Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,1-4). Se ogni domenica affermiamo che l’autore della Sacra Scrittura è Dio, altresì affermiamo che tale scritto è di Matteo, di Marco, di Luca, o di Giovanni. Gli Evangelisti furono prevenuti e assistiti da una grazia unica e straordinaria, che chiamiamo divina ispirazione, per mezzo della quale essi hanno scritto tutto e soltanto quello che Dio voleva scrivessero, impedendo loro di errare, al fine di portare a tutti il messaggio della salvezza inalterato e completo; ma nello stesso tempo ciascuno di loro ha scritto il proprio Vangelo utilizzando appieno le proprie facoltà (intelletto e volontà), talenti, capacità, linguaggio, punto di vista, in base all’esperienza personale che essi hanno fatto di Gesù.
Ecco allora il lavoro che vogliamo compiere: dimostrare che i Vangeli sono davvero frutto delle testimonianze degli Apostoli, che riportano davvero ciò che essi hanno sperimentato, visto e toccato, affinché anche noi, come loro, possiamo credere che il Figlio di Dio è davvero venuto in mezzo a noi, si è fatto uomo, è entrato nella storia, è morto ed è risorto per trasformare la vita di ciascuno di noi.
Seguiamo dunque l’indagine del nostro detective da lui pubblicata nel suo libro Cold-Case Christianity: a homicide Detective investigates the claims of the Gospels, edito nel 2013, risultato di un approfondimento maturato lungo diversi anni.
In questo libro Wallace applica ai Vangeli il metodo forense utilizzato per verificare la veracità di un testimone, e che può essere sintetizzato in quattro punti fondamentali.
Assicurarsi che:
1) il testimone sia stato davvero presente ai fatti;
2) la sua testimonianza sia corroborata da altre prove;
3) la testimonianza sia stata conservata e trasmessa accuratamente lungo il tempo senza inquinamenti o manomissioni;
4) la testimonianza non sia stata inficiata da altri fini.
1° REQUISITO:
I VANGELI RIPORTANO TESTIMONIANZE OCULARI
DI CHI FU DAVVERO TESTIMONE AI FATTI
Non è un caso che molti scettici e atei tendano a relegare la testimonianza dei Vangeli ad autori molto tardivi, forse del II secolo. Infatti, in questo modo possono facilmente attribuire tutto ciò che sa di miracoloso e soprannaturale alla fantasia esaltata delle primitive comunità cristiane, imbevute ormai del “mito” di Gesù. Quanto alla paternità data a Matteo, Marco, Luca o Giovanni, è da loro facilmente spiegata: quale maggiore garanzia potevano avere per assicurare autorevolezza e diffusione allo scritto se non ponendola sotto la firma di un apostolo?
Se così fosse, però, non si capisce come le primitive comunità cristiane avessero attribuito due Vangeli a persone che non avevano mai conosciuto Gesù (san Luca e san Marco) piuttosto che a un qualsiasi altro apostolo, né si capisce il perché non avessero considerato come autentici i Vangeli apocrifi, attribuiti ad apostoli come san Giuda o san Giacomo (effettivamente riconosciuti più tardivi), per ritenere unanimemente autentici solo quelli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
A queste domande naturalmente i nostri scettici non sanno rispondere. Il fatto è che per trovare una spiegazione naturalistica ai fatti miracolosi narrati nei Vangeli sono costretti a dare tempo e possibilità al “mito” per potersi creare. Sarebbe, infatti, impensabile inventare fatti circostanziali riguardanti una figura contemporanea e conosciuta come Gesù ed essere poi creduti. Ecco perché a questi tali dobbiamo rispondere che la loro indagine, per essere davvero imparziale come affermano, deve essere libera da tutti i pregiudizi, compresi quelli riguardanti il soprannaturale, per lo meno dando a Dio la possibilità di esistere e di operare.
Quali sono dunque gli indizi reali che abbiamo? Possiamo confermare l’antichità dei Vangeli e datarli all’epoca in cui vissero i testimoni dei fatti? Noi diciamo di sì.
Seguiamo l’analisi di Wallace:
a) Né i Vangeli, né gli Atti degli apostoli parlano della distruzione del Tempio avvenuta per mano dei Romani nel 70 d.C., avvenuta dopo tre anni di assedio. Si tratta di un fatto epocale per il giudaismo. Gesù stesso lo aveva predetto (cf. Mt 24,1-3). Perché dunque gli Evangelisti avrebbero dovuto tacerlo, quando esso confermava e dimostrava la capacità divina di Gesù di predire eventi futuri? Infatti, altre predizioni di Gesù riportate dagli Evangelisti si erano adempiute, a riprova del fatto che Egli era davvero Dio e conoscitore del futuro. Se un evento così importante è stato taciuto, possiamo ragionevolmente pensare che esso non si era ancora compiuto al momento della stesura dei Vangeli.
b) Luca negli Atti degli Apostoli non ci parla della morte di Pietro e Paolo, seppur importantissima per la chiesa primitiva, avvenuta la prima nel 64 e l’altra nel 65 d.C. Anzi il libro degli Atti termina mentre san Paolo, ancora vivo, si trova prigioniero a Roma. Ora noi sappiamo che san Luca aveva già ultimato il Vangelo (“il suo primo libro”) quando iniziò la stesura degli Atti degli apostoli: quindi, il suo Vangelo deve essere fatto ragionevolmente risalire a qualche anno prima.
c) San Paolo nella sua prima Lettera a Timoteo scrive: «Dice infatti la Scrittura: Non metterai la museruola al bue che trebbia, e: Il lavoratore ha diritto al suo salario». Ora se la prima citazione è presa dal libro del Deuteronomio (25,4), la citazione «il lavoratore ha diritto al suo salario» è tratta dal Vangelo di Luca (10,7). Quindi, il Vangelo di Luca era già conosciuto dalla comunità cristiana tanto da essere citato come “Scrittura” da san Paolo.
d) Le Lettere del Nuovo Testamento ai Romani, ai Corinti e ai Galati, considerate all’unanimità dell’apostolo san Paolo, e datate tra il 48 e il 60 d.C., fanno eco ai Vangeli e ci presentano Gesù come il Risorto, il Figlio di Dio, Dio incarnato: «Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguitapparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancorao , mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me» (1Cor 15,3-8). San Paolo attesta anche di essersi confrontato, tre anni dopo la sua conversione, con gli Apostoli, testimoni oculari della vita e dei fatti di Gesù: «Andai a Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi presso di lui quindici giorni» (Gal 1,18). L’idea perciò della costruzione di un mito tardivo attorno alla figura di Gesù da parte delle comunità cristiane del II secolo non tiene conto di questi dati: il Gesù dei miracoli, risuscitato da morte, raccontato dagli Evangelisti, è il medesimo che san Paolo attesta di aver veduto risorto, che gli Apostoli gli hanno confermato di aver anch’essi veduto risorto, e che, quel che è più importante, fu da san Paolo pubblicamente annunciato in un momento storico in cui molti di questi testimoni oculari erano ancora vivi e avrebbero potuto smentirlo: «Apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora».
a) Nella sua prima Lettera ai Corinzi, datata tra il 53 e il 57 d.C., san Paolo ci riporta il racconto dell’Ultima Cena: «Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me”» (1Cor 11,23-25). Secondo Wallace questo brano è una citazione del Vangelo di san Luca (Lc 22,19-20) che è l’unico a riportare le parole di Gesù «fate questo in memoria di me» e che, pertanto, il Vangelo di san Luca è da considerarsi di qualche anno anteriore a questa Lettera.
b) L’evangelista Marco scrive, secondo la Tradizione, attingendo direttamente dalla bocca e dalla predicazione di san Pietro. Un’analisi attenta del testo ci conferma questo atteggiamento rispettoso di san Marco nei confronti di san Pietro (egli cita più volte l’Apostolo, anche dove non è richiesto, tralasciando invece ciò che più torna a sua maggior umiliazione). Ebbene, quello che emerge dal Vangelo di Marco è una certa urgenza di divulgare il messaggio evangelico, senza curarsi troppo dell’ordine dei fatti. Lo dice anche Papia (95-150 d.C.) nelle sue Spiegazioni dei detti del Signore riportateci dallo storico Eusebio di Cesarea: «Marco, divenuto interprete di Pietro, scrisse con accuratezza, ma non con ordine, tutto ciò che ricordava delle parole e dei fatti del Signore. Egli, infatti, non aveva udito il Signore né era stato suo discepolo, ma più tardi, come dicevo, aveva accompagnato Pietro, il quale impartiva le sue istruzioni secondo i bisogni, ma senza fare esposizione ordinata dei detti del Signore, cosicché non commise colpa Marco scrivendo alcune cose così come le ricordava. Egli ebbe una sola preoccupazione, di non omettere nulla di quanto aveva inteso e di non introdurre alcun errore».
Per questa urgenza, che si legge tra le righe, Wallace paragona il Vangelo di Marco al primo rapporto che il detective fa appena giunto sulla scena del delitto e ricollega questa fretta al pensiero dominante presente nella prima comunità cristiana, ossia del ritorno imminente di Cristo. D’altra parte gli stessi Apostoli ritenevano che Gesù sarebbe tornato presto. Ciò spiega l’urgenza di Marco nel divulgare il suo Vangelo senza curarsi dell’ordine cronologico: non aveva senso rimandare o aspettare. Questa fretta ci spinge a porre il Vangelo di Marco in una data molto vicina ai fatti raccontati e prima del Vangelo di Luca.
c) Leggendo il Vangelo di Marco si rileva un buon numero di persone non identificate. Marco non riporta il nome di chi estrasse la spada nel giardino del Getsemani, né il nome della guardia a cui fu reciso l’orecchio; non ci dice il nome della donna che nella casa di Simone il lebbroso gli versò il profumo, non parla della risurrezione di Lazzaro... quasi volesse proteggere tali persone... È, infatti, proprio dei testimoni della prima ora escludere i riferimenti che possano compromettere o avere ripercussioni sulla vita di qualcuno dei propri cari ancora vivente. Tale preoccupazione non avrebbe senso a distanza di anni, quando il pericolo è scongiurato o le persone di cui si parla sono già morte. Ecco perché san Giovanni, che secondo la Tradizione scrive per ultimo il suo Vangelo, ha avuto la piena libertà di identificarli.
Con questi indizi Wallace conclude che i Vangeli debbano essere stati scritti prima del 70 d.C., perché non parlano della distruzione del Tempio; prima del 67-70 d.C., perché non parlano dell’assedio di Gerusalemme; prima del 61-65 d.C. (per lo meno per quanto riguarda il Vangelo di Luca), perché gli Atti degli apostoli non parlano della morte degli apostoli Pietro e Paolo. Ora, se gli Atti degli apostoli si possono collocare tra il 57-60 d.C., e la citazione dell’Ultima Cena nella Lettera ai Corinzi attorno al 53-57 d.C., il Vangelo di Luca potremmo ragionevolmente pensarlo scritto attorno al 50-53 d.C. e, per conseguenza, il Vangelo di Marco tra il 45-50 d.C.
Anche l’archeologia sembra confermare questa tesi, sebbene le prove qui riportate non trovino tutti gli studiosi unanimi. È il caso del famoso frammento 7Q5 rinvenuto assieme ad altri antichi rotoli nelle caverne di Qumran nel 1947, nel quale sono state identificate alcune lettere dei versetti 52-53 del capitolo 6 del Vangelo di Marco. Questo frammento è datato intorno all’anno 50 e, trattandosi di una copia, la stesura del testo originale va datato senz’altro prima. Anche i tre frammenti del papiro P64 (detto anche papiro di Magdalen), contenenti alcuni versi del cap. 26 del Vangelo di Matteo, sono stati datati dal papirologo tedesco Carsten Peter Thiede tra il 30 e 70 d.C., e più precisamente intorno agli anni ’50. Trattandosi anche qui di una copia in greco dell’originale aramaico andato perduto, la sua stesura sarebbe senz’altro da anticipare di qualche anno.
Al di là, comunque, della datazione data da Wallace e dall’archeologia, ciò che possiamo dire è che tutti gli indizi ci conducono nella medesima direzione verso la quale la storia e la testimonianza dei primi scritti cristiani ci hanno sempre indirizzato: ossia che i quattro Vangeli sono stati scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, vissuti nel I secolo, due dei quali testimoni diretti della vita, delle opere, della Morte e Risurrezione di Gesù (Matteo e Giovanni) e due contemporanei e familiari, in senso largo, degli Apostoli (Marco e Luca). Certo, Marco e Luca non conobbero direttamente Gesù, ma la loro testimonianza è degna di essere da tutti creduta, perché san Marco, come già detto, scrisse il suo Vangelo attingendo alla predicazione di san Pietro; e Luca scrisse il suo “resoconto ordinato”, non senza aver fatto, come dice egli stesso, “ricerche accurate su ogni circostanza” (cf. Lc 1,1-4) presso coloro che ne furono testimoni.
Dunque, le fonti storiche, le prove interne al testo e l’archeologia ci attestano unanimemente che la stesura dei Vangeli è stata fatta in un tempo estremamente vicino ai fatti, quando molti dei testimoni oculari erano ancora vivi e in grado di suffragare e confermare ciò che è stato scritto. Al contrario l’attribuzione dei Vangeli ad autori ignoti del II secolo non offre alcuna spiegazione ragionevole, lineare e convincente a tutti gli indizi sopra riportati. Pertanto questa prima prova forense può dirsi superata.
2° REQUISITO:
LA TESTIMONIANZA DEI VANGELI
È CORROBORATA DA ALTRE PROVE
Il detective dopo aver appurato la reale presenza del testimone al crimine, e quindi la sua reale conoscenza dei fatti, verifica che la sua testimonianza sia corroborata da altre prove che ne confermino la veracità.
Cerchiamo, dunque, di vedere quali elementi confermano la testimonianza degli Apostoli.
a) La prima prova di supporto la troviamo all’interno del testo comparando la testimonianza di un Evangelista con quella degli altri tre, verificando se le loro testimonianze sono concordi, coerenti e senza contraddizioni. Naturalmente dobbiamo stare attenti a non precipitare in falsi giudizi. È, infatti, normale che le testimonianze portate in tribunale abbiano delle contraddizioni apparenti, e questo perché ogni testimone vede la scena dal suo punto di vista, in base al proprio bagaglio culturale, alla posizione in cui si trova al momento del crimine, ecc. Che diremmo, infatti, se le testimonianze dei giurati fossero tutte perfettamente sovrapponibili? Potremmo sospettare che i giurati si siano premeditatamente accordati su ciò che dovevano dire e ciò che dovevano nascondere. Occorre quindi vagliare le testimonianze evangeliche per distinguere le eventuali reali contraddizioni da quelle soltanto apparenti. Ad esempio, san Matteo nel discorso della montagna dice che “Gesù salì sulla montagna”, mentre san Luca ci dice che «disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante». Questo salire dell’uno e scendere dell’altro è una contraddizione reale o apparente? Anzitutto va tenuto conto che Gesù poteva ripetere lo stesso discorso in luoghi diversi, secondo quello che era il metodo rabbinico allora in voga, e i due Evangelisti potrebbero riferirsi a due episodi diversi. Ma potremmo anche spiegare l’apparente contraddizione con il punto di vista di partenza diverso dei due Evangelisti. Per chi è stato su quegli altipiani della Galilea, e ha visto quei saliscendi attorno al lago di Genezaret, è facile farsene un’idea.
Wallace dà poi una grande importanza ai cosiddetti “supporti non intenzionali”, o “supporti inconsapevoli” dei testimoni. Abbiamo già detto, infatti, che ogni Evangelista differisce in qualcosa dall’altro poiché osserva lo stesso evento da angolature diverse. Ora sono proprio questi particolari a darci involontariamente degli indizi sulle affermazioni degli altri, indizi attraverso i quali possiamo verificare la veracità di un’affermazione o la sua falsità.
Facciamo un esempio. Prendiamo in considerazione il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci riportato da tutti e quattro gli Evangelisti (Matteo 14,13-21, Marco 6,30-44, Luca 9,12-17, Giovanni 6,1-14).
Gli Apostoli sono appena rientrati dalla loro missione apostolica per città e villaggi. Dopo aver raccontato a Gesù tutto quello che avevano fatto e insegnato, Gesù li invitò a prendere un po’ di ristoro. Saliti sulla barca, si diressero verso un luogo deserto; ma la folla, saputolo, li precedette all’altra riva. Gesù allora sentendo compassione per loro cominciò a predicare e a guarire i malati che vi si trovavano. Fattasi sera, non volendo mandarli a casa digiuni, presi 5 pani d’orzo e due pesci offerti da un ragazzo e fatta sedere la gente, li distribuì per mano degli Apostoli. Furono tutti saziati e coi pezzi avanzati furono riempite 12 ceste. Il miracolo era evidente, e lo stupore della folla crescente. Ora, dagli Evangelisti sappiamo che la folla presente al miracolo era di 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Come mai tanta folla in un luogo deserto? Né Matteo, né Marco, né Luca ce ne danno una ragione. San Giovanni soltanto ci dice che la folla lo cercava «perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi» e aggiunge anche che «era vicina la Pasqua». Questo particolare ci può far supporre che molti fossero in cammino per Gerusalemme e, avendo sentito parlare dei segni che Gesù compiva, avesse voluto incontrarlo lungo il tragitto. Ecco che qui Giovanni offre due ragioni al perché della folla che gli altri Evangelisti non danno.
Ma continuiamo la nostra analisi. San Giovanni ci dice anche che la domanda «dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Gesù la rivolse a Filippo. Ma perché proprio a Filippo? San Giovanni non ce ne dà una ragione, ma da san Luca apprendiamo che il luogo dove si trovavano non era molto distante dalla «città chiamata Betsaida». Ora san Giovanni nel brano della chiamata di Natanaele, ci dice che Filippo era di Betsaida. Dunque Gesù interroga Filippo perché Filippo era di quella zona: chi più di lui poteva dare una tale informazione? Ecco che san Luca involontariamente ci dà la spiegazione di ciò che san Giovanni afferma.
Ancora. San Matteo ci dice che in quell’occasione Gesù ordinò alla gente di sedersi sull’erba, e san Marco aggiunge che essa era “verde”. Ora né san Matteo, né san Marco ci dicono il perché c’era erba, né tanto meno perché fosse verde, ma san Giovanni ci ha detto che era vicina la festa di Pasqua, che per gli ebrei cadeva il 15 del mese di Nissan, e quindi a conclusione del periodo delle piogge. Giovanni quindi involontariamente corrobora l’affermazione di Marco, ossia che l’erba effettivamente poteva essere verde. Il periodo di Pasqua ci illumina anche sulla presenza dei pani d’orzo: infatti era il periodo della mietitura dell’orzo. Naturalmente si potrebbe continuare con gli esempi ma ciò che vogliamo qui dimostrare è che la testimonianza degli Evangelisti è continuamente corroborata da prove di “supporto involontario”: ciò che non spiega un Evangelista lo spiega involontariamente un altro, suffragando la veracità della sua testimonianza.
b) Gli scrittori evangelici riferiscono nomi corretti di località e nomi propri di persona. Molti luoghi riportati nei Vangeli potevano dirsi completamente sconosciuti ai più. Pensiamo a un paese come Naim o come quelli sviluppatisi attorno al lago di Genezaret. Difficilmente si sarebbero potuti citare quei luoghi senza una grande familiarità con quella terra, giacché essi non figurano né nell’Antico Testamento, né in altri scritti. Ora se i Vangeli fossero stati davvero opera di comunità cristiane vissute nel II secolo, frutto di autori provenienti dalle grandi comunità cristiane di Antiochia o di Roma, non si potrebbe dare una ragione plausibile a una tale precisione e familiarità con la geografia palestinese del tempo.
Quanto ai nomi propri, un ricercatore, di nome Ilan, ha assemblato il lessico di tutti i nomi utilizzati dagli ebrei di Palestina tra il 330 a.C. e il 200 d.C., esaminando, oltre al Nuovo Testamento, anche gli scritti dello storico Giuseppe Flavio, i documenti del deserto della Giudea e Masada, le prime opere rabbiniche del periodo e le iscrizioni dell’ossario provenienti da Gerusalemme. Egli scoprì che i nomi più popolari in Palestina durante l’arco di tempo che comprendeva quello dei racconti evangelici erano Simone e Giuseppe (per gli uomini), Maria e Salomè (per le donne). Ora, se poniamo in parallelo le percentuali dei nomi più popolari contenuti nel Nuovo Testamento e quelli contenuti nelle altre fonti, possiamo notarvi una perfetta congruenza. Se, come ci dice la critica scettica, gli scrittori dei Vangeli fossero degli autori tardivi, che si misero a inventare anche i nomi dei personaggi dei racconti evangelici, dovremmo rimanere più che meravigliati per questa loro precisione nell’uso degli stessi. Tanto più che i nomi maggiormente popolari in altri paesi come l’Egitto, la Siria o Roma erano all’epoca di Gesù molto diversi (in Egitto ad esempio il più popolare era Eleazar, che risulta solo terzo nella lista dei nomi più usati in Palestina e così via). Gli stessi nomignoli che gli Autori sacri usano per distinguere un Simone dall’altro ci indicano la reale popolarità di quel nome all’epoca dei Vangeli: Simone lo Zelota, Simon Pietro, Simone il Lebbroso, Simone di Cirene... E gli esempi potrebbero continuare con altri nomi propri.
c) Ci sono testimonianze non bibliche che corroborano le descrizioni fatte nei Vangeli. Per esempio, l’ebreo Giuseppe Flavio (37ca.-100 d.C.) nelle Antichità Giudaiche ci parla della morte di san Giovanni Battista: egli menziona l’esecuzione di Giacomo, fratello di Gesù, e ci descrive Gesù come un “uomo saggio”, che aveva numerosi discepoli tra i Giudei e le altre nazioni, che Pilato condannò ad essere crocifisso e a morire, ma del quale i suoi discepoli non smisero di seguire gli insegnamenti, raccontando che era apparso loro vivo tre giorni dopo la sua crocifissione e che forse era il Messia di cui parlavano i profeti.
Lo storico Sesto Julio Africano nella sua Storia del mondo del 221 d.C. cita l’opera del samaritano Thallus (ca. 5-60 d.C.), contemporaneo di Gesù, che riporta l’oscuramento del sole e il gran terremoto avvenuto al momento della crocifissione del Signore. Thallus negò che l’oscurità al momento della crocifissione fosse stata causata soprannaturalmente, attribuendola a un’eclisse solare, ed è per questo che il cristiano Sesto Julio Africano lo citò con tono polemico, ma pur tuttavia esso confermò l’affermazione che Gesù fu crocifisso e che in quel momento l’oscurità coprì la terra.
Anche Cornelio Tacito ci parla di Gesù nei suoi Annali, seppur con disprezzo nei confronti dei cristiani. Egli ci dice che Gesù fu condannato dal procuratore romano Ponzio Pilato, sotto il regno di Tiberio, in Giudea.
Il filosofo siriano Mara Bar-Serapion (circa 70 d.C.), scrivendo al figlio per incoraggiarlo, paragona la vita e la persecuzione di Gesù a quella di altri filosofi perseguitati per le loro idee. Parla di Gesù come di un uomo influente, morto per ciò in cui credeva, che in questa morte ebbero parte gli Ebrei e che i suoi seguaci hanno vissuto coerentemente i suoi insegnamenti.
Seppur tutte queste informazioni fuori dell’ambiente cristiano possano essere incomplete, a volte confuse e imprecise, tuttavia confermano nelle linee essenziali le notizie riportateci dagli Evangelisti circa la vita, la morte e la risurrezione di Cristo.
d) Nel passato le notizie riportate dai Vangeli furono spesso ritenute false semplicemente perché non corroborate da altri testi. Quando poi sembravano contraddire altre fonti allora venivano subito bollate di falsità e utilizzate per scopo anti-cristiano. Tuttavia dobbiamo notare che più l’archeologia avanza con le sue scoperte, più conferma i dati evangelici.
Faccio un esempio. San Luca ci dice che al tempo del censimento era governatore della Siria un certo Quirino. Ora, lo storico ebreo Giuseppe Flavio nel suo libro Antichità giudaiche ci dice che Quirino governò dal 5 al 6 d.C.; un periodo quindi troppo avanti per poter essere accordato con il regno di Erode il Grande. Le scoperte archeologiche del XIX secolo però hanno messo in luce che dall’11 a.C. fino alla morte di Erode fu proconsole della Siria e della Cilicia Quirino (probabilmente omonimo di quello menzionato da Giuseppe Flavio). Il suo nome, infatti, venne rinvenuto inciso su una moneta di quel periodo, come anche sulla base di una statua eretta in Pisidia d’Antiochia.
Un altro esempio eclatante lo abbiamo nella Piscina di Bethesda, descritta da san Giovanni nel suo Vangelo, e considerata un falso storico fino a che gli scavi archeologici a Gerusalemme non l’hanno riportata alla luce. Presso il mar Morto è stato poi rinvenuto anche un altro documento, di epoca antecedente alla distruzione di Gerusalemme, in cui, descrivendo la città, tra le altre cose è menzionata la piscina “Beth Eshdathayin” localizzata vicino a un porticato.
E gli esempi si potrebbero moltiplicare.
Per quanto riguarda i tratti essenziali, possiamo concludere che le testimonianze evangeliche hanno ampia conferma nei testi extra biblici e nella documentazione archeologica; trovano conferma più specifica, per quanto riguarda i dettagli, attraverso i supporti involontari degli Evangelisti tra loro; l’uso dei nomi e delle località è corretto e conforme al luogo e al periodo dei testimoni; il greco utilizzato è conforme all’uso fatto presso le regioni interessate e al tempo in cui furono scritti. Dunque anche questa seconda prova forense è pienamente superata.
3° REQUISITO:
I VANGELI SCRITTI DAGLI EVANGELISTI SONO STATI TRAMANDATI
SENZA INQUINAMENTI
Finora abbiamo verificato l’attendibilità dei testimoni evangelici: il fatto che furono presenti agli eventi narrati e che le loro testimonianze sono suffragate da diversi elementi interni ed esterni ne comprovano la veracità. Ora non ci resta che verificare se queste testimonianze sono state conservate senza inquinamenti, adulterazioni, aggiunte sostanziali e consegnate a noi nella loro originale integrità.
Alcuni studiosi scettici e atei sostengono l’aggiunta di testi fantasiosi alle primitive testimonianze evangeliche da parte delle primitive comunità cristiane. Questi tali si poggiano sul fatto che gli originali dei Vangeli e le copie più antiche sono andate perdute. Non c’è da stupirsi dal momento che in principio i copisti si servirono di un materiale facilmente deteriorabile, quale era il papiro. Dobbiamo aspettare la libertà costantiniana, con la libera circolazione dei testi, per avere i primi codici del Nuovo Testamento su pergamena. Ed è, quindi, dal IV-V secolo che l’integrità dei Vangeli è garantita dai codici. Ma che dire del tempo intercorso tra la stesura originale dei Vangeli e il IV secolo?
Non avendo testi scritti di questo periodo, la via da seguire è quella della cosiddetta catena di conservazione. Cioè, dobbiamo accertarci che gli anelli di congiunzione tra gli Apostoli e i cristiani del IV secolo siano assicurati da altre fonti. E il primo anello di questa catena ci è dato senz’altro dai discepoli degli Apostoli, alcuni dei quali a noi noti, e dei quali conserviamo alcuni scritti. Ad esempio, di sant’Ignazio di Antiochia, discepolo di san Giovanni evangelista, successore di san Pietro alla cattedra di Antiochia, noi possediamo 7 lettere scritte a diverse comunità cristiane del suo tempo. Tali lettere lasciano intendere la conoscenza dei Vangeli e delle Lettere di san Paolo, come anche la sua conoscenza personale degli Apostoli, conoscenza che sembra avere in comune anche con alcuni dei suoi interlocutori. È chiaro che lo scopo di sant’Ignazio non è qui quello di parafrasare i Vangeli, ma piuttosto quello di incoraggiare e ammonire i cristiani del suo tempo. Eppure, se guardiamo le descrizioni che egli ci fa di Gesù ne possiamo notare tutta la sovrapponibilità con quanto descrittoci nei Vangeli. Se poi agli scritti di sant’Ignazio aggiungiamo quelli degli altri discepoli degli Apostoli e di quelli dei loro immediati successori, quali san Policarpo, sant’Ireneo, sant’Ippolito, san Clemente, san Giustino Martire, san Clemente di Alessandria, ecc., il quadro che ne risulterà sarà ancora più evidente, completo e robusto. Tanto più che questi discepoli degli Apostoli operarono in aree geografiche molto diverse, distanti tra loro.
Da loro apprendiamo che Gesù fu predetto dai profeti dell’Antico Testamento, che era discendente di Davide, concepito di Spirito Santo, vero Figlio di Dio, vero Dio, nato dalla Vergine, annunciato da una stella. Egli uscì da Dio e manifestò la volontà e la conoscenza di Dio. Fu battezzato da Giovanni Battista, visse una vita umile, modesta, perfetta e senza peccato. Pronunciò le parole di Dio e insegnò alle persone molte verità divine, tra cui il “Sermone della montagna”. Fu trattato ingiustamente e condannato, frustato e crocifisso sotto il governo di Ponzio Pilato e il regno di Erode il Tetrarca. Il suo fu un sacrificio in nostro favore per pagare il debito del peccato. Egli dimostrò la sua divinità risorgendo fisicamente dai morti, apparendo a Pietro e agli altri discepoli, mangiando con loro e incoraggiandoli a toccarlo e a costatare di persona tale verità. Gli Apostoli dopo questi fatti divennero impavidi, compresero che la Risurrezione di Gesù era pegno di vita eterna e di risurrezione per tutti quelli che credono nel suo nome. Gesù, salito alla destra del Padre, ora regna in eterno: a Lui appartiene tutta la creazione ed Egli giudicherà i vivi e i morti.
Insomma, tutte queste affermazioni che troviamo nelle pagine dei discepoli degli apostoli ci confermano che la sostanza dei Vangeli a noi giunti è la medesima, al punto che se per ipotesi i Vangeli fossero andati perduti, ne potremmo ricostruire l’essenza dai loro scritti.
Cosa dire però dei dettagli inferiori, come i singoli episodi, parole, eventi, riportati nei Vangeli e che non troviamo negli scritti dei primi Padri?
Innanzitutto dobbiamo tener presente la serietà con cui gli Apostoli intesero l’incarico affidato loro da Gesù di annunciare a tutto il mondo ciò di cui essi stessi furono spettatori. È ragionevole pensare che gli Apostoli abbiano vigilato con cura sui discepoli al fine di garantire la trasmissione fedele e autentica del messaggio evangelico, di ciò che Gesù fece e insegnò, e che tale messaggio fosse da essi trasmesso inalterato. Se all’inizio, vista l’urgenza del loro mandato, la trasmissione degli insegnamenti di Gesù fu orale, è logico pensare che, man mano che passavano i mesi e gli anni, abbiano sentito la necessità di mettere o far mettere per iscritto la loro testimonianza, correggendo eventuali errori o imprecisioni diffusisi nelle comunità loro affidate. E difatti, nelle lettere di san Paolo vediamo quante volte l’Apostolo sia costretto a intervenire per sedare dubbi ed errori e per mettere in guardia da falsi apostoli e profeti.
Ed è logico pensare che i discepoli degli Apostoli abbiano sentito a loro volta tutta la responsabilità di fare altrettanto.
Quanto alla trasmissione scritta, conosciamo la meticolosità con cui la cultura religiosa giudaica del tempo trattava i Testi sacri. Ora, i Vangeli e le Lettere degli Apostoli furono fin da subito ritenuti sacri. Le prime comunità cristiane, sebbene talvolta in rivalità tra loro, non dubitarono mai della paternità dei 4 Vangeli e della loro autorità. Dunque non c’è motivo di dubitare dei copisti, della loro capacità o della loro serietà nel ricopiare il testo. Tanto più che se avessimo avuto delle adulterazioni volontarie certamente avremmo assistito al sollevamento di altre comunità, fosse in Africa piuttosto che in Asia, o in qualche altra parte del mondo. È impensabile che un’adulterazione dei Vangeli fosse accettata da tutti, improvvisamente, senza colpo ferire, senza che alcuno ne parlasse o ne sollevasse questione. Invece, nulla di tutto questo viene riferito negli scritti dei primi secoli. I codici pervenutici a partire dal IV-V secolo e provenienti dalle varie parti del mondo riportano ovunque, sostanzialmente, lo stesso testo.
In conclusione possiamo dire che c’è una catena di custodia dei testi del Nuovo Testamento pienamente affidabile che ci assicura che la testimonianza giunta dagli Apostoli fino a noi è rimasta inalterata.
4° REQUISITO:
LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI
NON È STATA INFICIATA DA ALTRI FINI SECONDARI
Una volta provata l’attendibilità della testimonianza e il fatto che essa è giunta inalterata fino a noi, rimane un’ultima domanda a cui rispondere: i testimoni hanno agito per qualche altro fine secondario che abbia potuto inficiare la loro testimonianza?
Tutte le bugie criminali che si consumano nel mondo possono essere, in ultima analisi, ricondotte a tre: soldi, sesso, potere/onore. Vediamo se gli Apostoli possono essere stati mossi da uno di questi tre motivi.
Dai Vangeli sappiamo che gli Apostoli lasciarono casa, famiglia, averi, per seguire Gesù. Lasciarono tutto senza avere “dove posare il capo”, spigolando a volte il cibo lungo la via per la fame. Anche dopo la Risurrezione di Gesù la loro vita fu povera. Basta ricordare l’episodio del paralitico presso la porta del Tempio che alzava la mano in cerca di elemosina e a cui Pietro rispose: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» (At 3,6). San Paolo più volte nelle sue lettere lascia intendere la sua penuria. Nella prima Lettera ai Corinzi scrive: «Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo» (1Cor 4,11).
Se gli Apostoli avessero mentito per avere soldi, possiamo dire che le loro bugie non funzionarono affatto. Tutti coloro che li osservavano li vedevano dediti alla vita spirituale e non al guadagno materiale: «“Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani” [...]. Tutti scoppiarono in un gran pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto» (At 20,33-38).
Gli Apostoli mai si descrissero come ricchi, al contrario, misero in guardia dal pericolo della ricchezza che può portare alla rovina eterna. San Giacomo nella sua Lettera scrive: «Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano?».
Anche le testimonianze extra bibliche degli Apostoli ce li mostrano amanti della povertà, contenti di non possedere nulla in questo mondo. Quindi, è da escludere che uno scopo finanziario inquinasse le loro testimonianze.
In pari tempo, è ugualmente irragionevole che essi abbiano avuto un fine carnale. Infatti, per seguire Gesù gli Apostoli non solo lasciarono i soldi e gli averi, ma anche le proprie legittime mogli e i propri figli, fatta eccezione per Giovanni che non era sposato. Essi vissero irreprensibili davanti alle comunità che li ospitavano, insegnando la necessità della purezza e dell’osservanza dei Comandamenti di Dio. E comunque sia, non si vede come una tale motivazione potesse spingere gli Apostoli ad inquinare la propria testimonianza riguardo la vita e le opere di Cristo.
Riguardo all’accusa della possibile ricerca di potere da parte degli Apostoli, nel dare la loro testimonianza evangelica, non se ne riesce a vedere la ragione, dal momento che la loro condizione sociale nel tempo in cui vissero non vide alcun miglioramento. Avere un posto di responsabilità nella chiesa dei primi secoli equivaleva al martirio, e non certo a un onore in senso umano. Bisogna tener poi presente che il potere è ambìto quando procura dei vantaggi, ma la posizione degli Apostoli li rese ancor più bersagliati e perseguitati (sia dal potere religioso che da quello civile). La narrazione del loro martirio, custodita nei martirologi, nelle tradizioni locali lì dove furono martirizzati, nei racconti di chi ce li ha tramandati, ci parla di atroci sofferenze e torture. Solo san Giovanni evangelista fu risparmiato dalla morte cruenta, ma dovette comunque subire l’esilio. San Paolo nella seconda Lettera ai Corinzi fa un elenco di quello che subì a causa della predicazione del Vangelo: «Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove colpi; tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese» (2Cor 11,24-28).
Insomma, dalla diffusione del Vangelo, gli Apostoli non hanno ricevuto né soldi, né piaceri, né potere; semmai al contrario, povertà, mortificazioni, derisioni, umiliazioni, sofferenze senza numero e per ultimo il martirio. Quindi possiamo ragionevolmente ammettere che, mentre stendevano le loro testimonianze, non erano affatto mossi o influenzati da nessuno dei precedenti motivi.
Ma che cosa dire dei pregiudizi? Alcuni, infatti, obiettano che: sì, gli Apostoli non avevano motivi secondari come i soldi, il sesso o il successo, per diffondere il Vangelo; ma erano cristiani, e questo basta per dire che la loro testimonianza era influenzata dal loro credo.
È naturalmente un’obiezione sciocca. Gli Apostoli erano ebrei prima di diventare cristiani e diventarono cristiani solo quando, dopo aver osservato Gesù e i segni che Egli ha compiuto, non ultimo la Risurrezione, si sono convinti della bontà e veracità della sua persona: che Egli cioè era davvero il Figlio di Dio come diceva di essere. Quanto al fatto che l’attesa degli ebrei nei confronti del Messia fosse stata all’origine della suggestione degli Apostoli e del loro errore di giudizio, basti pensare che il Messia atteso nella Giudea era di tutt’altro genere: un liberatore politico, un dominatore di popoli, un capo militare. Sicuramente non si aspettavano un Messia crocifisso e ucciso come un qualsiasi criminale, per di più condannato dai sommi sacerdoti e dalle guide religiose del popolo come un bestemmiatore. Nemmeno la Risurrezione dai morti era contemplata tra le loro attese. Difatti, i Vangeli trovarono non pochi ostacoli presso gli ebrei, e gli stessi Apostoli mostrarono più volte dubbi ed esitazioni nei suoi confronti, mentre era ancora in vita. San Tommaso ad esempio non volle credere alla Risurrezione di Gesù nemmeno dopo aver ascoltato la testimonianza dei suoi amici più intimi, dopo aver sperimentato per tre anni i miracoli da Lui compiuti e udito le sue predizioni a riguardo.
Gli Apostoli e i discepoli di Gesù divennero cristiani solo dopo aver fatto le proprie osservazioni, riflessioni e aver concluso che Gesù era davvero il Messia, il Figlio di Dio, il Vivente come Egli stesso affermava di essere. Solo da quel momento iniziarono a predicare e ad annunciare a tutto il mondo ciò che essi per primi avevano visto: «Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo» (1Gv 1-3).
A conclusione della nostra analisi forense possiamo dunque dire che:
1) i Vangeli riportano testimonianze oculari;
2) la loro testimonianza è confermata da diverse prove interne ed esterne;
3) la catena di trasmissione è stata accurata e sicura;
4) la loro testimonianza, infine, è stata imparziale, ossia non inficiata da secondi fini o pregiudizi.
Dunque, la loro testimonianza è pienamente credibile e degna di fede. Non possiamo ragionevolmente rifiutarla soltanto perché ciò che racconta è qualcosa di incredibile.
Gesù è davvero esistito, ha davvero operato cose mirabili, è davvero morto, risorto, portando a compimento tutte le profezie antiche: Egli è il Vivente, il Figlio di Dio incarnato e «beati quelli che pur non avendo visto crederanno!» (Gv 20,29).
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale