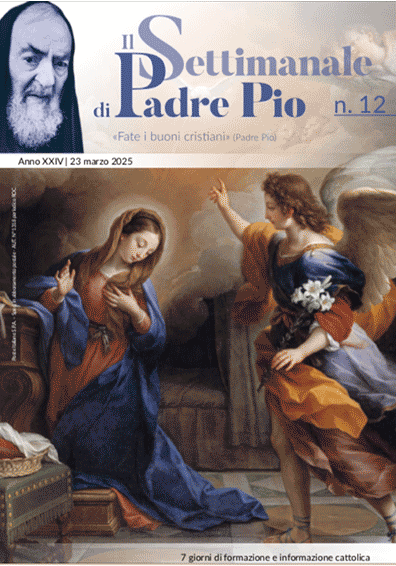Guai a chi si scandalizza di Gesù Cristo e non si scandalizza del male
dal Numero 20 del 17 maggio 2020
di Fra’ Pietro Pio M. Pedalino
È oggi più che mai importante affrontare il tema dello “scandalo” in entrambe le sue direzioni. Esiste infatti anche una “sonnolenza” che impedisce ai discepoli di Cristo di scandalizzarsi di fronte al peccato. Essa rimane nel corso dei secoli l’occasione favorevole per il potere del male.

Guai a chi si scandalizza di Gesù Cristo
Gesù è apparso come un segno di contraddizione: pur essendo stato mandato per la salvezza di tutti, di fatto è occasione di indurimento per molti: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione» (Lc 2,34). Nella persona di Gesù e nella sua vita tutto costituisce scandalo:
- è il figlio del falegname di Nazareth (cf. Mt 13,57);
- rifiuta il messianismo vendicatore (cf. Mt 11,2-5; cf. Gv 3,17), così come il messianismo politico (Gv 6,15);
- si incammina verso il suo destino di passione e di croce (cf. Mt 16,21).
Perfino molti discepoli si oppongono a lui come Satana (cf. Mt 6,22-23) e, scandalizzati, abbandonano il loro Maestro (cf. Gv 6,66). Ma Gesù risorto li raduna (cf. Mt 26,31-32).
L’evangelista Giovanni mette in rilievo il carattere scandaloso del Vangelo: Gesù è in tutto un uomo simile agli altri (cf. Gv 1,14), del Quale si pensa di conoscere l’origine (cf. Gv 1,46; 6,42; 7,27) e del Quale non si può comprendere il disegno redentore mediante la Croce (cf. Gv 6,52) e mediante l’ascensione (cf. Gv 6,62). Gli uditori inciampano tutti nella rivelazione del triplice mistero dell’Incarnazione, della Redenzione e dell’Ascensione; ma i discepoli sono rialzati da Gesù, mentre altri si ostinano e il loro peccato è senza scusa (cf. Gv 15,22-24).
Presentandosi agli uomini, Gesù li ha posti in condizione di optare per Lui o contro di Lui: «Beato è colui che non trova in me motivo di scandalo» (Mt 11,6; Lc 7,23). La comunità apostolica ha quindi applicato a Gesù in persona l’oracolo di Isaia 8,14 che si riferiva a Dio: Gesù è la “pietra di scandalo” e nello stesso tempo “la pietra d’angolo” (cf. 1Pt 2,7-8; Rm 9,32-33; Mt 21,42); Cristo è, ad un tempo, per gli uni fonte di vita e per gli altri causa di morte (cf. 2Cor 2,16).
San Paolo ha dovuto affrontare lo scandalo generato da Cristo sia nel mondo greco che nel mondo giudaico, cosa di cui peraltro aveva fatto egli stesso esperienza prima della sua conversione. Per l’Apostolo delle Genti Cristo – e in particolare la sua Croce – è «stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio» (1Cor 1,18). Cristo crocifisso è «scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani» (1Cor 1,23). La sapienza umana non può comprendere che Dio voglia salvare il mondo per mezzo di un Messia umiliato, sofferente, crocifisso. Soltanto lo Spirito di Dio permette all’uomo di superare lo scandalo della Croce – o meglio – di riconoscervi la suprema sapienza (cf. 1Cor 1,25; 2,11-16).
Lo stesso scandalo, la stessa prova della fede continuano attraverso tutta la storia della Chiesa. La Chiesa è sempre nel mondo un segno di contraddizione, e l’odio, la persecuzione sono per molti un’occasione di caduta (cf. Mt 13,21; 24,10), benché Gesù abbia annunciato tale realtà affinché i suoi discepoli non soccombano davanti ad essa (cf. Gv 16,1).
Guai a chi non si scandalizza del male
Ma esiste un’altra modalità, un altro profilo complementare a quello cristologico sotto il quale considerare lo scandalo.
Se lo scandalizzatore merita il severo “guai!” del divin Maestro – «Guai al mondo per gli scandali! È necessario che succedano scandali; ma guai a colui per colpa del quale avviene lo scandalo» (Mt 18,6-7) – per la gravità del fatto stesso di attentare alla vita di grazia nell’anima di un fratello o di una sorella, commettendo peccato e inducendo altri a cadere nei lacci di Satana, si può considerare anche un altro aspetto dello scandalo, quasi ribaltando il punto di vista adottato dal Signore. Potremmo dire: “guai” a chi non si scandalizza; “beato” è, invece, colui che si scandalizza. In che senso? È presto spiegato.
Lo scandalo etimologicamente significa “ostacolo” e consiste in una parola, azione o fatto che offende o turba la coscienza altrui. È sempre un male che induce al male. Quindi chi assiste ad uno scandalo, in un certo senso, ha il dovere di scandalizzarsi perché se non si scandalizzasse non considererebbe il male quale esso è veramente, qualcosa di malvagio che si oppone alla norma morale e alla volontà del supremo Legislatore.
Chi non si scandalizza davanti al male ha una coscienza erronea, deformata, che non gli permette di vedere il male nel male e di indignarsi per esso. L’incapacità di scandalizzarsi del male pone nell’impossibilità di convertirsi perché se esso è accettato come qualcosa di innocuo che non ferisce, non dispiace, come si farà a rifuggirlo attaccandosi al bene che è l’aspetto fondamentale di ogni vita morale? Guai a chi commette gli scandali dunque, sì, guai severi da parte di Gesù; ma anche guai a coloro che, inebetiti dal dilagare del male, stravolti e disorientati dal turpe fango morale presente ovunque, non sono più capaci di scandalizzarsi di esso.
Senza scandalizzarsi del male, d’altra parte, è impossibile anche ogni riscossa controrivoluzionaria. Solo in chi si scandalizza del male si genera interiormente quell’energia per contrastarlo. Diceva sant’Agostino: «La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle». Coraggio dunque, certo, ma preceduto ed alimentato dalla santa indignazione che spinge a cambiare le cose.
Senza indignazione per il male la vita cristiana (sia dal punto di vista del proprio progresso spirituale che dal punto di vista della riscossa controrivoluzionaria nel mondo) sarebbe atona, flemmatica. Chiediamo, perciò, a Dio di darci sempre la grazia di scandalizzarci del male instillando in noi una santa indignazione per poterlo contrastare con energia.
L’emblema dell’uomo apatico davanti al turpe oceano di male in cui il mondo affoga lo troviamo nei tre Apostoli che, durante l’agonia di Gesù nel Getsemani – l’ora del male per antonomasia, l’ora del peccato supremo –, anziché vegliare e pregare come comandato dal Maestro si addormentano. Guai a quel sonno dei buoni per il quale il male può avanzare nel mondo! Guai a quella tiepidezza spirituale che non pone frontiera all’azione diabolica! Scriveva Benedetto XVI nel secondo volume della trilogia Gesù di Nazareth: «La sonnolenza dei discepoli rimane nel corso dei secoli l’occasione favorevole per il potere del male. Questa sonnolenza è un intorpidimento dell’anima che non si lascia scuotere dal potere del male nel mondo [...], è una insensibilità che [...] si tranquillizza col pensiero che tutto, in fondo, non è poi tanto grave, per poter così continuare nell’autocompiacimento della propria esistenza soddisfatta. Ma questa insensibilità delle anime, questa mancanza di vigilanza [...] conferisce al Maligno un potere nel mondo» (1).
E nell’Udienza generale del Mercoledì Santo 20 aprile 2011, con ulteriori pennellate, perfezionava questo importante concetto, spiegando che quello della sonnolenza dei tre Apostoli nel Getsemani «è un messaggio permanente per tutti i tempi [...], è il problema di tutta la storia. La questione è in che cosa consiste questa sonnolenza, in che cosa consisterebbe la vigilanza alla quale il Signore ci invita. Direi che la sonnolenza dei discepoli lungo la storia è una certa insensibilità dell’anima per il potere del male, un’insensibilità per tutto il male del mondo. Noi non vogliamo lasciarci turbare troppo da queste cose, vogliamo dimenticarle: pensiamo che forse non sarà così grave, e dimentichiamo. E non è soltanto insensibilità per il male, mentre dovremmo vegliare per fare il bene, per lottare per la forza del bene. È insensibilità per Dio: questa è la nostra vera sonnolenza; questa insensibilità per la presenza di Dio che ci rende insensibili anche per il male. Non sentiamo Dio – ci disturberebbe – e così non sentiamo, naturalmente, anche la forza del male e rimaniamo sulla strada della nostra comodità», e invitava a «riflettere sulla sonnolenza dei discepoli, dei difensori di Gesù, degli apostoli, di noi, che non vediamo, non vogliamo vedere tutta la forza del male, e che non vogliamo entrare nella sua passione per il bene, per la presenza di Dio nel mondo, per l’amore del prossimo e di Dio» (2).
Se, al contrario, i discepoli del Signore non dormono ma vegliano non potranno fare a meno di scandalizzarsi del male. Ma nessuna paura: è proprio da qui che prende inizio quella battaglia spirituale e sociale per il trionfo del regno di Dio su quello di Satana. Noi tutti, in essa, giochiamo il nostro ruolo. Almeno noi non tiriamoci indietro.
NOTE
1) Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, LEV, Città del Vaticano 2011, pp. 172-173.
2) Idem, Udienza generale, Piazza San Pietro, mercoledì 20 aprile 2011.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale