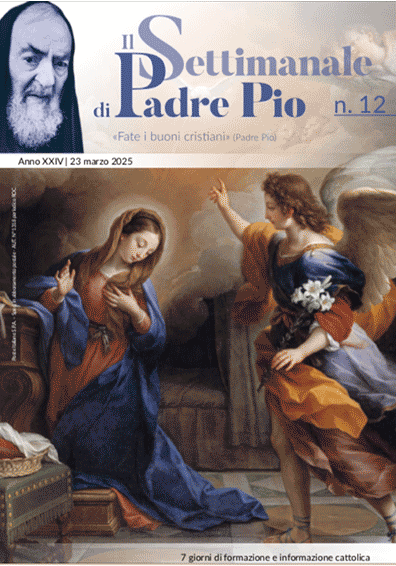La Vittoria di Cristo su pentagramma. “Emmaus” di Carissimi
dal Numero 15 del 12 aprile 2020
di Massimo Scapin
Le voci dei solisti e del coro si intrecciano dolcemente nell’Oratorio di Giacomo Carissimi, dall’intenso afflato spirituale, che in meno di 13 minuti fa rivivere il felice incontro avuto dai pellegrini di Emmaus.
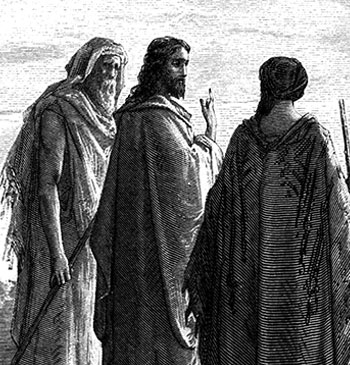
Durante il tempo pasquale tutta la liturgia canta la certezza e la gioia della Risurrezione del Cristo. Siamo invitati a un incontro personale con il Risorto e a riconoscerne l’agire negli eventi storici e nel nostro quotidiano. Spesso, ad esempio, ci viene riproposto il celebre racconto evangelico detto dei discepoli di Emmaus (cf. Lc 24,13-35). Artisti di tutti i tempi lo hanno rappresentato; per esempio, la Historia dei Pellegrini di Emmaus di Giacomo Carissimi (1605-1674) è il breve – dura meno di 13 minuti – oratorio per due soprani, tenore, coro e basso continuo, composto per il tempo di Pasqua dal padre dell’oratorio barocco per descrivere questo episodio commovente.
«Duo ex discipulis Iesus ibant in castellum nomine Emmaus», canta l’Historicus II (tenore) all’inizio, narrando come due discepoli di Cristo fossero diretti al villaggio di Emmaus, a circa undici chilometri da Gerusalemme. Un coro a tre voci subito interviene teneramente: «Ite felices, ite beati» (Andate felici, andate beati); e interrompe la loro afflizione per la tragedia del Venerdì Santo. «Et factum est dum loquerentur de his omnibus quae acciderant, ipse Iesus appropinquans ibat cum illis», canta l’Historicus I (soprano) per raccontare che mentre i due viandanti parlano e discutono, Gesù – che essi però non riconoscono – si accosta al loro cammino. «O stulti et tardi corde ad credendum! Nonne haec oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam suam?», canta Cristo (baritono) rimproverandoli come non abbiano potuto capire che il Messia doveva soffrire queste cose prima di entrare nella sua gloria. A commento, il coro – quasi il cielo al tramonto – ripete il suo canto: «Ite felices, ite beati». E l’Historicus I riprende la narrazione dicendo che Gesù spiegò ai due discepoli i passi della Bibbia che lo riguardavano: «Cum igitur Iesus interpretaretur discipulis in omnibus Scripturis quae de ipso erant...».
Il racconto riprende per dire come, arrivati al villaggio dove erano diretti, Gesù finge di continuare il viaggio. Ma i due discepoli, in un delicato passo a due voci, affettuosamente lo trattengono perché «expirat iam dies, et umbrae inclinantur», il giorno è ormai al tramonto e le ombre stanno calando. Gesù entra nel villaggio, racconta l’Historicus II; messosi a tavola con loro, spezza il pane e sparisce dalla loro vista.
I due, adesso che hanno aperto gli occhi e hanno riconosciuto Gesù, si dicono a vicenda come sentissero ardere in petto il cuore quando egli era con loro. «Eamus», andiamo, si dicono l’un l’altro, e – quasi volendo rischiarare le prime ombre della notte – inneggiano alla gloria del Risorto. L’oratorio si chiude con tutto il coro che ripete quell’invito, in modo ampio e ritmato: «Eamus, surgamus, canendo dicamus: “O Christi victoria, o triumphalis, o immortalis resurgentis gloria”», andiamo, sorgiamo, cantiamo la vittoria di Cristo, la gloria immortale del Risorto.
Sappiamo che, dopo la Risurrezione, Gesù è apparso alle pie donne e poi agli Apostoli, prima a Pietro e poi ai Dodici. «Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni» (Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone) è il grido della comunità; un’esclamazione che si fonda sulla testimonianza di Pietro, il quale, avuto il mandato di confermare, dopo l’ora della debolezza, la fede dei suoi fratelli, vede il Risorto prima di loro. In memoria di questa apparizione a Pietro, a Roma nel Medioevo la «Pasquetta» aveva una dimensione molto petrina; il successore di Pietro celebrava la Messa stazionale nella Basilica Vaticana (Feria II infra octavam Paschae. Statio ad sanctum Petrum) e poi andava in processione verso il Laterano. Eccone l’eloquente descrizione del cardinal Schuster: «A ricordare il simbolismo di questa prima apparizione a Pietro, oggi nel medio evo il Pontefice si recava con solenne corteo nella tomba dell’Apostolo. In quei secoli, non era infrequente che per la festa di Pasqua si trovassero a Roma l’imperatore o altri principi e re e gli storici ordinariamente ci descrivono che in tale occasione questi sovrani, in atto di devota sudditanza, reggevano al Papa la staffa e tenevano le briglie del suo destriero. Dopo la Messa, il Pontefice cingeva la tiara e ritornava trionfalmente in Laterano; ed al popolo accalcato lungo le vie faceva larghe distribuzioni di denaro. Passato appena il ponte Adriano, veniva acclamato anche dai rappresentanti della colonia israelitica in Roma, i quali in premio dimandavano la protezione pontificia pel loro popolo. Il Papa faceva distribuire del denaro anche a loro, promettendo agli Ebrei giustizia e difesa contro tutti i soprusi. La processione arrestatasi per brevi istanti ad accogliere le suppliche degli Israeliti, riprendeva indi il suo cammino alla volta del Laterano; il corteo saliva dapprima il Campidoglio, indi discendeva al Foro pel clivio Argentario, passava sotto gli Archi trionfali di Settimio Severo e di Tito, alla Meta Sudante lasciava a sinistra l’Arco di Costantino, e volgendosi verso il Colosso di Nerone, imboccava la via “Santa” che diretta conduceva al Laterano. Lo spettacolo di quella pompa religiosa attraverso le rovine della grandezza di Roma imperiale doveva essere indescrivibile. Il Pontefice incoronato, il cui cavallo era tenuto a briglia dalle più auguste autorità della terra; lo stuolo numeroso di vescovi e cardinali che nei loro solenni ammanti sacerdotali facevano corona al Papa; i chierici inferiori i quali man mano che il Pontefice passava innanzi le varie chiese della città, gli uscivano festosamente incontro agitando nuvole profumate d’incenso; il fitto popolo che s’accalcava lungo le vie, dovevano pur ricordare ai presenti la profezia di Daniele, del sassolino staccatosi dalla montagna, che avrebbe stritolato i regni più colossali, fondando un impero che sarebbe eterno. E dopo questa marcia trionfale, quale canto appropriato alla circostanza, di quello che eseguivano i cantori innanzi alle porte del patriarchio, mentre il Papa discendeva dal suo palafreno: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat»(1).
Se ci rattrista che il lieto annunzio Surrexit Dominus vere! et apparuit Simoni ancora non raggiunga tutti gli uomini, ci consola l’Historia dei Pellegrini di Emmaus di Carissimi.
NOTA
1) I. Schuster, Liber Sacramentorum. 4, Il battesimo nello Spirito e nel fuoco. La Sacra Liturgia durante il ciclo Pasquale, Marietti 1930, pp. 81-82.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale