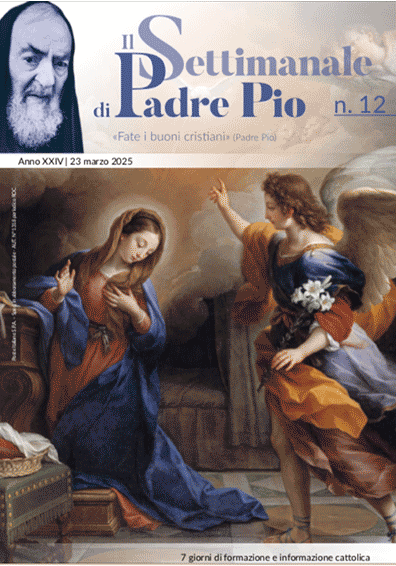Halloween e il fascino dell’occulto
dal Numero 42 del 27 ottobre 2019
di Lazzaro M. Celli
Spesso bambini e ragazzi si avvicinano al mondo dell’occulto per gioco o per curiosità. L’insufficiente istruzione religiosa e la sconfinata libertà di cui godono fanno il resto e così si trovano intrappolati in un mondo oscuro che non sanno combattere e che procura loro ferite permanenti.

La moda di Halloween è senza dubbio legata al tentativo di diffondere il genere horror anche tra un pubblico di giovani e di bambini. Essa ha lo scopo particolare di pacificare il mondo dell’infanzia con la magia, distinta erroneamente in buona e cattiva, bianca e nera. Pertanto, mira ad allargare la platea di estimatori usando uno schema strategico vecchio quanto l’uomo: eliminare dalla festa del 31 ottobre ogni aspetto che possa generare repulsione per l’esplicito collegamento al mondo del male.
Ciò che crea una naturale ripugnanza deve apparire, al contrario, accattivante, innocente, innocuo, solo un gioco e, in tal modo, la strategia in atto risulterà vincente, conquistando il mondo dei minori.
Una volta carpita la simpatia per questo genere di feste, si passa allo stadio successivo: quello della propaganda, anche esplicita, quando si abbassa la soglia di difesa. A tal fine, i media costituiscono uno strumento efficacissimo perché tutto ciò che trasmettono scatena un effetto emulativo. Non è raro che siano mandate in onda interviste ad artisti che s’ispirano al maligno, o si offrano serie televisive i cui protagonisti pratichino la magia, come ad esempio la saga di Halloween – La notte delle streghe –, una delle pellicole del genere horror uscita già nel 1978.
La moda di Halloween, e più in generale dell’occulto, non dipende solo da variabili di tipo ambientale, come l’influenza esercitata dall’esterno sull’uomo, ma anche dall’aspetto psicologico-individuale e psicosociale-comportamentale.
Nel primo caso assume un ruolo rilevante la curiosità. L’uomo, per sua natura, tende a conoscere, ma senza una guida morale che lo aiuti a distinguere il bene dal male, l’inclinazione umana alla conoscenza può risultare pericolosa. Se poi ad essa si accompagna anche una concezione della libertà intesa come assenza di regole, il rischio di essere risucchiati dal fascino delle pratiche magiche aumenta in modo esponenziale.
Si accende, così, l’elemento trasgressivo, la cui punta massima coincide soprattutto con il periodo adolescenziale, in cui la regola «deve» essere infranta. La trasgressione può giungere fino al punto da considerare il demonio come una presenza positiva, che aiuta a star meglio e a raggiungere il successo. Non sono rari i casi di giovani che si danno alle pratiche magiche per acquisire denaro e potere. Quando, però, passa la fase adolescenziale e si acquisisce una maggiore maturità, restano le ferite profonde, prodotte da scelte sbagliate, che disgregano la personalità, segnandola negativamente.
Alla costruzione di uno status symbol positivo del demonio ha senz’altro contribuito l’industria del divertimento, invadendo ogni angolo dell’anima dei giovani, con canzoni, videogames, film e libri inneggianti all’occulto. Non è raro, infatti, il caso in cui i giovani si avvicinano all’occulto per gioco o anche per noia.
A questi motivi bisogna aggiungere lo stato di fragilità delle nuove generazioni che vivono il domani con paura, ansia, incertezza. In questi casi il ricorso all’occulto racchiude il tentativo di dominare il futuro, gestirlo, propiziarlo.
Ultimo motivo, ma non meno importante, è lo svilimento pubblico della funzione spirituale della Chiesa Cattolica. Oggi non c’è quasi più fiducia nel suo ruolo, spesso perché non si ha più fiducia nel ruolo degli uomini di Chiesa. Bisogna, però, distinguere necessariamente due cose. Se gli uomini di Chiesa sbagliano, non ha sbagliato l’unico modello che dobbiamo imitare: Nostro Signore Gesù Cristo. E non ha sbagliato l’Immacolata, Colei che più perfettamente l’ha imitato.
Invero, l’apostolo san Pietro così scrive: «..Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme...».
Purtroppo oggi la risposta di molti uomini di Chiesa, invece di consistere nel presentare il fascino della vita cristiana radicalmente vissuta, come il Concilio Vaticano II chiedeva, propone un nuovo umanesimo che si traduce in un compromesso con la mentalità del mondo. Solo un ritorno ad una condotta di vita radicale può costituire la risposta personale valida per fermare la crisi degenerativa a cui è sottoposta la società odierna e la stessa Chiesa Cattolica.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale