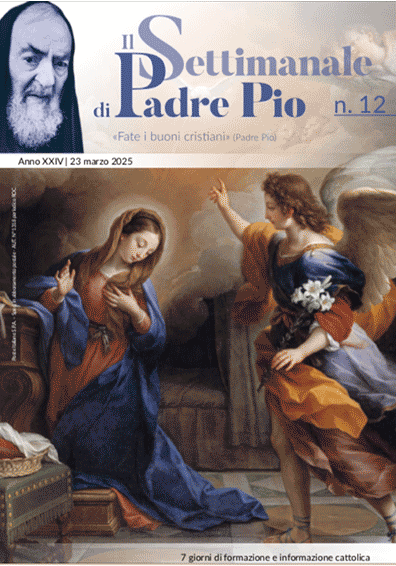“Ne la presenza del soldan superba predicò Cristo”
dal Numero 34 del 1 settembre 2019
di Carlo Codega
Tratte dal canto XI del “Paradiso”, le parole del Sommo Poeta ben esprimono l’intento che animò san Francesco nell’incontro col Sultano. L’ottavo centenario di questa visita stimola a un ripasso di storia che illumini le circostanze di questo viaggio alla luce delle fonti originarie a nostra disposizione.
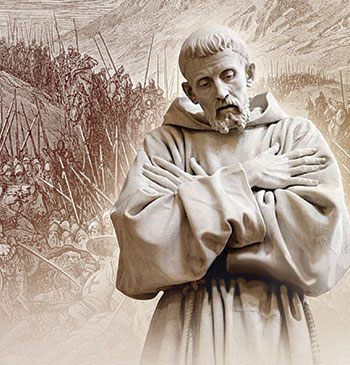
Gli 800 anni della visita di san Francesco al sultano
Non è certo una novità che, nel corso dei tempi, le figure di personaggi realmente esistiti vengano travisate e manipolate dai posteri, desiderosi di cogliere negli esempi passati delle giustificazioni per i loro errori presenti. Si può anzi dire che il Novecento, soprattutto nei totalitarismi, ha applicato con sistematicità scientifica questo schema di rilettura delle vicende e dei personaggi storici. Non è una novità nemmeno che persino i santi – anzi lo stesso Verbo Incarnato – siano stati “riletti” e “rivisitati” per appoggiare su di loro le prospettive teologiche, politiche o ideologiche più disparate. Non è tutto sommato lontana l’epoca in cui Cristo era diventato in qualche mente fantasiosa il primo socialista, il primo rivoluzionario o il primo sessantottino della storia. È invece una novità fastidiosa e inaccettabile che la rilettura di un personaggio lo conduca tanto lontano dalla realtà storica sino al punto che nella mentalità comune esso sia ormai divenuto quasi l’opposto di quello che fu veramente. Per sciogliere il riserbo chiariamo che stiamo parlando di san Francesco d’Assisi: colui che nella considerazione comune è divenuto riduttivamente il Santo della pace e dell’amore che, con gli uccellini che si posano tra le mani, ci ricorda la bellezza della natura.
La leggenda rosa, quella verde e quella arcobaleno
Siamo pronti persino a dare a san Francesco i titoli – peraltro piuttosto approssimativi – di Santo della pace, dell’amore e della natura, a patto che la pace non si identifichi con il pacifismo, l’amore con il sentimentalismo e la natura con l’ambientalismo, ideologie o tendenze molto lontane dal termine da cui in realtà prendono il nome. La vera pace, infatti, non è il pacifismo in quanto non esclude radicalmente la guerra, ma la ammette come mezzo per conservare o riportare la vera pace, cioè la tranquillità dell’ordine. Il vero amore non è un sentimento invertebrato ma ha una solida colonna che è la verità, sulla quale si fonda e dalla quale deriva, in quanto l’amore vero è quello della volontà che, istruita dall’intelletto, ama ciò che è buono e odia ciò che è cattivo, cosa inaccettabile per il vano sentimentalismo. La natura poi – in una retta considerazione cristiana – non è certo un ente divino e personale (Madre Natura), e nemmeno è un fine in se stesso, bensì è un mezzo che Dio ci ha dato per sopravvivere e per scovare nelle sue bellezze le tracce (vestigia come le chiamava san Bonaventura) dell’opera del Creatore.
Non intendiamo trattare in tutta la sua larghezza il problema di questa leggenda rosa (sentimentalismo), verde (ambientalismo) o arcobaleno (pacifismo e, perché no, anche un po’ di omosessualismo) di san Francesco, ma mostrare come la deformazione con cui la “cultura” attuale legge la figura di san Francesco d’Assisi – un po’ pacifista, un po’ ambientalista, un po’ carismatico pre-protestante – sia in realtà apertamente smentita dalle stesse fonti storiche almeno su un punto – ma non dubitiamo anche sugli altri – ovvero quello del suo presunto indifferentismo o latitudinarismo religioso. In tale visione san Francesco sarebbe stato il primo non solo ad aprire la strada al protestantesimo staccandosi dalla Chiesa gerarchica troppo ricca e “istituzionale” in cui il suo senso religioso carismatico soffocava, ma anche il primo a relativizzare la verità cristiana comprendendo come anche tutte le altre religioni siano buone e valide. In questo senso per molti san Francesco sarebbe un paladino dell’attuale ecumenismo o dialogo interreligioso in quanto sarebbe stato il primo a condannare le Crociate e muoversi invece pacificamente e disarmato verso il sultano, senza peraltro alcuna intenzione di convertirlo ma solo di dialogare con lui alla pari. In questa visita di san Francesco al sultano anzi si vuole addirittura vedere la prova di come la Chiesa Cattolica debba rinunciare a convincere gli altri della verità della Rivelazione divina ma, spogliata di tutto e persino delle sue certezze, si debba dirigere verso gli altri in spirito di umiltà, a testimoniare la vicinanza al profondo significato umano che esprime ogni religione. Che si vogliano sostenere tali sciocchezze è già un’aberrazione fastidiosa, ma che poi ci si voglia appoggiare su san Francesco è una provocazione ancora più fastidiosa, che è necessario correggere – fonti storiche alla mano – ancor più considerando come proprio quest’anno ricorrano gli ottocento anni dalla visita del Poverello di Assisi al sultano e come tale anniversario abbia avuto una grande risonanza nella cronaca, in seguito alla visita di papa Francesco negli Emirati arabi.
San Francesco verso la Terra Santa
Procediamo però con ordine. Siamo nel 1219 quando per la terza volta san Francesco cerca di raggiungere i paesi musulmani, dopo due tentativi andati a vuoto per disposizione divina, il primo tramite un naufragio sulle coste balcaniche (Fonti Francescane, n. 1171) e il secondo grazie a una malattia che interruppe in Spagna il suo peregrinare a piedi verso il Marocco. Questa volta invece san Francesco, accompagnato da fra’ Illuminato da Rieti, riuscì a recarsi in Siria.
Va innanzitutto sottolineato che in questa occasione, come nelle altre due precedenti, il motivo del suo viaggio nel Vicino Oriente non è direttamente legato alla Crociata che si combatteva (la cosiddetta “quinta” secondo il calcolo tradizionale), bensì sollecitata da altri motivi. Innanzitutto – come dice Dante – «per la sete del martirio» (cf. Paradiso, canto XI, v. 100), che san Francesco considerava la più degna sorte possibile per un frate minore, tanto che solo quando il suo Ordine ebbe i primi martiri (i Protomartiri francescani del 1220 in Marocco), poté vantarsi dicendo: «Ora posso dire che ho veramente cinque Frati Minori» (Wadding, Annales Minorum, n. 38)).
In secondo luogo il viaggio era motivato dal desiderio di convertire gli infedeli musulmani con le parole, se avessero creduto, o altrimenti con la testimonianza del martirio: «Per diffondere, con l’effusione del proprio sangue, la fede nella Trinità» (FF 1172), spiega san Bonaventura, indicando con precisione proprio il dogma di Fede più oltraggiato dagli islamici. Dunque non c’era alcun legame tra il viaggio del Santo e la Crociata che stava nel suo momento più delicato? Se non lo si può affermare con certezza, non sembra tuttavia nemmeno opportuno negarlo, soprattutto se consideriamo che in quel momento la Crociata si stava combattendo non nella Terra Santa stessa ma in Egitto e proprio lì andò a capitare il nostro Santo, non certo per caso. È vero che i cristiani in quel momento erano banditi dalla Terra Santa – anzi il sultano con un editto crudele aveva stabilito che chi gli avesse portato la testa di un cristiano avrebbe guadagnato un bisante d’oro – ma è anche vero che per i suoi scopi il Santo di Assisi avrebbe potuto puntare direttamente lì anziché recarsi in Egitto. San Francesco ben conosceva il mondo dei cavalieri e l’ideale della Crociata e non va dimenticato che prima di comprendere a cosa Iddio lo chiamasse egli stesso avrebbe voluto arruolarsi tra i Crociati che Gualtieri da Brienne radunava in Puglia per la Quarta Crociata. Tra i seguaci di san Francesco contiamo dei cavalieri, così come tra i suoi devoti più fedeli e l’immaginario medievale dei cavalieri risuona abbondantemente nelle parole del Santo di Assisi, che paragonava i suoi frati ai «cavalieri della Tavola Rotonda» (FF 1624). Tutto questo lo si dice non solo per spiegare perché probabilmente la presenza di san Francesco presso l’accampamento crociato durante l’assedio di Damietta non fosse casuale, ma anche per mostrare come sia ridicolo attribuire al Santo di Assisi un’opposizione preconcetta verso le Crociate, la quale non risulta da alcun suo scritto o parola, che anzi testimoniano il contrario.
San Francesco e la Quinta Crociata
San Francesco, come ogni altro cristiano di allora, avrebbe voluto che le Crociate avessero un esito favorevole alla Cristianità medievale, liberando la Terra Santa e allontanandovi i musulmani che, a più riprese, avevano impedito pellegrinaggi o imposto vessazioni ai cristiani. Tale affermazione non teme smentita e nemmeno la nota vicenda avvenuta all’accampamento di Damietta dimostra il contrario. Come ben si sa, alla vigilia di un attacco importante, il Santo – ispirato da Dio – ebbe certezza dell’esito sfavorevole ai cristiani dello scontro che si approntava, per questo – spinto anche da fra’ Illuminato – «affronta, pieno di slancio, i crociati con ammonizioni salutari, proibisce di attaccare, preannuncia la disfatta» (Fonti Francescane, n. 1190). Purtroppo però il Santo non venne creduto, cosicché l’esercito cristiano l’indomani avrebbe subito una solenne sconfitta, con molte perdite (600.000 tra morti e prigionieri, ci informa san Bonaventura). Leggere in questo tentativo di san Francesco un’opposizione alla Crociata è più che fantasioso, alla luce anche di una semplice constatazione: se il Santo di Assisi avesse voluto la fine delle Crociate avrebbe favorito la sconfitta dell’esercito cristiano piuttosto che cercare di evitarla! San Francesco non si oppose né alla Crociata né alla guerra in sé ma cercò, in quell’occasione, di evitare la morte di molti cristiani. Quale fosse il motivo per evitare lo scontro non lo sappiamo, e forse non lo sapeva nemmeno san Francesco dato che la rivelazione divina lo spingeva a evitare l’attacco crociato piuttosto che a dare altre motivazioni. Si possono fare varie ipotesi su tale motivo contingente o anche pensare che fosse volontà di Dio punire l’esercito cristiano per aver troppo contaminato il puro ideale crociato con calcoli e finalità umane: un anonimo cronista – conosciuto sotto il nome di Eraclio – sottolinea che san Francesco «notò il male e il peccato che cominciava a crescere tra la gente dell’accampamento» (FF 2238). Acutamente il beato Tommaso da Celano commenta: «L’ostinazione di solito porta a funesta rovina perché, confidando nelle proprie forze, non merita l’aiuto celeste. Se infatti si deve sperare la vittoria dall’alto bisogna pure attaccare battaglia solo dietro l’ispirazione divina». Va ricordato – come è storicamente noto – infatti che la Quinta Crociata fu dominata dalla trista figura del legato papale, lo spagnolo cardinale Pelagio il quale, per ambizione mista a impreparazione, decise di sfidare in maniera temeraria il sultano Malik-el-Kamil. Questi, messo alle strette dal grande esercito crociato, si era detto disponibile a cedere Gerusalemme se i crociati avessero tolto l’assedio all’importante porto di Damietta. Il cardinal Pelagio, troppo sicuro di sé e contro l’opinione dei capi militari, invece rifiutò l’offerta e cercò di far capitolare del tutto il sultano. Alla fine, nonostante la sconfitta preannunciata da san Francesco, Damietta – estenuata da un lungo assedio – cadde, ma il vantaggio crociato fu effimero ed essi non riuscirono mai a giungere in Terra Santa anzi ben presto dovettero di nuovo cedere il porto egiziano. Forse l’azione di san Francesco andò proprio contro questa folle scelta del Cardinale, che a ben vedere si opponeva anche alla finalità della Crociata, che non doveva avere mire politiche se non indirizzate alla liberazione della Terra Santa. Ad ogni modo l’ammonimento di san Francesco non significò una condanna della Crociata e come tale non fu percepito nemmeno dai contemporanei. Il cronista della Storia di Eraclio, sicuramente favorevole ai crociati, sottolinea infatti che san Francesco «venne all’esercito di Damietta e operò molto bene» (FF 2238). Basti poi pensare che il comandante dell’esercito cristiano, il re di Gerusalemme Giovanni di Brienne, fu talmente affascinato dalla figura del Santo di Assisi che, alla sua morte, chiese e ottenne di essere seppellito nella Basilica inferiore di Assisi dove si può ancora vedere la sua tomba.
Un nuovo spirito crociato
Alcuni hanno voluto vedere persino nella partenza di san Francesco d’Assisi dall’accampamento crociato verso la terra del sultano una silenziosa critica alla Crociata, come a voler indicare che il suo modo di agire pacifico e disarmato fosse quello corretto mentre errato fosse l’uso delle armi contro gli islamici. In realtà qui si tratta di un fraintendimento storico completo: san Francesco va nel Vicino Oriente anzitutto – come abbiamo detto – per cercare il martirio e, con esso o senza di esso, la conversione degli infedeli musulmani. Niente di tutto ciò invece era la finalità della Crociata, la quale non si proponeva di convertire gli islamici e tanto meno di sottometterli per poi forzarli a farsi battezzare. La Crociata era una guerra giusta volta a restaurare i diritti della Cristianità sulla Terra Santa, ovvero il possesso dei Luoghi santi o, quanto meno, l’indiscutibile diritto dei cristiani di andare in pellegrinaggio nei luoghi santificati dalla presenza di Nostro Signore e dagli eventi salvifici della Redenzione. San Francesco non critica la Crociata con il suo modo di agire in quanto, semplicemente, ha uno scopo totalmente diverso da quello dei crociati. Si può forse dire che, silenziosamente e con il suo esempio, sta ricordando ai crociati che dall’altra parte del campo di battaglia ci sono anime da convertire e da salvare, ma in alcun modo per questo starebbe condannando l’ideale giusto e sacrosanto di riconquistare la Terra Santa e permettere i pellegrinaggi dei cristiani. Sta forse indicando un obiettivo più alto – la conquista delle anime anziché la conquista della Terra Santa – ma senza escludere né tanto meno condannare quello meno elevato. Sta aprendo la strada a un nuovo tipo di battaglia e di crociata, una “Crociata spirituale” in favore delle anime da salvare, ma senza per questo opporsi alla Crociata “terrena” per la salvezza del dominio cristiano a Gerusalemme.
Ad ogni modo a voler dare ascolto alla testimonianza del compagno di san Francesco – fra’ Illuminato da Rieti – la posizione del Santo circa la Crociata è ancora più fastidiosa alle orecchie dei moderni “dialoganti” ed ecumenisti, in quanto se san Francesco criticava la Crociata, la criticava per difetto e non per l’eccesso di forza. Secondo fra’ Illuminato, dinanzi al Sultano che gli aveva rinfacciato che i crociati non seguissero l’insegnamento di Gesù nel non rendere male per male, il Santo rispose: «Mi sembra che non abbiate letto tutto il Vangelo di Cristo Nostro Signore. Altrove sta scritto: “Se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo lontano da te” [...]. Proprio per questo i cristiani giustamente invadono voi e le terre che avete occupato, perché bestemmiate il nome di Cristo e allontanate dal suo culto quanti più uomini potete» (FF 2691). Ben lungi dal condannare le Crociate, san Francesco immise nel Cattolicesimo un nuovo e più radicale spirito crociato, destinato a fruttificare e a rialzare la Chiesa Cattolica.
“Ne la presenza del soldan superba...” (Paradiso, XI)
Giunti a questo punto, coloro che vedono in san Francesco il precursore del dialogo interreligioso e del sincretismo in cui tale dialogo spesso sfocia, vedranno nel Santo di Assisi che si reca dal sultano non solo una condanna dell’uso delle armi per motivo religioso, bensì anche una commovente testimonianza dell’amore per l’umanità e per le diverse religioni. San Francesco – secondo questi – non andrebbe dal sultano ad annunciargli il Vangelo né tanto meno a cercare di convertirlo o di dimostrargli la falsità della sua religione, ma solo a dialogare con lui: andrebbe – come si suole ripetere oggi con qualche frase trita e ritrita – non a dare qualcosa ai non-cristiani ma a ricevere qualcosa da loro, ad arricchirsi umanamente dalla conoscenza delle altre religioni, mettendo contemporaneamente tra parentesi la sua confessione cristiana. Niente di più falso e favoloso se si confronta la vicenda dell’incontro con il sultano, così come tramandataci dalle fonti.
San Francesco si addentrò in territorio islamico sicuro che sarebbe stato di lì a poco arrestato, tenendo presente che il sultano Malik-el-Kamil – detto “sultano di Babilonia”, ma che in realtà governava in Egitto – aveva emanato un editto in cui si ricompensava la consegna di ogni cristiano prigioniero con un bisante d’oro. Dopo essere stato arrestato e malmenato dalle guardie (anche se alcuni cronisti tacciono su questo aspetto), il Santo fu condotto dal sultano, in quanto durante la prigionia si limitava a ripetere continuamente l’unica parola conosciuta in arabo: “Sultano, sultano”. Dinanzi a Malik-el-Kamil – il “soldan superbo”, come definito da Dante – san Francesco non si dimostrò però molto interessato a intraprendere un dialogo alla pari e nemmeno ad “arricchirsi” con la conoscenza della religione musulmana e della sua spiritualità. San Francesco non era andato a discutere, anzi riteneva abbastanza inutile il farlo in quanto – come ci tramanda san Bonaventura – disse che sarebbe stato vano farlo con la mera ragione, poiché inferiore alla fede, ma dato che i musulmani non accettavano la Sacra Scrittura non si sarebbe potuto iniziare a discutere nemmeno da lì (cf. In Hexaemeron XIX, n. 14). Cosa era dunque andato a fare? Alla domanda su chi lo avesse inviato, san Francesco non esitò a rispondere che «non era stato inviato da uomini, ma da Dio Altissimo, per mostrare a lui e al suo popolo la via della salvezza e annunciare il Vangelo della verità» (Fonti Francescane, n. 1173). Le parole che rivolse al sultano risultano del tutto inequivocabili circa le intenzioni del Santo e circa il suo atteggiamento: egli era interessato solo alla salvezza delle anime, e in particolare a quella del sultano, che avrebbe potuto trascinare con sé nella Religione cattolica innumerevoli uomini se non addirittura interi popoli.
“Predicò Cristo e li altri che ’l seguiro” (Paradiso, XI)
Aveva colto bene la questione il sommo poeta Dante, il quale senza orpelli ci tramanda con precisione il senso della missione di san Francesco: predicare Cristo e la Chiesa Cattolica, indicata con una parafrasi (“gli altri che seguirono Cristo”). Tra tutte le versioni del colloquio – sostanzialmente in accordo – scegliamo quella tramandataci dal cronista Ernoul, continuatore della storia delle crociate di Guglielmo da Tiro. Davanti al sultano che domandava loro se avessero voluto farsi saraceni ed evitare così spiacevoli conseguenze, il Serafico Padre rispose negativamente per poi aggiungere: «Se voi non volete credere alla religione cristiana, noi consegneremo la vostra anima a Dio, perché vi diciamo in verità che se morirete in questa legge che ora professate, voi sarete perduto, né mai Dio avrà la vostra anima. Proprio per questo siamo venuti a voi». A differenza del linguaggio odierno in cui si tenta sempre, anche a costo di equilibrismi teologici e retoriche “arrampicate sui vetri”, di cogliere i “semi di verità” in tutte le religioni false e nelle ideologie erronee e, al contempo, di salvare chiunque dalla condanna infernale, san Francesco senza mezzi termini mostrò al sultano la falsità dell’islamismo e il rischio della sua salvezza eterna, se si fosse rifiutato di convertirsi.
Nonostante san Francesco mancasse di quel “tatto pastorale” che tanto si raccomanda oggi nel dialogo interreligioso, il sultano rimase edificato dalla convinzione con cui parlava, dal fervore di spirito che dimostrava e dalla sapienza celeste che promanava da lui. Per questo lo ascoltò volentieri, alla presenza dei suoi consiglieri e dei dotti islamici, e lo invitò anzi a rimanere con lui, nonostante i toni poco concilianti dell’Assisiate. Il Poverello di Assisi, però, ben attento a non farsi inghiottire da nessuna corte, rispose chiaramente, indicando il senso della sua missione: «Se tu, con il tuo popolo, vuoi convertirti a Cristo, io, per suo amore, resterò molto volentieri con voi. Se invece esiti ad abbandonare la legge di Maometto per la fede di Cristo, da’ ordine di accendere un fuoco il più grande possibile: io, con i tuoi sacerdoti, entrerò nel fuoco e così, almeno, potrai conoscere quale fede, a ragion veduta, si deve ritenere più certa e più salda» (FF 1174). L’ordalia – la prova del fuoco – invocata da san Francesco non venne però raccolta dal sultano il quale anzi, vedendo subito dileguarsi alcuni dei suoi consiglieri, commentò amaramente che non credeva che tra i suoi “sacerdoti” vi fosse qualcuno che fosse pronto a esporsi al fuoco o alla tortura per dimostrare la verità della propria fede. Nemmeno accettò che il solo san Francesco si gettasse nel fuoco per dimostrare la verità del Cattolicesimo, constatando che se avesse accettato la Fede cattolica vi sarebbe stata una sedizione popolare.
Maliziosamente i dotti islamici però cercarono di dissuadere il sultano dall’ascoltare quei due frati, anzi gli ricordarono che la legge imponeva di tagliare la testa ai predicatori di altre religioni. Al che il sultano, rivolgendosi ai francescani, rispose: «Per quest’unica volta, andrò contro la legge, non facendovi tagliare la testa. Sarebbe una ricompensa malvagia far morire voi, che avete voluto coscientemente affrontare la morte per salvare l’anima mia nelle mani del Signore Iddio» (FF 2234). Intimamente stupito dalla singolarità di quell’uomo «così profondamente diverso dagli altri» (FF 422), Malik-el-Kamil volle donargli molte cose preziose, le quali furono tutte rifiutate dal Poverello, «avido non di cose mondane ma della salvezza delle anime» (FF 1174). Solo chiese qualcosa da mangiare e tenne con sé – ed è ancora conservato nel Sacro Convento di Assisi – un corno di ossa di manifattura orientale, il quale da lì in poi san Francesco avrebbe usato per chiamare la gente a raccolta quando andava a predicare in un villaggio. A titolo di benevolenza però il sultano autorizzò i frati a predicare nei suoi territori e li rimandò scortati all’accampamento crociato, con un salvacondotto che gli permettesse di evitare ogni eventuale angheria della soldataglia islamica.
“E per trovare a conversione acerba troppo la gente” (Paradiso, XI)
Pur ammirando tutte le virtù del Serafico Padre, si potrebbe obiettare: a che pro questo linguaggio e questo atteggiamento missionario se alla fine né il sultano, né nessuno dei suoi si convertì? Proprio quest’episodio non dimostrerebbe il fallimento di questa strategia missionaria “dura e pura”? Evidentemente stanno nel mistero insondabile della volontà divina e della libertà umana la corrispondenza alla grazia e la conversione perciò, in questo campo, la valutazione umana è necessariamente superficiale e approssimativa. Tuttavia va detto che accanto a chi – come Dante e il beato Tommaso da Celano – fece notare l’insuccesso della missione di san Francesco, altri rimasero aperti invece a un esito positivo, per quanto celato nel segreto.
Oltre al fatto che in qualche modo si aprì una strada per la missione francescana in Terra Santa e nel mondo arabo del Vicino Oriente – ancora perseguita dalla gloriosa Custodia di Terra Santa dei Frati Minori – in effetti altri testimoni sottolinearono che lo stesso sultano non rimase affatto indifferente all’annuncio di san Francesco. Il celebre cronista Giacomo da Vitry, in una sua lettera a papa Onorio III, scrisse che «il sultano pregò san Francesco, in segreto, di supplicare per lui il Signore perché, dietro divina ispirazione, potesse aderire a quella religione che più piacesse a Dio» (FF 2212). Se nella Leggenda Maggiore san Bonaventura scrisse che san Francesco non trovò nel sultano «la radice di una vera pietà» (FF 1174), in un sermone sulla figura del suo santo Fondatore attribuì – in base ai ricordi di fra’ Illuminato – al sultano l’ammissione che la Fede cristiana fosse quella vera e che questi, non potendo convertirsi apertamente, mantenne però sempre la Fede cristiana impressa nel cuore (cf. FF 2701).
Ancora più in là si spingono invece i Fioretti – a dire il vero più tardi rispetto a tutte le altre testimonianze – i quali attribuiscono al sultano una conversione esplicita, seppur ritardata in punto di morte. Secondo questi quando san Francesco stava per partire Malik-el-Kamil gli disse che avrebbe voluto convertirsi alla Fede cristiana ma, temendo che lui e tutti i frati sarebbero stati uccisi immediatamente, non sapeva come comportarsi. Al che il Santo gli disse che, per divina rivelazione, era meglio che non si convertisse immediatamente ma che si tenesse sempre pronto e saldo nella fede e nella devozione perché, prima della sua morte, gli avrebbe mandato due frati a battezzarlo. In effetti molti anni dopo, quando il Santo era già morto e il sultano si apprestava a rendere l’anima a Dio, san Francesco apparve a due frati e chiese loro di recarsi dal sultano, oltre mare. Il sultano, fiducioso nella promessa, aveva già avvisato le guardie di lasciar passare degli uomini vestiti di un saio marrone cinto con una rozza corda, cosicché quando questi arrivarono poterono giungere al capezzale del sultano senza intoppi, istruirlo sulla Fede cattolica e battezzarlo, e così «la sua anima fu salva per meriti e orazioni di santo Francesco» (FF 1856).
Miracoli che avvengono quando santi, come san Francesco, si mettono il mondo e il rispetto umano sotto i piedi e gridano ad alta voce la verità di Cristo, senza timore di dispiacere agli uomini e convinti solo di servire Dio.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale