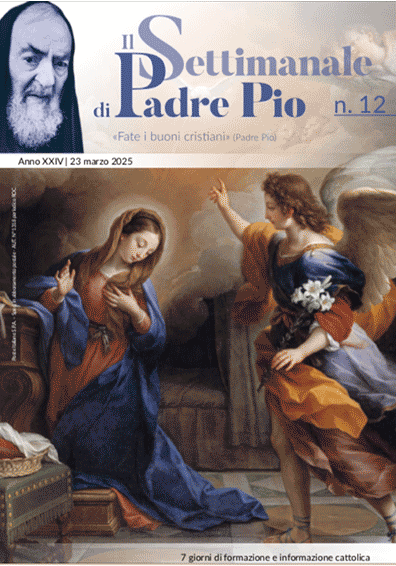Sussidiarietà: un principio da rilanciare
dal Numero 28 del 14 luglio 2019
di Riccardo Pedrizzi
Il cosiddetto “principio di sussidiarietà” è importante per comprendere il ruolo dello Stato e il suo margine di movimento in rapporto alla vita personale, familiare e sociale dei cittadini. Esso garantisce in pari tempo maggior efficienza allo Stato e maggior protezione e promozione ai singoli e alle famiglie.

Il principio di sussidiarietà è quel principio che suggerisce – o meglio dovrebbe imporre e impone – alle istituzioni, in genere, ed allo Stato, in particolare, di svolgere una funzione di supplenza, quando è necessario, e di aiuto, quando è richiesto, alla vita ed alla crescita della persona e della società.
Quasi tutti, oggi, soprattutto nella affannosa ricerca di soluzioni adatte ad uscire fuori da questa drammatica crisi che ci ha colpito, singoli, forze sociali, economiche e politiche riconoscono, passata la sbornia ideologica che ha avvelenato il XX secolo, che sia la persona che le formazioni sociali in cui essa si sviluppa, prima fra tutte la famiglia, hanno diritti che sono anteriori alle leggi positive ed allo Stato che deve semplicemente prenderne atto, riconoscerli e garantirli.
Da qui dovrebbe derivare un ordinamento giuridico e normativo nel quale singoli e gruppi hanno diritti e spazi di libertà che lo Stato deve limitarsi a tutelare e promuovere.
Da qui discende, inoltre, che l’intervento dello Stato nella vita personale, familiare e sociale non può essere né assoluto, né illimitato, né giustificato quando oltrepassi il limite del rispetto dei diritti, delle libertà e delle finalità naturali delle persone e delle comunità umane (i cosiddetti corpi intermedi della società).
Tale intervento è, invece, necessario ed auspicabile ogniqualvolta singoli e gruppi non siano in grado, da soli, di esercitare i propri diritti e di raggiungere i propri obiettivi.
Si tratta, in questo caso, del principio di sussidiarietà “positiva”, o “promozionale”, che impone allo Stato di intervenire per incentivare l’autonomia dei soggetti sociali e per aiutarli a raggiungere le proprie finalità, rimuovendo gli eventuali ostacoli.
Mentre lo stesso principio di sussidiarietà, nella sua accezione “negativa”, o “positiva”, impedisce allo Stato di violare la sfera di libertà delle persone, della famiglia e degli altri corpi intermedi della società o, comunque, di sostituirsi ad essi nella realizzazione dei loro scopi, «siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e con l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare» (Pio XI, Quadragesimo anno, enciclica del 15 maggio 1931).
Corollario del principio di sussidiarietà è che il compito di affrontare e la responsabilità di risolvere qualunque problema individuale o sociale risiedono prima di tutto nella comunità umana più vicina al problema stesso.
La sussidiarietà, dunque, è da intendersi come quel principio capace nell’esperienza sociale di valorizzare le autonomie sociali, di riconoscere il valore dei “piccoli”, affidando ai “grandi” il compito di insegnare loro le modalità migliori per esercitare i propri diritti, le proprie funzioni, senza sottrarglieli o, peggio, senza sostituirsi a loro; e altresì capace di costruire un sistema di rappresentanza, di cura degli interessi e di promozione dello sviluppo delle comunità locali, finalmente centrato sull’autonoma e originaria responsabilità degli enti locali. A partire dalle comunità e dalle organizzazioni più piccole per risalire, a poco a poco, verso quelle più ampie e ritenute (ma spesso a torto) più importanti. Il che non vuol dire però sostituire al grande Moloch della burocrazia statale tante piccole burocrazie, dando vita ad un esercito di roditori che ingrossa le fila di un già pletorico apparato pubblico.
La sussidiarietà vuol dire lasciar campo libero, ovunque sia possibile, a privati, associazioni, cooperative ed imprese che possono fare lo stesso lavoro, magari con costi inferiori e qualità dei servizi migliori.
Questa concezione la troviamo, tutto sommato, sancita nella nostra Costituzione: nel significato “protettivo” all’articolo 2, («la Repubblica riconosce e garantisce i diritti individuali dell’uomo, sia come singolo, sia nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità») ed all’articolo 29 («la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»); nel senso “promozionale” all’articolo 3, II comma («la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana») ed all’articolo 30 («nei casi di incapacità dei genitori, la legge prevede a che siano assolti i loro compiti»); nell’accezione sia “protettiva” che “promozionale” all’articolo 5 («la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali»).
Ma di fatto questo principio è stato espunto, espulso e disatteso dalle relazioni e dalla vita sociale del nostro Paese, per il prevalere negli ultimi due secoli di logiche centralistiche e statalistiche: dalla organizzazione dello Stato alla burocrazia, dalla economia alla scuola, dalle politiche familiari a quelle in favore di tutti gli altri gruppi sociali naturali o volontari.
Con la riforma del titolo V della Costituzione all’articolo 118 fu introdotta l’attribuzione delle funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà, cioè attribuendole, prima di tutto, ai Comuni perché sono gli enti più vicini ai cittadini e, via via, ai livelli di governo più lontani se questo si rende necessario. Prima della riforma esse venivano conferite sulla base del principio del parallelismo: chi deteneva la funzione legislativa in una materia deteneva anche quella amministrativa.
Ma quella riforma, anche in questo punto, esclusivamente politico-amministrativo e non in grado di avere un impatto sociale sulla vita delle persona, ha dimostrato da anni tutti i suoi limiti.
Lo Stato, infatti, fino ad oggi ha fatto e continua a fare di tutto ed a occupare spazi di libertà che non gli sono propri, nonostante la svendita di tante imprese pubbliche. E lo dimostra la dimensione del bilancio statale che, nonostante le varie manovre che si susseguono da parte dei governi di ogni colore, tende a crescere, sempre più così come tutte le risorse gestite dal settore pubblico.
Il principio di sussidiarietà è un principio di efficienza, poiché consente allo Stato di liberarsi di oneri che non gli competono e che sono di minor significato, riappropriandosi invece e con pienezza della sua funzione esclusiva di dirigere, vigilare e reprimere.
Eppure lo Stato tarda ancora ad uscire da molti settori (basti pensare alle migliaia di società municipalizzate) ed è restio a trasformare il proprio ruolo e la propria funzione da produttore di servizi a quella di regolatore e di controllore.
Perché tutto ciò avvenga veramente non basta perciò, al punto in cui siamo, limitarsi ad introdurre nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà solamente nella sua dimensione “verticale”, che si ridurrebbe ad un decentramento delle funzioni dal centro alla periferia (federalismo), ma occorre puntare anche e soprattutto sull’aspetto “orizzontale”, che esalta le iniziative e rende fecondo il ruolo delle singole persone e dei gruppi sociali, a cominciare dalla famiglia.
Proprio per questo tutti coloro che credono nel primato della persona e nella sua priorità ontologica rispetto alle istituzioni devono fare, nella pienezza di tutte le sue potenzialità, del principio di sussidiarietà, peraltro già adottato e vigente nell’ambito della Comunità Europea, un fondamentale criterio di giudizio e di riferimento per la propria azione politica e sociale.
Per questo né la visione liberal individualistica del mondo, in cui tutto (o quasi) è scambio, né la visione statolatrica, in cui tutto (o quasi) è doverosità, sono guide sicure per farci uscire dalle secche in cui è finito l’Occidente sviluppato.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale