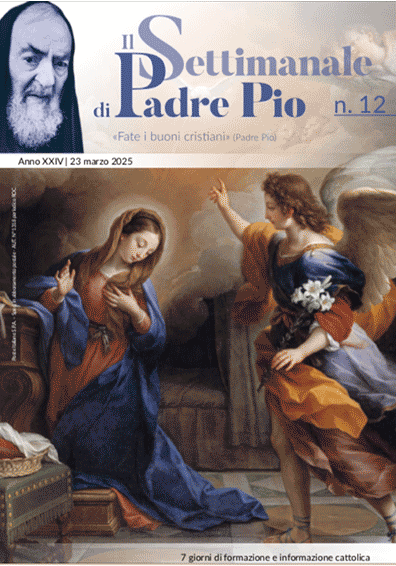J. H. Newman approda alla Chiesa Cattolica
dal Numero 25 del 23 giugno 2019
di Moisè Piave
Con la prossima canonizzazione John Henry Newman sarà il primo inglese, vissuto in Inghilterra dopo lo scisma, ad essere proclamato santo dalla Chiesa Cattolica. Seguiamolo nel suo percorso interiore verso la Chiesa di Roma, per scoprire con lui l’immenso valore della Tradizione cattolica.

In occasione della imminente canonizzazione del celebre convertito inglese è utile interrogarsi sulle motivazioni profonde che lo hanno portato ad agire. Si è parlato e scritto molto di lui anche se non sempre a proposito.
In questo articolo non abbiamo la pretesa di colmare quella che a nostro avviso è una lacuna, ma almeno desideriamo dare qualche elemento per spingere i lettori ad approfondire le mirabili circostanze che non senza l’eroica corrispondenza del Newman e la materna azione di Maria lo hanno condotto passo dopo passo in modo provvidenziale ad accettare ciò che fino a pochi anni prima riteneva inaccettabile e cioè la vera Chiesa di Cristo, la Chiesa di Roma.
Egli stesso nella nota autobiografia (Apologia pro vita sua del 1864) divide la sua vita in tappe cronologicamente scandite pur non dandovi un nome. Noi le divideremo in quattro: la prima conversione, la seconda conversione, il periodo della solitudine ed infine la pace interiore con l’approdo alla soliditas Cathedrae Petri, la «solidità della Cattedra di Pietro» come la definì il protagonista di un romanzo da lui scritto. Per concludere prenderemo in esame lo sviluppo della sua devozione mariana.
Iniziamo, allora questo breve itinerario nell’anima del celebre convertito, magistralmente guidato dalla divina Provvidenza, analizzando il primo momento del suo percorso spirituale quella che lui stesso definì la sua «prima conversione».
“God and myself” ovvero “La prima conversione”
Nel cuore dell’infanzia del giovane Newman già troviamo l’inclinazione a trasfigurare il reale e a cercare la verità delle cose al di là della superficie. Un’inclinazione, però, da sola non è sufficiente. Come tutti i piccoli inglesi anch’egli, in perfetta tradizione protestante, fu iniziato ai Testi Sacri molto precocemente. La forte e bella lingua biblica nella versione “ufficiale” del Re Giacomo s’impresse con forza nel suo animo, ma non bastò a renderlo un cristiano fervente.
Certo, rimaneva in lui una delicatezza morale non comune assieme ad un ingegno eccezionale, ma tutto ciò non era sufficiente a renderlo uno spirito molto religioso.
Anzi, a causa anche della precoce scolarizzazione tutta improntata, secondo la moda del momento, il giovane Newman assunse sempre più un atteggiamento orientato ad un deismo molto vago di marca liberale ed umanistica. Verso i quattordici anni, come ricorderà nella sua Apologia, giungerà anche ad avvertire dubbi sull’immortalità dell’anima e, leggendo alcuni versi di Voltaire al riguardo, scrisse al margine: «Quant’è terribile, quant’è plausibile».
L’estate del 1816 che passò nella solitudine del collegio fu, dunque, il momento di quella che chiamò la sua “prima conversione”. L’esperienza, mediata certamente dai colloqui con un pastore anglicano vicino al movimento “evangelico” di matrice più calvinista, venne descritta come «una ripresa, un ritorno dei principi sotto l’azione dello Spirito Santo che avevo già sentiti e che, già, m’avevano in parte diretto quand’ero giovane». L’essenza della conversione è definibile come il carattere dottrinale d’una certezza religiosa. Il giovane riceve lo choc di una dipendenza: «Venni sotto l’influenza d’un Credo definito e ricevetti nell’intelletto impressioni del dogma».
Il frutto più importante di questa esperienza fu la scoperta di un Dio personale e vivente, l’esperienza terribile ed incomunicabile di un Dio che parla alla sua coscienza, gli si rivela nella sua trascendenza e gli fa conoscere la sua condizione di creatura: «Dio è presente nel mio essere, dentro di me e tuttavia infinitamente al di sopra di me». All’uomo, quindi, non resta che discernere i segni nei quali riconosce l’esistenza del suo Creatore e la sua vicinanza. E questo è l’esercizio della fede. L’uomo che vuole farsi guidare dalla fede altro non deve fare che cercare e scoprire i segni di Dio per cogliere i pegni della certezza.
In questo modo vediamo già delinearsi i tratti principali della spiritualità newmaniana e il lungo ed impervio cammino che lo porterà, non senza l’indispensabile azione della grazia, con la continua ricerca dei “segni di Dio” ad approdare alla Fede cattolica.
“Un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vuoi”: la seconda conversione
La conversione fu un miracolo e pose le basi di una svolta tanto che nell’Apologia dirà di ritenere il giovane John Henry precedente a quest’esperienza un’altra persona. Certamente egli mantenne sempre salda in sé questa convinzione della presenza e vicinanza di un Dio personale e la decisione e lo zelo che pose nell’intraprendere la carriera ecclesiastica lo testimoniano. Ma, come egli confesserà più tardi, non aveva ancora una direzione precisa nella sua vita. Per un breve periodo fu preso dall’aspirazione ai titoli accademici gli honours dell’università di Oxford e dal liberalismo che vi aleggiava anche se ben presto sarà conquistato da ideali ben più alti e nobili. L’amicizia con John Keble fu un ulteriore incentivo su questa via. Infatti Keble era un giovane pastore anglicano che, dopo aver ottenuto gli onori più alti dell’università, aveva rinunziato alla carriera accademica già spianata ed al clima intellettuale ma spiritualmente arido della città, per ritirarsi in una parrocchia di campagna dove esercitava il suo ministero parrocchiale, coltivando le sue doti di poeta e cercando un rapporto più profondo con Dio.
Questo approfondimento del rapporto con Dio divenne con il tempo, sull’esempio dell’amico, lo sprone della sua attività anche se non riusciva bene a comprendere in che modo potesse concretizzarsi.
“Guidami, luce gentile”
È di questo periodo la sua importante opera sugli Ariani del IV secolo a dimostrazione del suo interesse per il periodo patristico e l’antichità cristiana che non lo abbandonerà mai. L’esperienza, però, che orienterà in una direzione precisa questi diversi interessi della vita del Newman fu quella del viaggio nel Mediterraneo intrapreso, in parte controvoglia, con alcuni amici nel 1834.
Colpito dal paesaggio e dalle testimonianze dell’antica presenza cristiana decide di abbandonare i suoi compagni di viaggio e di tornare da solo in Sicilia. In una spedizione verso l’interno dell’Isola cadrà malato nei pressi di Enna, rimanendo inchiodato al letto per tre settimane tra la vita e la morte.
Durante questo periodo egli sperimenta quella che definisce una illuminazione interna: «Ebbi nella mia mente la strana sensazione che Dio viene incontro a coloro che vanno per la sua via; [...] che io dovevo mettermi dunque nel suo sentiero, nella sua via, dovevo fare anche io la mia parte».
Egli percepì chiaramente la sua nullità e la necessità di abbandonare la propria volontà ed ogni ambizione umana per permettere all’anima di schiudersi alla fede ed all’amore di Dio. Era la resa, la sottomissione alla divina volontà che gli permetteva finalmente di poter comprendere e seguire con soprannaturale indifferenza a quanto gli poteva accadere quella che riteneva la sua vocazione: riformare la Chiesa d’Inghilterra.
Questi sentimenti li espresse in una celebre poesia Lead, kindly light (Guidami, luce gentile) in cui si riflettono la serena umiltà e la tranquilla fiducia che ormai l’animavano.
Al suo ritorno dalla Sicilia si dedicherà anima e corpo alla missione che sa di dovere adempiere. L’ora per la Chiesa anglicana è grave ed egli è convinto che è suo dovere fare tutto ciò che può per risvegliare dal torpore i suoi figli migliori.
Risveglio dal “sonno antidogmatico”: strumento di Dio nella lotta al liberalismo
L’obiettivo di Newman è chiaro: bisogna richiamare la Chiesa alla sua propria dignità aiutandola a riscoprire il senso della sua missione.
L’unico modo per fare questo è quello di riportare la Chiesa ai principi divini della sua fondazione ed alle esigenze della sua missione.
A questo punto vediamo che Newman è ancora convintamente anglicano e il suo obiettivo non è certamente quello di condurre alla Chiesa Cattolica la Chiesa anglicana, ma soltanto quello di rivitalizzarla. Questa risoluzione, però, inizia un processo che, riportandolo alla inevitabile riscoperta della Tradizione, non potrà non portarlo, infine, all’unico luogo in cui questa Tradizione si è conservata inalterata.
Per agire si decise che il modo più efficace fosse la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, noti come Tracts, destinati a scuotere con un linguaggio fermo, drastico e diretto l’indifferentismo di tutti coloro che dovevano normalmente occuparsi di cose della Chiesa.
Ciò, manifestando tutta la sacra passione che animava gli estensori, non poteva lasciare indifferenti ed anzi seduceva ed affascinava: era nato, ormai, il Movimento di Oxford. Un movimento che creerà molto scalpore e fungerà da spartiacque per la Chiesa anglicana.
Già dopo la pubblicazione dei primi opuscoli (i famosi Tracts), Newman comprende bene che per continuare è necessario radicarsi su un terreno più solido e che questo non poteva che essere dottrinale, cioè dogmatico. A differenza di David Hume che circa cento anni prima aveva dichiarato di essersi “risvegliato dal sonno dogmatico” per poi cadere nello scetticismo totale e nella negazione del fondamento di qualsiasi conoscenza, Newman si potrebbe dire essersi risvegliato dal “sonno antidogmatico” del liberalismo che permeava ormai gran parte della Chiesa d’Inghilterra e che pretendeva di sottomettere le più profonde certezze della Fede all’arbitrio della libertà di pensiero.
Il liberalismo – assimilabile a ciò che oggi definiamo relativismo – fu, infatti, per Newman il nemico più temibile ed egli non avrebbe mai cessato di combatterlo proprio perché vedeva nell’essenza dello stesso quel “principio antidogmatico” che è la rovina della religione e della società.
Ormai cattolico, nel celebre “discorso del biglietto” (Biglietto speech), pronunciato il giorno in cui ricevette la porpora cardinalizia nel 1879, ribadì che «fin dall’inizio ho cercato di contrastare lo spirito del liberalismo nella religione».
Il partito liberale, infatti, aveva all’epoca un forte seguito, ispirando l’azione di filosofi e di molti uomini politici che, se erano concilianti sui privilegi che la Monarchia garantiva alla Chiesa anglicana, erano risoluti nel sottrarla ad ogni ortodossia dottrinale.
Questo avveniva non tanto o non solo su pressione di persone irreligiose e apertamente contrarie al cristianesimo, come ad esempio in Francia o in altre parti del continente europeo, ma sotto la pressione delle varie sette protestanti che cercavano in questo modo di sottrarre spazio alla “Chiesa Stabilita”.
Per vincere questa battaglia contro il pericolo liberale era ormai chiaro che Newman ed i suoi compagni non potevano accontentarsi di un mero spirito di polemica, ma dovevano presentare un concreto programma di rinnovamento a tutto campo: innanzitutto dottrinale, ma anche liturgico ed ascetico. Infatti, poiché la fede di Newman è dogmatica il movimento non potrà non essere un rinnovamento teologico, poiché è sacramentale non potrà non essere liturgico e poiché è inseparabile dalle esigenze evangeliche non potrà non essere un movimento promotore di ascesi e di santità.
“Quaerere Deum”: la ricerca della santità
Quest’ultimo è, forse, uno degli aspetti rimasti maggiormente in ombra del Movimento anche se ne costituisce, come ci pare di aver chiarito, il moto propulsore. L’insistenza sulla vera conversione era costante nei sermoni di Newman. Il Movimento tendeva a riscoprire in modo irresistibile le sorgenti di una vera spiritualità prima con i pochi autori anglicani del XVII secolo, poi, sempre di più, con i classici della spiritualità cattolica come le Lettere di santa Teresa d’Avila, Il Combattimento spirituale di Scupoli, L’introduzione alla vita devota di san Francesco di Sales. Questo processo che giunse, pur tramite un “riadattamento” alla spiritualità anglicana, fino alla vera e propria traduzione di ampi estratti del Breviario romano, fu guardato con grande sospetto dalla gerarchia che arrivò a vietarlo. Tra i suoi progetti vi era anche quello di reintrodurre la vita religiosa secondo il modello classico in Inghilterra, dove era stata soppressa con la separazione da Roma.
Il Movimento di Oxford e la pretesa apostolicità della Chiesa anglicana
Dal 1835 al 1839, quindi, il Movimento di Oxford, guidato dall’indiscussa leadership del futuro cardinale, ma composto anche di altri nomi noti all’ambiente universitario oxoniense come il già citato Keble e il canonico Pusey, che pure resteranno sempre anglicani, era al centro delle polemiche e delle discussioni tra i fedeli anglicani.
In questi anni, oltre ai Tracts su argomenti scottanti come la dottrina della giustificazione, anche la predicazione di Newman nella chiesa di Saint-Mary attirerà un numero di fedeli sempre maggiore.
Questa fase idilliaca sarebbe però terminata ben presto. L’idea della Chiesa anglicana come via media tra lo snaturamento del cattolicesimo romano e le innovazioni protestanti era destinata a non durare a lungo.
Nel 1841 Newman pubblicherà l’ultimo e più famoso dei Tracts, il numero 90, nel quale egli sostiene, non senza difficoltà, che i “trentanove articoli” che costituiscono lo statuto della Chiesa anglicana s’identificherebbero alla fin fine con i dogmi del Concilio di Trento, purificati dai commenti romani che ne oscurerebbero e ne falserebbero il significato.
Una posizione invero bizzarra, ma comprensibile. Egli, infatti, nel suo studio ed approfondimento della tradizione patristica, in cui vedeva le origini pure e incorrotte comuni alla Chiesa d’Inghilterra ed a quella Romana, si era trovato davanti ad un dato incontestabile per un occhio acuto e scevro, ormai, di quasi tutti i pregiudizi negativi come il suo, e cioè lo sviluppo dottrinale organico che caratterizzava tutta l’epoca patristica che portava all’esplicitazione delle verità di Fede ed alla proclamazione dei dogmi nel corso dei secoli. Come una pianta si sviluppa e cresce, restando però sempre se medesima, anche la dottrina non muta sostanzialmente, ma semplicemente si approfondisce, si chiarisce grazie al lavorio razionale e speculativo da una parte e dall’altra all’ineffabile azione dello Spirito Santo inviato a farci conoscere la verità tutta intera (cf. Gv 14,26).
Ma una volta accettato questo principio come fondamento, non si poteva bloccarlo ad una data o epoca senza una vera ragione. Perché accettare la dottrina fino al IV secolo, oppure fino all’VIII? Quale la differenza sostanziale tra i primi Concili ecumenici e quelli successivi e più recenti come il Tridentino? Erano domande che Newman si poneva anche se ancora, come abbiamo visto, non riusciva a rispondervi pienamente. Poco alla volta, passo dopo passo, finirà per accettare e fare suoi uno dopo l’altro i vari usi cattolici, sia in ambito strettamente spirituale, come abbiamo visto, sia in ambito dottrinale (la giustificazione, la Presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, la confessione auricolare, fino ai decreti tridentini).
Ma questo percorso di progressivo avvicinamento alla Chiesa Romana, pur seriamente motivato, non poteva non destare dapprima i sospetti e, man mano che procedeva, le censure della Comunione anglicana. La condanna da parte della gerarchia anglicana dell’opuscolo 90 nel 1841 non giunse quindi come un fulmine a ciel sereno, ma era già stata considerata come la reazione più probabile alle prese di posizione dei “trattariani”. Essa poteva considerarsi la definitiva sepoltura del Movimento oxoniense.
Tutti gli sforzi fatti per fornire alla Chiesa anglicana un fondamento dogmatico in grado di giustificare la sua pretesa di apostolicità non erano stati compresi dai suoi correligionari che anzi lo accusarono di essere un “romanista”.
Pur non comprendendone le motivazioni profonde, però, le accuse dei suoi nemici non erano peregrine. La strada intrapresa con lucidità e convinzione dalla sua “seconda conversione”, egli ne è consapevole, lo conduce inevitabilmente a Roma.
La quadratura del cerchio
Tuttavia, prima di fare il passo definitivo, egli aspetterà ancora. La vanità della sua impresa che gli appare sempre più chiara, in realtà, invece di persuaderlo della giustezza del suo operato gli provoca un dramma interiore non indifferente.
Tutto il lavoro compiuto, tutti i suoi studi ed un forte impulso interiore lo portano ad un’unica conclusione: la Chiesa fondata da Cristo è e non può non essere che la Chiesa di Roma. Altrimenti bisognerebbe ritenere che Egli non abbia fondato nessuna Chiesa, ma questo è assurdo perché contraddice l’evidenza delle testimonianze storiche e delle Scritture. Che fare, dunque? Restare all’interno della Comunione anglicana o seguire il ragionamento e le evidenze da cui finora si era fatto guidare?
Il futuro Cardinale, come tutte le persone sagge, diffidava anzitutto di se stesso. Egli iniziava a ritenere che un cambiamento di comunione gli si imponesse come un obbligo di coscienza, ma non era giunto ancora al livello di maturazione in cui la decisione si fa necessaria. Ciò che lo frenava era il timore di un autoinganno, di un’illusione. Questo lo metteva, però, in uno stato di angoscia in cui la coscienza era sottoposta al richiamo di esigenze contradditorie tra cui non riusciva a scegliere.
In questo momento, dunque, sente fortemente l’esigenza di una direzione spirituale, non così comune in ambito anglicano, che affiderà al già citato canonico Keble. Questi, purtroppo, non aveva certamente le qualità necessarie per guidare un’anima del genere e quindi la direzione risultò inefficace.
Lo Spirito Santo, però, non lo abbandonava ed anzi, perché potesse essere più attento alle sue ispirazioni, lo spinse a ritirarsi dal mondo per vivere in campagna con alcuni amici, a Littlemore nei pressi di Oxford. Qui in un clima di silenzio, studio ed orazione, grazie ad una vita più austera e regolare, quasi monastica, egli era convinto di poter comprendere meglio quale fosse la volontà di Dio per lui.
Per l’opinione pubblica anglicana, scandalizzata dal Tract 90, il ritiro era una specie di sfida. Egli non faceva nulla per allontanare le voci di una sua conversione a Roma, ma nemmeno faceva nulla per far credere che questa potesse avvenire il giorno dopo.
Si era imposto di non prendere decisioni frettolose e a maggior ragione per la decisione di abbandonare Canterbury per Roma voleva avere la sicurezza di non cedere all’impulso delle passioni.
Il suo ritiro non era una diserzione, quindi, ma una solitudine ricercata. Egli voleva stabilirsi nella pace e nell’“indifferenza spirituale” tanto raccomandate dagli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola, che egli lesse e rilesse molte volte, per poter prendere ogni decisione con sicurezza.
Con il termine di “indifferenza” sant’Ignazio designa lo stato in cui l’anima non sente più nessuna attrattiva per qualcosa in particolare ma desidera ed è pronta a scegliere unicamente ciò che piace a Dio. Newman per raggiungere ciò aveva rotto con il mondo, con tutti i vincoli, gli onori delle cariche, gli affetti e i ricordi. Il costante e pressante invito ad unirsi alla Chiesa di Roma verso cui un tempo nutriva tutti i pregiudizi e le prevenzioni tipiche di un leale membro della Comunione anglicana lo percepiva come un segno ma, come già ribadito, non voleva cedere senza indugio e senza riflessione. Nelle sue lettere al direttore spirituale emerge questa tensione. Scrive infatti nel gennaio del 1845 al suo direttore: «L’unica questione è questa: posso io (la domanda è personale; non perciò qualcun altro, ma posso io) salvarmi l’anima nella Chiesa d’Inghilterra? Sono salvo, se dovessi morire stanotte? È un peccato mortale per me, se non passo ad un’altra comunione?».
Il ritiro silenzioso e la costante preghiera unite alla minuziosa ricerca attraverso la storia dei dogmi e della tradizione ecclesiastica gli forniscono ogni giorno maggiori argomenti in favore della scelta di Roma. Quello che egli più desidera è essere fedele alla verità, ma le argomentazioni da sole non bastano a portarlo a fare questo passo importante che gli costerà, dal punto di vista umano, moltissimo.
L’apologia della santità
Lo strumento che Dio aveva scelto per portalo finalmente nell’unico Ovile di Cristo fu il beato Domenico della Madre di Dio, al secolo Barberi. Questo religioso passionista originario di Viterbo con la sua testimonianza di una vita santa spesa unicamente per il bene delle anime, vissuta in semplicità ed umiltà, gli portò la sicurezza necessaria, quella che potremmo chiamare la “prova del nove della santità”. La grande conferma della verità del Cattolicesimo, oltre che dalle argomentazioni storico-teologiche, gli venne proprio dalla santità. Scriverà a questo proposito nel suo Diario intimo: «Considerando i santi di tutte le età come una sola compagnia, la Chiesa romana non è forse in definitiva dalla loro parte e non dall’altra? Ciò che mi ha molto impressionato in questi giorni è di scoprire la santità dei santi romani dopo la nostra separazione».
Più di tutti lo impressionò, però, la santità del beato Domenico. Fu proprio nelle sue mani che nell’ottobre del 1845, nella piccola cappella di Littlemore, fece la sua abiura e ricevette il Battesimo, ed amava definirsi «il suo convertito ed il suo penitente».
Abbracciando finalmente la Fede cattolica, confesserà di non aver provato emozioni particolari ma soltanto nelle profondità dell’anima «la più perfetta pace e tranquillità». Se non si manifestava quindi in un fervore sensibile, l’azione del Credo cattolico accolto finalmente nel cuore del grande convertito gli donò la pace e la certezza d’essere finalmente giunto dalle ombre e dalle immagini alla Verità, come avrebbe fatto scrivere sulla sua tomba.
Newman che si sente e si stima «inglese fino alle midolla» dichiara di essere venuto «non per discutere, ma per istruirsi». Entrando a poco a poco in seno ad un universo religioso di cui conosceva i principi fondamentali, ne scopre il lato quotidiano e familiare e l’impressione che ne riceve non lo delude affatto, trovandovi una fede popolare viva, semplice e seria. In questa esperienza egli riceve una lezione essenziale e cioè che, se le manifestazioni della pietà popolare cattolica possono essere molteplici, espansive e varie, trovano tutte il loro centro nel Sacrificio della Messa e nella Presenza reale. L’Eucaristia contribuisce così a rinsaldare la fede di Newman nella Provvidenza che l’avvolge e lo guida costantemente.
La conversione al Cattolicesimo, rivelandogli un Dio più vicino e più intimo, gli fa sentire ancora più pressante «la grande ombra della mano del Signore su di lui».
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale