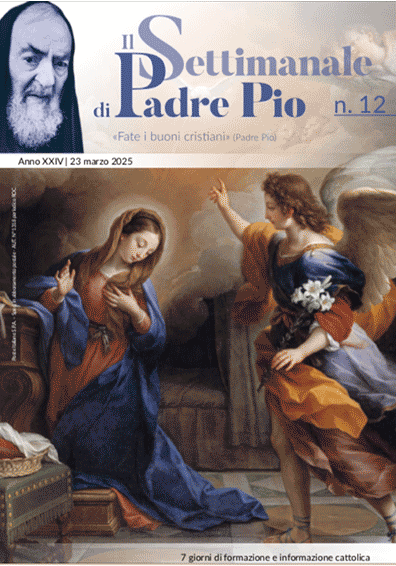Il beato Vincenzo Romano presto Santo
dal Numero 38 del 7 ottobre 2018
di Elena Nobis
Il 14 ottobre prossimo papa Francesco eleverà agli onori degli altari il beato Vincenzo Romano, esimio modello di sacerdote, predicatore e parroco, di cui cercheremo di ripercorrere, per sommi capi, le tappe salienti della vita e del suo ministero intensissimo.

In una ridente cittadina, situata alle falde del Vesuvio, Torre del Greco, il 3 giugno 1751 nasceva, forse penultimo di cinque figli, Domenico Michele Vincenzo Romano, da Nicola Romano e Grazia Rivieccio. I genitori, entrambi di umili origini ma provenienti da una famiglia pia, vollero che il piccolo fosse rigenerato al più presto alle acque della grazia. Così, l’indomani, lo condussero al fonte battesimale della parrocchia di Santa Croce.
Poté ricevere una solida formazione cristiana, intrisa di salda fede e pietà viva, già in famiglia, tanto da poterla considerare con ragione un’autentica “chiesa domestica”. Suo maestro ed educatore fu il dotto e pio sacerdote don Agostino Scognamiglio, il quale fu suo padrino al sacramento della Confermazione, che ricevé il 17 giugno 1758. Solo dopo aver completato la propria preparazione catechistica, intorno ai 10 anni, secondo le consuetudini del tempo, poté accostarsi per la prima volta alla Mensa eucaristica. Frequentava la Congregazione dell’Assunta, presso la quale recitava l’Ufficio della Madonna, e quella del Santissimo Sacramento, ove pregava l’Ufficio dei defunti.
Il padre avrebbe voluto avviarlo al mestiere dell’orefice, ma conosciuto il desiderio di Vincenzo di farsi prete, non vi si oppose. Dotato di ingegno e memoria non comuni, oltre che incline alla pietà e alla vita devota, avrebbe avuto tutte le “carte in regola” per entrare in Seminario, sennonché l’Arcivescovo respinse la sua domanda d’ammissione per l’elevato numero di seminaristi torresi e perché il clero locale era considerato in esubero. Vincenzo, però, oramai quattordicenne, non si dava per vinto. Si pensò addirittura di farlo entrare tra i Gesuiti, ma la Provvidenza dispose altrimenti. Il cardinale di Napoli, Antonio Sersale, infatti, temendo che divenisse un prete ozioso e su interessamento del duca Di Martino, accettò di accoglierlo in Seminario, previo un accurato esame, che Vincenzo superò brillantemente. Il rettore e i professori erano entusiasti di lui per la pietà e il profitto, e lo additavano ai compagni quale esempio da seguire.
A due anni dal suo ingresso in Seminario Vincenzo ebbe la grazia di poter ascoltare la novena dell’Assunta predicata da sant’Alfonso M. de’ Liguori presso la Basilica di Santa Restituta a Napoli, e s’infervorò ancora di più nei suoi santi propositi. Secondo i suoi compagni, due erano le caratteristiche che spiccavano in lui: la sua “fame eucaristica”, che gli aveva meritato l’appellativo di “scialone”, e la sua dolcezza scontrosa per cui lo soprannominavano anche “pecora stizzita”.
Per l’eccellente profitto e per la condotta esemplare, i superiori gli affidarono il compito di dare ripetizioni nelle materie letterarie a “quelli che zoppicavano”, e fu anche nominato prefetto di una camerata.
Ben presto ricevé la tonsura con la retta intenzione di dar gloria a Dio ch’è l’anima di ogni azione buona; tra la Pentecoste e il Natale del 1769 prese i quattro Ordini minori “per servire Dio e la Chiesa”. Il 13 giugno 1772 fu fatto suddiacono, impegnandosi col vincolo della castità perfetta per il Regno dei cieli. Il 5 giugno 1773 fu ordinato Diacono, divenendo così dispensatore della Parola e dell’Eucaristia. Il 10 giugno 1775, a soli 24 anni, monsignor Giacomo Onoratolo lo ordinava sacerdote nella Basilica di Santa Restituta a Napoli.
Celebrò la sua prima Messa l’11 giugno 1775 presso la chiesa parrocchiale di Santa Croce “senza apparato”, tuttavia la notizia si sparse rapidamente, tanto che la chiesa era gremita di gente. Alcuni dei testimoni, per l’edificazione che ne riportarono, dicevano di lui: «Sembra un santo». E una cosiddetta monaca di casa, ossia una donna che faceva voto di verginità e si consacrava alla preghiera e al servizio di Dio pur restando nella propria abitazione, asseriva di aver udito una voce angelica affermare: «Non c’è prete più santo di questo che è uscito a dire la Messa».
S’impegnò talmente nell’esercizio del suo ministero da meritarsi gli appellativi di “faticatore zelante”, “celebre faticatore” e “operaio instancabile”. Un teste dichiarò addirittura che «nella cura delle anime sembrava che avesse fatto il voto di non perdere mai tempo». Inoltre, su consiglio del proprio direttore di spirito, aprì in casa una scuola gratuita per i giovani torresi, avviandoli nello studio e nelle vie del Signore. Dai suoi alunni esigeva, infatti, disciplina, studio metodico e preghiera fervente. La lezione mattutina si apriva con una breve meditazione e la visita al Santissimo Sacramento chiudeva la giornata. L’aula recava numerose scritte, contenenti perlopiù massime bibliche inerenti ai Novissimi. Oltre alla scuola per laici don Vincenzo, con l’approvazione dell’Arcivescovo, teneva scuola ai seminaristi e si prendeva cura anche degli aspiranti al Seminario. I frutti del suo insegnamento erano tali che l’avrebbero voluto come professore al Seminario di Napoli, ma l’Arcivescovo non volle per non privare Torre del Greco di un simile insegnante.
La sua attenzione era rivolta anche alle classi più povere, in particolare agli abitanti delle zone rurali: il pensiero che costoro tralasciassero la Messa domenicale lo tormentava. Così, per ben tre anni, la domenica celebrò in una cappella rurale e istruiva i fedeli non soltanto sul Vangelo, ma cercando di trasmetter loro almeno i primi elementi della Dottrina cristiana. Avrebbe continuato ancora questo prezioso apostolato se la volontà di Dio non l’avesse chiamato a diventare il padre spirituale della Congrega dell’Assunta, una confraternita che contava ben 300 membri. Oltretutto fu nominato cappellano festivo delle monache teresiane, senza tralasciare la sua preziosa collaborazione come confessore presso la parrocchia della Santa Croce e la Congrega del Santissimo Sacramento. Fu instancabile anche nell’assistenza di malati e moribondi, per i quali si adoperava senza curarsi della propria salute. Una volta per assistere un malato affetto da malattia contagiosa mise senza esitazione a repentaglio la sua vita, e di sicuro non sarebbe sopravvissuto se la popolazione intera non ne avesse implorato la guarigione dal Signore.
Determinante, poi, fu il sostegno spirituale e materiale che offrì in occasione della terribile eruzione del Vesuvio del 15 giugno del 1794, la quale sommerse di lava e ceneri buona parte della città: anche la chiesa della Santa Croce fu sommersa completamente dalla lava e il campanile per metà. La casa di don Vincenzo, invece, era rimasta indenne. In quei giorni il santo Sacerdote passava benedicendo, confortando, ravvivando le speranze e offrendo i primi soccorsi alla popolazione. Si poneva il problema, infatti, di ricostruire quasi completamente Torre del Greco. Alcuni testi dichiararono che animò i fedeli «col suo esempio a prendere pietre, terreno, cemento [...] e trasportarlo sui propri omeri per gettare le fondamenta dell’Opera gigante». Inoltre, anche in quell’occasione i testimoni attestarono che «non si vide mai turbato, mai disanimato, ma sempre ilare e pieno di fiducia». Allora, l’anziano parroco, don Gennaro Falanga, propose all’Arcivescovo di nominare don Vincenzo quale nuovo parroco della chiesa di Santa Croce. Solo don Vincenzo, secondo lui, sarebbe stato in grado di far fronte ad una situazione del genere. Naturalmente il nostro Santo, nella sua grande umiltà, chiese di essere esonerato dall’incarico, ma inutilmente: su questo punto l’Arcivescovo fu irremovibile. «Avrei voluto piuttosto la morte – scrive don Vincenzo stesso – che aggravarmi di questo sì pericoloso peso della cura delle anime; questa carica non si può accettare né per onore, né per interesse o per altro fine, ma soltanto per volontà di Dio». Il suo ministero lo viveva nell’abbandono più totale in Dio, consapevole di essere soltanto uno strumento di cui il Signore si serviva per la salvezza delle anime: «Signore – leggiamo nei suoi scritti –, niente io posso, niente io sono, niente io so, la Cura è vostra, sulla vostra parola, come san Pietro, io mi getto in questo mar... O Gesù, io sono l’asinello sotto di Voi, Voi guidatemi, Voi tiratemi, Voi regolatemi».
Se in don Vincenzo, dunque, rifulsero in modo particolare le virtù dell’umiltà e della carità – verso Dio con la sua preghiera incessante e verso il prossimo da soccorrere anzitutto spiritualmente ma anche materialmente –, possiamo dire con certezza che praticò in grado eroico anche le virtù teologali della fede e della speranza. «La speranza – insegnava il Santo ai sacerdoti dubbiosi – è il maggior bene della nostra vita mortale nell’assedio di tanti mali: asciuga le lacrime, alleggerisce le fatiche, rinvigorisce la debolezza, cura le piaghe. Dovremmo riporre fiducia solo in Dio, ché il temporale ci sarà dato per sovrappiù se cercheremo prima il Regno di Dio».
Non ci soffermeremo volutamente sulla sua vita di preghiera, specie sulla sua pietà eucaristica e mariana che, proprio perché praticate anch’esse in grado eccelso, meritano una trattazione a parte.
Tutto il suo programma pastorale si compendiava, si può dire, in queste parole: «Gesù deve essere il nostro esemplare e modello e libro: in Lui dobbiamo ogni giorno studiare l’umiltà, da Lui copiare tutte le virtù. Se così saremo simili a Lui in terra, saremo poi simili in cielo vedendolo a faccia scoperta». E ai confratelli insegnava: «Questo è il compendio di tutta la perfezione di un sacerdote: questo ne costituisce la felicità e la gloria: imitare Gesù Cristo, seguire l’orme di Gesù Cristo, vestirsi di Gesù Cristo, essere una viva copia di Gesù Cristo, fare in sé un vivo ritratto di Gesù Cristo che vive, che parla, che opera, che patisce, e proporlo agli altri a rispettarlo, amarlo, ad imitarlo». E, secondo le testimonianze, fu davvero «un pastore secondo il cuore di Dio e una vera immagine di Gesù Cristo, principe dei Pastori». Il suo ardentissimo zelo per la salvezza delle anime non gli consentiva soste: predicazione, opere di bene e doveri di ministero si succedevano a ritmi talvolta incalzanti, senza soluzione di continuità. Difatti dormiva abitualmente 3-4 ore d’estate e 5 d’inverno.
Il 1° gennaio 1825, però, una durissima prova l’attendeva: mentre si affrettava ad uscir di casa per andare a celebrare la Santa Messa, cadde rompendosi il femore. Fu chiamato d’urgenza un chirurgo da Napoli, ma solo dopo alcuni mesi poté camminare, trascinandosi faticosamente sulle grucce fino in parrocchia con l’aiuto di un fedele. Così continuò l’esercizio del suo ministero per ben cinque anni, sforzandosi di non tralasciare in alcun modo le sue numerose attività pastorali.
IL 2 febbraio le sue condizioni peggiorarono: mentre celebrava la Santa Messa svenne. Portato immediatamente a casa, non fu più in grado di alzarsi dal letto. Pur completamente allettato, tuttavia, non cessava di dare insegnamenti con le sue massime e il suo atteggiamento esemplare. Ai sacerdoti che cercavano di recargli conforto diceva: «Bisogna guardare le tribolazioni con l’occhio della fede, non con la ritrosia della carne. Se così si guardassero le tribolazioni come venute dalla mano di Dio, formerebbero la felicità dell’uomo sulla terra». E al medico ripeteva: «Sono l’uomo del dolore, ma sia sempre benedetto Iddio che me le ha mandate».
Durante la novena di Natale del 1831 il suo stato di salute si aggravò ulteriormente. Colpito da polmonite, subito si dispose a ricevere gli ultimi Sacramenti con grandissimo fervore e rassegnazione. Congedò i sacerdoti convenuti al suo capezzale, lasciando loro una sorta di testamento spirituale: «Pregate il Signore che mi dia la grazia di fare un buon passaggio; non abbiamo qui una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura; conservate la carità fraterna; è venuto il tempo, debbo morire». Fu il suo Nunc dimittis. L’Arcivescovo, subito informato, gli inviò la pastorale benedizione.
La sua ultima notte avrebbe gradito l’assistenza del nipote don Felice, ma questi, vinto dal sonno si addormentò. Un altro sacerdote presente, allora, tentò d’imitarne la voce, ma don Vincenzo se ne accorse e lo riprese severamente: «Perché dite la bugia? La bugia è sempre peccato. Voi non siete mio nipote». E poiché questi tentò di scusarsi, dicendo che don Felice riposava, gli rispose: «Ebbene dite: sta riposando».
All’alba del 20 dicembre 1831, dopo aver ricevuto la benedizione in articulo mortis e le indulgenze dell’Abitino del Carmine, il santo Curato torrese tra gli spasimi della morte diceva: «O mio Gesù! Gesù mio, siatemi salvatore. Nelle tue mani raccomando il mio spirito». Infine, lasciava questa terra, mormorando i dolcissimi nomi di Gesù e Maria.
- 1 Alla scuola della Sacra Famiglia
- 2 Un santo 2025? “Vademecum” spirituale per non perdere la rotta
- 3 Il Natale e l’Eucaristia Il piccolo Agnello nato a Betlemme
- 4 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 5 Maria è mia Madre
- 6 Lo sposalizio della Beata Vergine Maria e il sacramento del Matrimonio
- 7 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 8 Tra terra e Cielo San Pio e il tempo natalizio