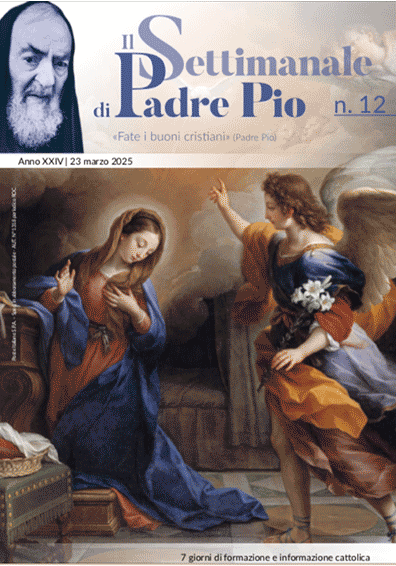Il “male intrinseco”: non è lecito fare il male a scopo di bene
dal Numero 35 del 9 settembre 2018
di Suor M. Gabriella Iannelli, FI
San Giovanni Paolo II ha autorevolmente affermato che esistono azioni e comportamenti che per la loro specie morale sono sempre cattive (intrinsecamente cattive) per il loro oggetto, indipendentemente dalle intenzioni e circostanze.

L’uomo dimostra ciò che è attraverso ciò che sceglie di fare: «Gli atti umani sono atti morali, perché esprimono e decidono della bontà o malizia dell’uomo stesso che compie quegli atti» (n. 71). Sono le scelte deliberate che qualificano moralmente la persona che le compie e ne determinano la fisionomia spirituale profonda (cf. n. 71). Da che cosa dipende la bontà o malizia di un atto umano? San Giovanni Paolo II risponde nella sua enciclica Veritatis splendor affermando che «l’agire è moralmente buono quando le scelte della libertà sono conformi al vero bene dell’uomo ed esprimono così l’ordinazione volontaria della persona verso il suo fine ultimo, cioè Dio stesso: il bene supremo nel quale l’uomo trova la sua piena e perfetta felicità [...]. L’ordinazione razionale dell’atto umano al bene nella sua verità e il perseguimento volontario di questo bene, conosciuto dalla ragione, costituiscono la moralità» (n. 72).
Come è stato ribadito diverse volte dal Santo Padre la Legge divina, naturale e positiva, esprime ciò che bisogna fare per operare il bene ed evitare il male: «Il cristiano, grazie alla rivelazione di Dio e alla fede, conosce la “novità” da cui è segnata la moralità dei suoi atti» (n. 73).
Una volta fatte queste premesse il Papa passa ad esaminare alcune teorie etiche denominate teleologiche per le quali il criterio per valutare la moralità di un atto sarebbe il fine perseguito dall’agente e i valori da lui intesi. In altri termini «il comportamento concreto di una persona sarebbe giusto, o sbagliato, a seconda che possa, o non possa, produrre uno stato di cose migliore per tutte le persone interessate: sarebbe giusto il comportamento in grado di “massimizzare” i beni e di “minimizzare” i mali» (n. 74). Nello sforzo di elaborare una morale razionale, scrive il Papa, si arriva a «false soluzioni», come quelle del «consequenzialismo», che pretende di ricavare i criteri della giustezza di un comportamento, dalle conseguenze che ne derivano, o il proporzionalismo che prende in esame la proporzione tra gli effetti buoni e cattivi. Queste teorie arrivano alla soluzione che «non si possa mai formulare una proibizione assoluta di determinati comportamenti» pure se questi sono in contrasto con i valori morali indicati dalla ragione e dalla Rivelazione (legge divina naturale e positiva)» (cf. n. 75). «Sulla specificità morale degli atti, ossia sulla loro bontà o malizia, deciderebbe esclusivamente la fedeltà della persona ai valori più alti della carità e della prudenza, senza che questa fedeltà sia necessariamente incompatibile con scelte contrarie a certi precetti morali particolari. Anche in materia grave...» (n. 75). Il Papa con la sua caratteristica chiarezza e decisione afferma categoricamente che «siffatte teorie non sono fedeli alla dottrina della Chiesa, allorché credono di poter giustificare, come moralmente buone, scelte deliberate di comportamenti contrari ai comandamenti della legge divina e naturale».
L’errore di queste teorie sta nel prendere in considerazione l’intenzione e le conseguenze dell’azione, senza tenere abbastanza conto dell’oggetto dell’atto. Spiega il Papa: «Sono certamente da prendere in grande considerazione sia l’intenzione – come insiste con una forza particolare Gesù in aperta contrapposizione agli scribi e farisei, che minuziosamente prescrivevano certe opere esteriori senza badare al cuore, sia i beni ottenuti e i mali evitati a seguito di un atto particolare. Si tratta di un’esperienza di responsabilità. Ma la considerazione di queste conseguenze – nonché delle intenzioni – non è sufficiente a valutare la qualità morale di una scelta concreta. [...]. Le conseguenze prevedibili appartengono a quelle circostanze che, se possono modificare la gravità di un atto cattivo, non possono però cambiarne la specie morale. La moralità dell’atto umano dipende anzitutto e fondamentalmente dall’oggetto ragionevolmente scelto dalla volontà deliberata» (nn. 77, 78). Vi sono azioni e comportamenti che per la loro specie morale sono sempre cattivi, o in altri termini, sono «intrinsecamente cattivi», per il loro oggetto, indipendentemente dalle intenzioni e dalle circostanze.
La Chiesa ha sempre insegnato l’esistenza di atti intrinsecamente cattivi, basandosi sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione, e ne ha dato anche delle ampie esemplificazioni. San Paolo afferma in modo categorico: «Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il Regno di Dio» (1Cor 6,9-10). Sant’Agostino, parlando anche egli in termini concreti, scrive: «Quanto agli atti che sono per se stessi dei peccati (cum iam opera ipsa peccata sunt), come il furto, la fornicazione, la bestemmia, o altri atti simili, chi oserebbe affermare che compiendoli per buoni motivi (causis bonis), non sarebbero più peccati o, conclusione ancora più assurda, che sarebbero peccati giustificati?».
Insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica che «vi sono comportamenti concreti che è sempre sbagliato scegliere, perché la loro scelta comporta un disordine della volontà, cioè un male morale». San Tommaso d’Aquino scrive che «nessun male compiuto con buona intenzione può essere scusato». Parlando delle pratiche contraccettive Paolo VI afferma: «In verità, se è lecito, talvolta tollerare un minor male morale al fine di evitare un male maggiore o di promuovere un bene più grande, non è lecito, neppure per ragioni gravissime, fare il male, affinché ne venga il bene, cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente disordine e quindi indegno della persona umana, anche se nell’intento di salvaguardare e o promuovere beni individuali, familiari o sociali» (cf. nn. 79, 80, 81).
La conclusione a tale argomentazione non può che essere la seguente: «Le circostanze e le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo oggetto in un atto “soggettivamente” onesto o difendibile come scelta» (n. 81).
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale