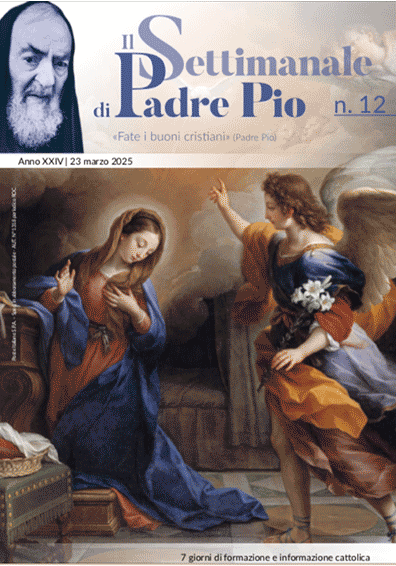Il sacrario dell’uomo: la coscienza
dal Numero 24 del 17 giugno 2018
di Suor M. Gabriella Iannelli, FI
Davvero utile è oggi affrontare l’argomento della “coscienza” per divincolarsi da concezioni fuorvianti, ponendosi alcune domande: può la coscienza personale legittimare in alcuni casi ciò che la Legge divina considera “intrinsecamente cattivo”? Il Magistero è un aiuto o un ostacolo alla formazione di una coscienza matura? La coscienza può errare?

Nei paragrafi 54-64 dell’enciclica Veritatis splendor il Santo Padre Giovanni Paolo II argomenta sul tema della coscienza, ricollocandola al posto che le ha sempre assegnato la Dottrina morale e dissipando ancora una volta le ambiguità e le deviazioni che si sono avute riguardo alla funzione di essa nella vita di ciascun uomo. Egli denuncia subito, all’inizio del paragrafo 54, delle tendenze culturali proprie del mondo moderno che, esaltando «in modo idolatrico la libertà, conducono ad un’interpretazione “creativa” della coscienza morale, che si allontana dalla posizione della tradizione della Chiesa e del suo Magistero».
Cosa è la coscienza? Risponde il Concilio Vaticano II nella Gaudium et spes: «È il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria. Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa’ questo, fuggi quest’altro» (n. 16). La coscienza dunque scopre in sé un dettame divino, una legge che è quella insita nella natura umana, e permette di applicarla ai casi concreti in cui ci si trova ad operare. È strettamente collegata alla legge naturale, ma non si identifica con essa, come spiega il Papa: «Mentre la legge naturale mette in luce le esigenze oggettive e universali del bene morale, la coscienza è l’applicazione della legge al caso particolare, la quale diventa così per l’uomo un interiore dettame, una chiamata a compiere nella concretezza della situazione il bene. La coscienza formula così l’obbligo morale alla luce della legge naturale: è l’obbligo di fare ciò che l’uomo, mediante l’atto della coscienza, conosce come un bene che gli è assegnato qui e ora» (n. 59).
Per il valore assoluto e creativo che alcuni teologi danno alla coscienza, essa dovrebbe poter prendere decisioni personali, senza essere condizionata da norme e leggi le quali non possono abbracciare tutti i singoli atti concreti delle persone. Le norme morali non sarebbero un criterio oggettivo vincolante per formulare giudizi giusti, ma sarebbero solo una prospettiva generale che aiuta in prima approssimazione l’uomo nel dare un’ordinata sistemazione alla sua vita personale e sociale. In tale contesto c’è chi ritiene che la creatività e la maturazione della coscienza sarebbe ostacolata anche dalla posizione troppo categorica che, in molte questioni morali, assume il Magistero della Chiesa, i cui interventi sarebbero causa, presso i fedeli, dell’insorgere di inutili conflitti di coscienza (cf. n. 55). «Per giustificare simili posizioni – spiega il Papa – alcuni hanno proposto una sorta di duplice statuto della verità morale. Oltre al livello dottrinale e astratto, occorrerebbe riconoscere l’originalità di una certa considerazione esistenziale più concreta. Questo, tenendo conto delle circostanze e della situazione, potrebbe legittimamente fondare delle eccezioni alla regola generale e permettere così di compiere praticamente, con buona coscienza, ciò che è qualificato come intrinsecamente cattivo dalla legge morale. In tal modo si instaura in alcuni casi una separazione, o anche un’opposizione, tra la dottrina del precetto valido in generale e la norma della singola coscienza, che deciderebbe di fatto, in ultima istanza, del bene e del male. Su questa base si pretende di fondare la legittimità di soluzioni cosiddette “pastorali” contrarie agli insegnamenti del Magistero e di giustificare un’ermeneutica “creatrice” secondo la quale la coscienza morale non sarebbe affatto obbligata, in tutti i casi, da un precetto negativo particolare» (n. 56).
La vera natura della coscienza, con l’obbligo morale che essa comporta, è ben distante da questo falso concetto di una coscienza creativa, che arriva persino “a decidere del bene e del male”, legittimando “soluzioni pastorali contrarie al Magistero della Chiesa”.
Per riaffermare il vero concetto di coscienza, il Papa nei numeri 57-63 ripresenta tutta la teologia morale tradizionale inerente ad essa. La coscienza «pone l’uomo di fronte alla legge, diventando essa stessa testimone per l’uomo: testimone della sua fedeltà o infedeltà nei riguardi della legge, ossia della sua essenziale rettitudine e malvagità morale» (n. 57). La coscienza è «un giudizio morale sull’uomo e sui suoi atti: è un giudizio di assoluzione o di condanna. [...]. Il giudizio della coscienza è un giudizio pratico, ossia un giudizio che intima che cosa l’uomo deve fare o non fare, oppure che valuta un atto da lui ormai compiuto. È un giudizio che applica a una situazione concreta la convinzione razionale che si deve amare e fare il bene ed evitare il male» (n. 59).
La coscienza, per svolgere questa funzione, deve essere retta. Ogni persona deve formarsi una «buona coscienza» con la ricerca della verità, con la luce dello Spirito Santo, con quella purezza di intenzione che non falsa la parola di Dio ma vi aderisce cercando di «discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2) (cf. n° 62). La coscienza «non è un giudice infallibile: può errare». È il caso della coscienza erronea, che può essere tale per ignoranza invincibile o per errore colpevole. L’ignoranza invincibile è un’ignoranza di cui il soggetto non è consapevole e da cui non può uscire da solo. In tal caso la coscienza non perde la sua dignità e il male commesso può non essere imputabile alla persona che lo compie, ma anche in tal caso esso non cessa di essere un male, un disordine che non contribuisce alla crescita morale della persona (cf. n. 63).
La coscienza, invece, compromette la sua dignità quando è colpevolmente erronea ossia «quando l’uomo non si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all’abitudine al peccato» (Gaudium et spes, n. 16). La coscienza erronea non è più in grado di formulare un giudizio morale giusto. Per questo è di primaria importanza formare la coscienza con la conoscenza della legge divina e con la pratica delle virtù; essa, infatti, diventa erronea per l’abitudine al peccato. È quindi assolutamente necessario formare la coscienza e renderla oggetto di continua conversione alla verità e al bene. Il Magistero della Chiesa con la sua «dottrina sacra e certa» costituisce «un grande aiuto per la formazione della coscienza». Quando la Chiesa si pronuncia su questioni morali, non intacca in alcun modo la libertà di coscienza dei cristiani, ma svolge solo una funzione a servizio della coscienza, aiutandola a non essere portata qua e là da qualsiasi vento di dottrina secondo l’inganno degli uomini (cf. Ef 4,14), a non sviarsi dalla verità circa il bene dell’uomo, ma, specialmente nelle questioni più difficili, a raggiungere con sicurezza la verità e a rimanere in essa (cf. n. 64).
La “Dottrina sacra” insegnata attraverso il Magistero perenne, partendo dai primi secoli di vita della Chiesa, ha illuminato le epoche con la luce del Vangelo, dirigendo e formando le coscienze al vero bene personale e collettivo, individuale e sociale, mai smentendosi, mai contraddicendosi, ma rimanendo sempre come punto fermo e indefettibile in mezzo alle tempeste che hanno scosso la Chiesa stessa e l’umanità tutta.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale