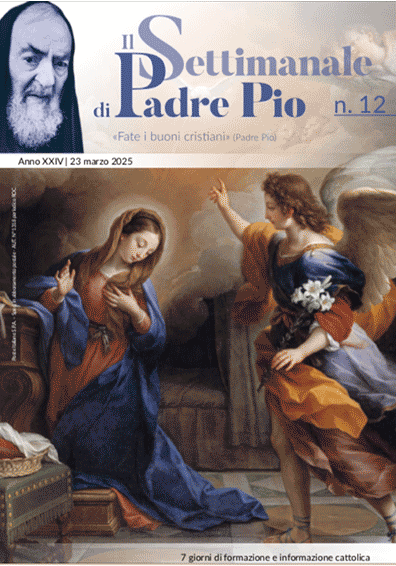Gli “atti senza testimoni”
dal Numero 23 del 10 giugno 2018
di Giovanni Apollinare
Provare vergogna per un male compiuto, anche senza che nessuno ne sia testimone, è un’esperienza comune ad uomo ed è la base sulla quale può fondarsi una coscienza morale autentica...

Il medico missionario protestante Albert Schweitzer, in La mia vita e il mio pensiero, ricorda l’istante in cui per la prima volta provò vergogna di se stesso. Aveva circa tre anni, e giocava nel giardino. Venne un’ape e lo punse su un dito. Quando cominciò a piangere, fu soccorso dai genitori e da alcuni vicini. Da subito, il piccolo Albert percepì che il dolore era già passato da alcuni minuti e che egli continuava a piangere solo per ottenere l’attenzione della platea. Quando raccontava il caso, Schweitzer era settuagenario. Aveva una vita realizzata come artista, medico, filosofo e fondatore di un ospedale in Africa, per soccorrere i poveri ammalati. Ma sentiva ancora vergogna per quella prima frottola. Quel sentimento attraversava gli anni, nel fondo della memoria, dandogli un senso di repulsione nella coscienza, a fronte di ogni nuova tentazione di auto-inganno.
Si noti, che nessuno aveva percepito nulla. Solo il bambino Albert sapeva della sua vergogna, solo lui doveva dar conto di quell’atto davanti alla sua coscienza, e a Dio.
Sono convinto che le esperienze di questo tipo – che di solito chiamo “atti senza testimoni” – sono l’unica base possibile sulla quale l’uomo possa sviluppare una coscienza morale autentica, rigorosa e libera nella verità. Solo chi, nella solitudine, sa essere rigoroso e giusto con se stesso – e contro se stesso –, è capace di giudicare gli altri con giustizia, invece di lasciarsi portare dai gridi della folla, dagli stereotipi della propaganda, dal proprio interesse camuffato con eleganti pretesti morali.
La ragione di questo è auto-evidente: un uomo deve essere libero da tutta la “fiscalizzazione” culturale esterna, per avere la certezza che guarda in se stesso e non a un ruolo sociale; solo allora, potrà fare un giudizio totalmente sincero. Solo chi è signore di se stesso, è libero, e nessuno è signore di se stesso se gli rincresce di guardare, in solitudine, dentro il suo cuore.
Neppure la conversazione più sincera e la confessione più spontanea possono sostituire questo esame interiore, perché quelle valgono solo come espressioni di questo, senza del quale sono solo effusioni passeggere, indotte da un’atmosfera casualmente stimolante, o per un “sincerismo” vanitoso.
Il “rientrare in se stessi” è allo stesso tempo vicinanza e allontanamento: il giudizio emesso nella solitudine della propria interiorità crea la vera intimità dell’uomo con se stesso, e crea anche la distanza, lo spazio interiore in cui le esperienze vissute e le conoscenze acquisite, sono assimilate, approfondite e personalizzate, alla luce della Verità. Senza questo spazio, senza questo mondo personale conquistato nella solitudine, l’uomo è solo un tubo per il quale entrano e escono le informazioni – come gli alimenti – trasformati in detriti.
Ora, non tutti furono benedetti dalla Provvidenza, con la percezione spontanea e il giudizio certo dei propri peccati. Senza questi doni, il desiderio di giustizia si perverte nell’incolpare gli altri – proiettando su di essi anche le proprie responsabilità –, e nella “razionalizzazione”, nel senso psicanalitico del termine. Chi non ha ricevuto questi doni dalla Provvidenza, li deve ricevere dall’educazione.
L’educazione morale, dunque, consiste primariamente nel creare un ambiente morale propizio all’auto esame, alla serietà interiore, alla responsabilità del sapere quello che uno fa, quando non c’è nessuno che lo guarda, alla luce della Verità e, solo dopo, nel memorizzare le liste del “giusto” e dello “sbagliato”.
Durante i millenni, un ambiente così fu creato e sostenuto dalla pratica cristiana dell’esame di coscienza. Ci sono pratiche analoghe anche in altre tradizioni religiose, ma non c’è nulla di simile nella cultura laica contemporanea. C’è la psicoanalisi, la psicoterapia, ma si pongono sulla linea dell’esame di coscienza solo quando conservano la relazione religiosa alla colpa personale e al suo riscatto tramite la confessione davanti a Dio, e al suo ministro. Nella misura in cui la società si scristianizza, questo riferimento religioso si dissolve e le tecniche cliniche tendono a produrre l’effetto opposto: abolire il senso di colpa, convertendolo ora in un indurimento egoista – confuso con la maturità – ora con una adattabilità auto compiacente, sfibrata e insulsa – confusa con la salute.
La differenza tra la pratica religiosa e i suoi succedanei moderni è che quella sintetizzava, in un’unica intensa esperienza, il dolore della colpa e la gioia della completa liberazione; cosa che le “etiche laiche” non possono fare, né lo potrebbero, perché manca loro la dimensione del Giudizio finale e il confronto con un destino eterno che, dando a tale esperienza un significato metafisico, eleva l’anelito della responsabilità personale alle altezze di una nobiltà spirituale che le esteriorità dell’“etica cittadina” non possono nemmeno sognare.
Da due secoli a questa parte, la cultura moderna sta facendo quello che può per debilitare, soffocare ed estinguere nell’anima di ogni uomo la capacità di questa esperienza suprema, nella quale soltanto la persona può acquisire l’autentica misura della sua condizione e dei propri doveri in ordine all’Assoluto, propri della natura umana. L’etica laica e l’educazione civica è quello che rimane all’esterno, quando la coscienza interiore ammutolisce e quando le azioni dell’uomo non significano altro che “obbedienza” o “infrazione” di un codice convenzionale di interessi casuali.
L’etica laica diventa, così, puro adattamento esteriore, senza alcuna risonanza intima, se non quella che si possa ottenere per l’internalizzazione forzata di slogan, frasi fatte e parole d’ordine.
Questa etica laica è il sacrificio della coscienza sull’altare della menzogna ufficiale del giorno.
* Il materiale utilizzato per la stesura del presente articolo è stato tratto, tradotto e rielaborato da: Olavo de Carvalho, O minimo..., Edizioni Record, San Paolo 2015, pp. 41-43.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale