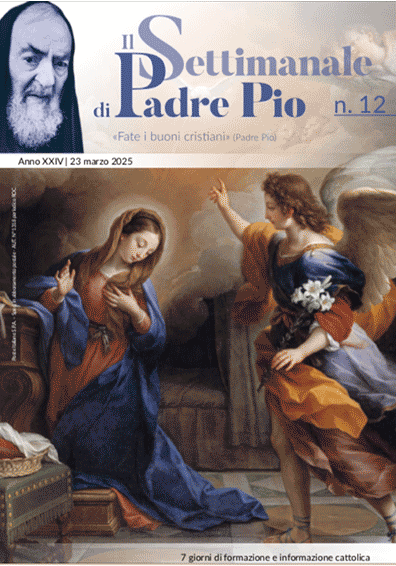Cisneros: “El santo Cardenal”
dal Numero 49 del 17 dicembre 2017
di Moisé Piave
L’8 novembre 1517 moriva in concetto di santità il cardinale francescano Francisco de Cisneros. Vissuto nella Spagna del XV secolo, risulta affatto sconosciuto; offriamo qualche notizia per sollevare almeno parzialmente dall’ingiusto oblio a cui è stata condannata questa luminosa figura di cardinale, religioso e statista.

Un anniversario tra gli anniversari
Quest’anno, il 2017, ricorrono diversi anniversari pregni di significato. Certamente ai lettori del Settimanale il primo che verrà alla mente, per la preziosa ed amplissima trattazione fattane, sarà il centenario di Fatima. Oltre alla grandiosa Mariofania, però, vanno certamente ricordati anche altri anniversari molto meno piacevoli, ma non certo slegati da quest’ultimo. Tra essi il più recente ed infausto è il centenario della Rivoluzione russa che ha segnato l’avvento del comunismo al potere e gettato per circa settant’anni nell’ateismo di Stato metà del pianeta, facendo più morti e più martiri (tra gli ottanta ed i cento milioni) di quanti ce ne fossero stati in tutta la storia del Cristianesimo e lasciando dietro a sé un deserto spirituale. Vi sono poi i trecento anni della fondazione della perniciosissima setta segreta che va sotto il nome di “Massoneria” e, pessimo tra tutti per le sue conseguenze, il quinto centenario della Rivoluzione protestante scatenata dal monaco Martin Lutero. Il figlio degenere di sant’Agostino, purtroppo, in preda alle passioni ha diviso la cristianità occidentale, trascinando nelle braccia del diavolo e nella peggiore abiezione morale con il suo delirante «pecca fortiter et crede fortius» (pecca fortemente e credi ancora più fortemente) metà dell’Europa. E proprio a quest’ultimo, purtroppo, va ascritta l’origine, seppure remota, degli altri infelici eventi sopra ricordati.
Anche se è sempre vero il detto che “con i se e con i ma la storia non si fa” è verosimile, infatti, ritenere che nessuno dei nefasti eventi suddetti si sarebbe realizzato senza il primo, in quanto non si può non individuare il filo rosso della causalità tra i vari avvenimenti. La separazione tra fede e ragione (che egli definiva la «prostituta del diavolo») tra Stato e Chiesa, ed anzi l’asservimento totale di quest’ultima al primo, sono tutti frutti delle celebri “novantacinque tesi” che egli affisse la vigilia della festa di Ognissanti di cinquecento anni fa sulla porta della cattedrale di Wittenberg. Non è questo, però, il luogo per entrare nel merito di queste “tesi” che, peraltro, oggi non interessano più a nessuno se non a qualche cattolico fuori strada. Qui ci limitiamo a dire che se l’albero si giudica dai frutti, come ha insegnato Nostro Signore, non c’è bisogno di un grande sforzo per comprendere quanto sia nocivo quello di Lutero. Tra tutti questi eventi amari e tristi ci teniamo a ricordarne, però, uno – certamente non l’unico – positivo. L’8 novembre 1517 (lo stesso giorno della morte di un’altra gloria dell’Ordine serafico, il beato Giovanni Duns Scoto), infatti, moriva in concetto di santità ad ottantun anni il cardinale Francisco Ximenez de Cisneros.
Da Torrelaguna a Salamanca... fino a Roma
Ai più, almeno in Italia (per quanto ne sappiamo non esiste ancora una sua biografia in italiano), questo grande uomo risulta affatto sconosciuto ed invece fu un gigante sotto tutti gli aspetti. Cercheremo quindi di dare qualche notizia per sollevare almeno parzialmente dall’ingiusto oblio a cui è stata condannata questa luminosa figura di cardinale, di riformatore, di statista, di biblista ma, prima di tutto e sopra tutto, di degno figlio del Serafico Poverello d’Assisi. Fu proprio in onore di san Francesco, infatti, che volle prendere il nome di Francisco, all’ingresso in Religione, alla veneranda età di quarantotto anni.
Ximenez de Cisneros nacque nel 1436 a Torrelaguna, nei pressi di Madrid, da una famiglia dalla origine nobile, ma dalla fortuna modesta, ricevendo il giorno stesso il nome di Gonzalo al sacro Fonte. Il padre consumò tutto ciò che rimaneva alla famiglia per l’istruzione dei figli e per questo fu costretto a riprendere l’esercizio della professione di avvocato, cosa inusuale per un nobile, per poterla mantenere. Come molti del suo tempo anche Gonzalo fu sin da piccolo destinato allo stato ecclesiastico ed avviato prima allo studio della Grammatica e poi, al compimento del quattordicesimo anno di età, del Diritto civile e canonico presso la prestigiosa Università di Salamanca, l’Atene spagnola. Terminato brillantemente il corso di studi, ed ordinato sacerdote, rientrò alla casa paterna, lasciandola, però, ben presto per il timore di pesare sulle già precarie condizioni della famiglia. Non aveva, infatti, un incarico che gli potesse fruttare una qualche rendita. Decise, così, di recarsi a Roma che, con la sua fama ed imponenza, costituiva un’avvincente attrazione per la sua immaginazione, nonostante le difficoltà ed i costi che il viaggio comportava, specialmente per un uomo dalla modesta condizione come la sua. Qui si mantenne esercitando la sua professione di avvocato per la Curia romana. A quel tempo, infatti, quella che era ancora nota come “Christianitas”, ed era uno dei frutti più belli del Medioevo, nonostante la divisione politica tra le varie “nationes” funzionava ancora come un unico grande paese in cui grazie ad una lingua comune – il latino – e ad una cultura comune – data dalla religione cattolica – ci si poteva sentire “a casa” ed esercitare la propria professione o studiare all’università in qualsiasi luogo, dalla Polonia al Portogallo, dalla Scozia alla Sicilia.
Non rimase però, il Cisneros, a lungo nella Città Eterna perché, appena iniziò ad essere conosciuto alla Corte di Pio II, seppe della morte del padre e decise di rientrare in Spagna per essere di conforto materiale e spirituale alla sua anziana madre. Prima di allontanarsi da Roma, però, ottenne dal Papa la concessione di un Breve che stabiliva che avesse il diritto di entrare in possesso del primo Beneficio (1) che si rendesse vacante nella diocesi di Toledo che era la sua diocesi di incardinazione. Questa pratica, allora assai diffusa, era però invisa ai vescovi che la vivevano come un’indebita intromissione del Papa nella gestione della diocesi e, non senza ragione, una mutilazione dei loro diritti e della loro autorità in quanto l’assegnazione dei Benefici nelle loro diocesi era riservata a loro.
Un difficile ritorno in Spagna
Nel 1473 si rese vacante, per la morte del possessore, un Beneficio legato alla Chiesa arcipretale di Uceda che egli desiderava molto perché includeva nella sua giurisdizione il suo paese natale. In base al documento pontificio questo sarebbe dovuto toccare al Nostro, ma questo si scontrava con la decisione dell’arcivescovo di Toledo, Alfonso Carillo, che lo aveva già destinato ad un altro prelato. Poiché il Cisneros non volle piegarsi a quella che riteneva una sopraffazione, rinunciando al beneficio, l’Arcivescovo pensò bene di farlo rinchiudere prima in una torre e poi, dato che non dava segni di cedimento, nella prigione della diocesi che era utilizzata per il clero vizioso e ribelle.
Dopo sette anni di cattività, su pressione di una contessa nipote del Vescovo, si giunse ad un compromesso con il quale il Nostro rinunciava al Beneficio in questione e l’Arcivescovo gli concedeva in cambio la libertà e il Beneficio di Singuenza. Questi anni di persecuzione furono fondamentali per la maturazione sia spirituale sia intellettuale di Gonzalo che poté così dedicarsi con maggior libertà all’orazione ed allo studio dell’ebraico e del caldeo, come allora era chiamato l’aramaico, che costituirono le basi per la pubblicazione, diversi anni dopo, della sua celebre edizione dei testi originali della Sacra Scrittura nota come Bibbia Poliglotta Complutense.
Dalla carriera ecclesiastica al “Cristo povero e nudo”
Dopo che all’Arcivescovado di Toledo, la sede primaziale di tutta la Spagna, salì l’ottimo cardinal Mendoza, iniziò la sua “carriera” in quanto fu scelto dallo stesso come vicario generale. Ma lo spirito mistico ed austero del Cisneros non poteva trovare alcuna attrattiva nelle occupazioni frivole e mondane che quell’incarico comportava e si sentiva chiamato ad una vita più alta. Invano i suoi amici e lo stesso cardinal Mendoza cercarono di trattenerlo, egli ormai aveva preso la sua decisione: “Dio solo” era la sua unica aspirazione e non trovò modo migliore per metterla in pratica che seguire il Poverello d’Assisi. L’unica cosa che riuscirono ad ottenere fu il passaggio dei benefici e delle rendite che gli erano intestati al bellicoso ed inquieto fratello Bernardino per il quale si sperava che la vita ecclesiastica potesse costituire un freno ed un rimedio. In realtà non servì a molto e pochi anni dopo, lo stesso Bernardino, dopo aver dato già innumerevoli amarezze al santo fratello, tentò pure di replicare il crimine di Caino.
Ximenez de Cisneros entrò dunque come novizio nel convento di “San Juan de Los Reyes” a Toledo appena fondato da Isabella e Fernando “i re cattolici” e celebre per la sua rigorosa osservanza della Regola. Nonostante i suoi quarantotto anni di età (ma nella storia dell’Ordine francescano si incontrano anche diversi santi entrati in tarda età) fu un novizio esemplare per umiltà, obbedienza e spirito di mortificazione tanto da essere indicato da tutti come modello per una santa emulazione e stimolo alla virtù. Queste virtù ed il fatto che fosse già sacerdote da diverso tempo fecero sì che divenisse, dopo l’anno di noviziato in cui prese il nome di “Francisco”, come già ricordato, richiestissimo per il ministero della Confessione soprattutto per le persone più distinte di Toledo che allora era anche la sede della Corte e quindi, in un certo senso, la capitale della Spagna.
La lampada sotto il moggio
Si capisce bene come questa “popolarità” non potesse piacere al neoprofesso figlio di san Francesco che chiese ed ottenne, quindi, di essere inviato in un piccolo convento fuori città chiamato “Santa Maria dei Castagni” perché costruito nei pressi di un bosco di castagni. Qui Francisco poteva dedicarsi in pace all’orazione ed alla contemplazione delle Scritture, restando raccolto in Dio. Per avere maggior quiete ottenne il permesso di costruire con le proprie mani anche un piccolo eremo nei pressi del convento dove poteva godere di ancora maggior solitudine e raccoglimento. Ma, come già aveva detto Nostro Signore, la lampada non è fatta per stare sotto il moggio (cf. Mt 5,13) e quindi ben presto si verificò quello che anche il buon cardinal Mendoza aveva dichiarato al momento in cui il suo fidato segretario aveva lasciato il mondo: «Un uomo come quello non è fatto per restare occulto». I religiosi con cui viveva, infatti, quando giunse il momento di eleggere il nuovo guardiano pensarono bene che non poteva esserci un soggetto migliore che il Cisneros, vista la sua esemplarità. Quest’ultimo, per parte sua, non ne voleva sapere di accettare quest’incarico ma, dopo l’insistenza dei suoi confratelli, per spirito d’obbedienza, decise di accettare. Il primato in tutto, per il Cisneros, spettava alla volontà di Dio espressa dall’obbedienza e, se pur apprezzava la solitudine per stare più concentrato in Dio, non era certo il tipo da tirarsi indietro quando comprendeva che il medesimo Dio lo voleva da un’altra parte.
Al lavoro per la gloria di Dio
Siamo ormai nel 1492, l’anno in cui, con la presa di Granada dalle mani degli islamici, termina la Reconquista cioè la crociata plurisecolare portata avanti con tenacia e fede eroiche dagli spagnoli per riprendersi, praticamente senza alcun aiuto esterno, palmo a palmo tutta la nazione che era stata invasa e soggiogata dalle armate musulmane ben sette secoli prima. Per festeggiare questo grandissimo avvenimento i sovrani cattolici decisero, tra l’altro, di finanziare la spedizione di Cristoforo Colombo che voleva trovare la via per le Indie passando da Occidente e che portò alla scoperta dell’America. Oltre ai festeggiamenti, però, ci fu la nomina del nuovo vescovo di Granada che finalmente era tornata in mano cristiana. Questo doveva necessariamente essere una persona retta e prudente perché si trovava ad avere a che fare con una discreta minoranza di musulmani – i Mori – che abitava ancora nella città e che andava al più presto evangelizzata per evitare, oltre alla loro perdizione eterna, anche forti disagi e contrasti a livello di ordine pubblico. Questo dovrebbe essere d’insegnamento anche per i nostri giorni quando ci si vuole convincere che una presenza musulmana in Europa non sia foriera di problemi di alcun tipo. È una pia illusione se non un vero e proprio inganno diabolico smentito costantemente non solo dalla storia, ma oseremmo dire, anche dalla geografia.
Per l’alto incarico il cardinal Mendoza, primate della Spagna, fece nominare il pio e dotto Padre de Talvera, religioso di san Girolamo e confessore della regina Isabella, che però, finì col ritrovarsi priva del confessore. L’incarico di confessore della regina era molto delicato perché, oltre alle preoccupazioni di carattere prettamente personale e religioso, con il confessore si consigliava anche per gli affari di Stato. Era ancora chiaro, a quel tempo, che l’uomo non è diviso e che non si può relegare l’influenza della religione solo all’uomo cosiddetto “interiore” ed agire poi per gli “affari di Stato” come se Dio non ci fosse. La religione riguarda tutto l’uomo, interno ed esterno, preso sia singolarmente che in società. Sarà Lutero il primo a sostenere che i cosiddetti “affari di Stato” non hanno nessuna attinenza con la religione ed il principe può regolarsi in essi secondo la convenienza, salvo poi invocare egli stesso l’aiuto e l’intervento dei principi secolari ogniqualvolta vedesse minacciata la sua autorità e preminenza per «fare a pezzi, strangolare, passare da parte a parte segretamente e alla luce del sole, come se si trattasse di uccidere un cane furioso» chiunque gli si opponesse perché «l’asino va bastonato e la plebaglia va governata con la forza» (2). E quando più di qualcuno osava fargli notare che il suo «li strozzi chi può» non era quanto ci si aspettava da un “novello Elia” ed un “quinto evangelista”, non aveva remore a rispondere come gli Ebrei a Pilato: «Io, Martin Lutero, ho colpito nella loro sollevazione tutti i contadini, poiché proprio io ho comandato di farne macello: tutto il loro sangue ricade sopra di me. Ma io lo rigetto sopra di Nostro Signore Iddio; è stato Lui a comandarmi di parlare in quel modo» e continuava dicendo che le autorità hanno la missione da Dio di «incalzare, battere, strangolare, impiccare, abbruciare, decapitare, storpiare la plebaglia, il signor Tutti, affine di essere temuti», concludendo che «come si conducono al macello i porci e si uccidono le bestie feroci» così, infatti, l’autorità deve far di tutto per far eseguire le proprie leggi (3). Non si capisce poi, come ancora oggi ci siano alcuni, soprattutto da parte cattolica, che difendano Lutero e il suo «vangelo tirato fuori da sotto il banco» (4). D’altra parte a chi si scandalizzava egli poteva sempre rispondere: «La volontà di essere puri non ha bisogno per effettuarsi dell’opera; basta che si rinnovi in noi per mezzo della fede la nascita di Cristo [...] il peccato non mi può mordere; Summa summarum opera di qui, opera di là tutto dipende oramai dalla dottrina e dalla fede» (5). Quindi «scandalo di qui, scandalo di là! La necessità non ha legge e nemmeno dà scandalo» (6).
A Corte con il corpo, in convento con il cuore
Riguardo all’affare del confessore della regina Isabella fu il già citato cardinal Mendoza a risolverlo consigliandole appunto quel santo sacerdote e santo frate che era Padre Francisco Cisneros, già stato a suo tempo il suo segretario. La Regina, allora, che era solita scegliere con accuratezza e solo dopo un lungo colloquio con il suo confessore, decise di chiamare a corte con un pretesto plausibile il Cisneros per vedere di persona se facesse al caso suo. Dopo aver constatato con una lunga e varia conversazione che quello che già a prima vista sembrava un «Anacoreta della Tebaide resuscitato» e «l’ideale vivo di un santo», era proprio quello che cercava, gli propose di divenire il suo confessore. Questi cercò di esporre le sue ragioni per non accettare, spiegando alla Regina che non era adatto e che lui cercava solo una vita lontana dal mondo, ma tutto fu inutile. Alla fine, temendo che persistendo nel rifiuto avrebbe potuto finire con l’opporsi alla volontà di Dio, accettò. Pose, però, una condizione: di non dover rinunciare all’osservanza integrale della Regola del suo Ordine e di dover venire a Corte soltanto quando era necessario per la direzione spirituale della sovrana, potendo rimanere per il resto in convento. Ricordava bene, infatti, quanto già il Serafico Padre san Francesco avesse messo in guardia i frati dai pericoli che si correvano nello stare a lungo nelle Corti e nel frequentare i potenti. Con questo incarico iniziava la grande ascesa del Nostro che lo porterà nei venticinque anni seguenti a divenire la persona più importante della Spagna.
All’inizio la riforma della Chiesa
Sarebbe troppo lungo seguire un preciso ordine cronologico per esporre tutte le attività svolte dal Cisneros e ci limiteremmo quindi soltanto ad alcune principali per evidenziare come quest’uomo di preghiera e di vita austera si rivelò anche un abilissimo uomo di Stato, a dimostrazione di quanto il “nuovo vangelo” di Lutero, per un ammirabile disegno della Provvidenza, fosse stato smentito con i fatti ancora prima che egli iniziasse a concepirlo e che le vere riforme, in qualsiasi ambito, sono quelle che fanno i santi proprio perché sono quelli che, essendo più vicini a Dio, si sforzano di cercare e compiere la sua volontà e non la propria. Essi sanno bene, infatti, che una fede senza le opere, come scriveva già l’apostolo san Giacomo nella sua lettera millecinquecento anni prima delle paturnie luterane, è una fede morta.
Un’altra incombenza che, però, accettò volentieri, nonostante gli portasse via molto tempo, fu quella di visitatore generale del suo Ordine. Quello che apprezzava di questo incarico era il fatto che poteva contribuire a migliorare lo stato dell’osservanza all’interno dell’Ordine e che aveva la “scusa” per allontanarsi dalla Corte. Partì, come prescrive la Regola, a piedi con un compagno per visitare personalmente i vari conventi di tutta la Spagna giungendo fino a Gibilterra. Qui, fu preso dall’idea di attraversare il mare per andare a convertire i musulmani in Marocco e guadagnare anche lui, come i protomartiri del suo Ordine, la palma del martirio. Ma, appurata che non era la volontà di Dio, decise di tornare a Corte per fare il resoconto del suo viaggio. Il quadro che presentò alla Regina fu desolante: l’influenza nefasta dell’islam, con il suo attaccamento ai piaceri sensuali, e della nobiltà aveva portato al rilassamento della gran parte del clero, ed i Francescani non erano certo esenti da questa situazione. Il voto di povertà non aveva ormai più alcuna rilevanza pratica: i religiosi vivevano nel lusso ed i conventi possedevano vaste proprietà e rendite cospicue, vendevano ed acquistavano a loro piacimento. Il voto di castità non era certo meglio osservato se, come leggiamo nelle cronache dell’epoca, era ormai talmente consolidato il concubinato del clero – secolare e regolare – che erano perfino riconosciuti dalle autorità locali i diritti di successione dei loro figli anche in assenza di testamento.
La riforma non era certo facile perché si andava contro ad usi che duravano da tempo e ad interessi economici di grande portata con “agganci” anche a Roma e nella Corte. Ma, con l’appoggio fondamentale dei re cattolici e con una buona dose di coraggio e fiducia in Dio, Cisneros iniziò a tagliare l’albero del vizio alla sua radice. Quando non riusciva con le buone a riportare l’osservanza arrivava anche a far intervenire l’autorità pubblica per sgomberare i religiosi riottosi, spesso provenienti da famiglie nobili ed influenti, dalle case che occupavano. Anche per il clero diocesano la riforma non era facile, ma grazie alla nomina di vescovi che avevano a cuore il loro incarico e ad interventi anche drastici a poco a poco riuscì a modificare la situazione che pareva ormai irrimediabilmente compromessa.
Arcivescovo sì... ma sempre francescano
Un aiuto potente in questa sua opera fu la nomina che ottenne, dopo la morte del buon cardinal Mendoza, ad arcivescovo di Toledo e primate di tutta la Spagna. La nomina gli fu conferita per intercessione della Regina che dimostrò così di preferirlo perfino al figlio naturale di suo marito che pure era uno dei favoriti per un incarico così prestigioso, essendo già arcivescovo di Saragozza. Questa nomina non era certo gradita al Cisneros che, dopo aver appreso la notizia direttamente dalla Regina, fu preso da tale spavento che corse a nascondersi al suo convento. Non voleva sentire ragione alcuna e rimaneva fermo e deciso nel suo “nolo episcopari” (“non voglio essere fatto vescovo”), conscio più degli altri delle grandissime responsabilità connesse alla carica. La lotta durò sei mesi. Alla fine dovette cedere perché gli fu recapitato un Breve papale che gli ingiungeva senz’altro, in virtù di obbedienza, ad accettare la dignità a cui era stato già designato. Anche questa volta, dimostrando la vera pasta di cui era fatto, di fronte alla manifesta volontà di Dio mise da parte ogni remora rimanendo sicuro che, nonostante le difficoltà, con l’aiuto di Dio non sarebbe venuto meno. Fu consacrato arcivescovo alla presenza dei re cattolici, l’11 ottobre del 1495 nel convento di San Francesco. L’elezione non mutò affatto la sua vita di religioso e finì col trasformare di fatto la Curia in un piccolo convento di stretta osservanza. La cosa non piacque a molti e così, dato il successo sperimentato al tempo dell’elezione, decisero di fargli recapitare un altro Breve dal Sommo Pontefice Alessandro VI in cui gli si ricordava che era gradita a Dio «l’onorevole decenza dei costumi in uso per ciascuno stato» e gli imponeva di «mantenere il suo vestiario e la Curia arcivescovile ad un livello consono allo stato in cui era stato elevato». Il Nostro obbedì prontamente e a livello esteriore eguagliò la magnificenza dei suoi predecessori. Sotto le ricche vesti consone al suo stato, però, non smise mai il saio francescano che ricevette il giorno della sua professione e che rammendava con le sue proprie mani. Anche per giaciglio si accontentava di una dura tavola, mentre per i pasti manteneva, anche se per sé soltanto, una frugalità che ricordava da vicino quella dei padri del deserto, distribuendo ai poveri, che erano sempre al centro delle sue preoccupazioni e cure, tutto l’avanzo. Per questi, poi, fece costruire anche un nuovo e più grande ricovero nella città di Toledo pagandolo di tasca propria.
Avanti con le riforme in mezzo alle tempeste
Per un uomo che ricopre un incarico pubblico la vera virtù non può limitarsi alla sfera privata e personale anche se questa non va tralasciata né sottovalutata ed è anzi una premessa indispensabile. Questa, però, è necessario che si esplichi – e naturalmente dovrebbe esplicarsi – anche in tutta l’attività che questa persona deve svolgere all’esterno. In altre parole non si può pretendere di essere un buon cristiano perché si ascolta con devozione la Santa Messa, si riceve l’Eucaristia, si digiuna tutti i venerdì ed a livello privato si ha una vita irreprensibile, però poi nella sfera lavorativa si agisce come se Dio non ci fosse. Quindi, per fare qualche esempio, un insegnante non potrebbe essere tranquillo in coscienza se, pur avendo una vita privata irreprensibile, a scuola insegnasse le teorie del gender perché “la legge lo prevede”, oppure un medico che praticasse l’aborto perché tanto “se non lo faccio io, lo farà un altro, dato che la legge lo permette” o – caso ancor più grave – un parlamentare o un uomo del governo votasse o facesse approvare delle leggi ingiuste e contrarie alla Legge naturale e divina per ragioni di calcolo politico.
Così il nostro Francisco, ormai arcivescovo di Toledo, era conscio che per essere santo non bastava che fosse un “santo frate” ma doveva essere un “santo arcivescovo”, agendo in ogni ambito della vita come era prescritto che agisse secondo l’esempio di Cristo. Proseguiva così il suo piano di riforma nonostante tutte le opposizioni convocando, per esempio, il capitolo della cattedrale ed esortandolo con carità e fermezza all’osservanza delle norme e regole di vita che esso stesso si era dato e che ogni suo membro aveva promesso di osservare all’atto di accettare la nomina (e la conseguente rendita). Quando questi ultimi, non propensi ad accettare le severe ammonizioni del loro Prelato e diretto superiore, mandarono di nascosto un inviato a Roma, egli non perse tempo e, dopo aver fatto giungere dei suoi emissari con la nave più veloce che c’era, lo fece arrestare non appena sbarcato ad Ostia e lo ricondusse in patria in catene. I suoi canonici, quindi, furono paternamente redarguiti per il tentativo di “ribellione” e caldamente invitati ad un ritorno se non alla «purezza originaria dei costumi» almeno ad una «maggior osservanza» di alcune delle norme stabilite dalla «pietà dei padri» in modo da avere uno stile di vita consono «alla dignità di sacerdoti di Gesù Cristo». Coloro che erano preminenti sul resto del clero per rendita e grado, infatti, non potevano non esserlo anche “per virtù” secondo il Cisneros. Inoltre volle chiarire che, seppure il dover intervenire a correggere eventuali abusi ripugnava alla sua inclinazione naturale, era un’esigenza del suo ministero e quindi in tal caso non avrebbe indugiato ad agire anche con la debita energia. Il capitolo, quindi, docilmente si sottomise. Così a poco a poco ebbe inizio la purificazione del clero e la riforma della Chiesa che tanto bene fece alla Spagna rendendola, nel giro di vent’anni, sostanzialmente impermeabile a qualsiasi velleità “riformistica” in senso protestante. Ma l’opposizione, soprattutto tra i religiosi, fu molto dura e si calcola che circa quattrocento sacerdoti preferirono trasferirsi con le loro concubine in nord Africa, accolti dal Califfo, apostatando dalla Fede cattolica e preferendo Maometto a Cristo.
Fermezza e mansuetudine verso i maomettani
Fu molto popolare anche grazie al suo intervento per annullare le imposte sulle rendite ed i guadagni che gravavano sulla popolazione e che, pur essendo nate come temporanee, sembrava non dovessero essere più tolte. Si adoperò poi per la conversione dei “Mori”, i musulmani che dopo la riconquista cristiana della Spagna non erano tornati in Africa. Anche in questo campo ottenne risultati così strabilianti che la popolazione gridava senza remore al “miracolo”, vedendo tanti seguaci di Maometto passare in massa alla vera Religione. Già l’ottimo Arcivescovo de Talvera aveva iniziato un’opera di evangelizzazione basata tutta sulla persuasione e studiando egli stesso e facendo studiare l’arabo ai suoi sacerdoti. Furono preparate anche delle traduzioni del Vangelo e del Catechismo in questa lingua e avviata una capillare opera di predicazione ed istruzione gratuita. Dopo secoli, finalmente, anche a Granada si poteva riudire il suono delle campane che erano state vietate dai saraceni. Di pari passo con queste misure furono emanate delle norme atte a favorire la conversione dei musulmani che è sempre stata molto difficile a causa delle prescrizioni severissime della legge coranica in merito. Fu vietato, per esempio, ai padri di diseredare i figli che si erano convertiti al Cattolicesimo o fu donata una dote dallo Stato alle figlie di musulmani convertite per potersi sposare con un cattolico e non andare incontro, così, al grande rischio dell’apostasia.
Grazie all’azione congiunta dei due arcivescovi, con l’esempio e la predica, in un solo giorno si convertirono più di quattromila maomettani. In poco tempo la maggior parte della città di Granada e dei dintorni era ritornata al Cristianesimo. Ciò nonostante le condizioni del trattato di pace garantivano una grandissima autonomia ai musulmani che si erano sottomessi pacificamente ai Re spagnoli ed anche la possibilità di praticare la loro religione. Le conversioni, però, ed il dominio cristiano non potevano essere tollerati dai più ostinati tra i seguaci di Maometto che, in segreto, cercavano un modo per cacciare l’odiato Arcivescovo e richiamare il Califfo dall’Africa.
L’occasione per la rivolta fu data dall’inseguimento, nel 1499, in un quartiere ancora quasi interamente musulmano di un Elche, cioè un cristiano apostata che, come tale, era sottoposto ad un regime molto più severo. Questa fu la scintilla che scatenò la rivolta di musulmani di Granada raggiunti in breve tempo e aiutati da molti che si erano convertiti da poco e non erano ancora saldi nella fede. Questa rivolta, però, in modo potremmo ben dire miracoloso, fu placata dal santo Arcivescovo de Talvera che, sull’esempio di san Leone Magno che si era presentato ad Attila armato solo di un crocifisso, si presentò nelle medesime condizioni ai rivoltosi e li invitò a ritornare alla calma. L’espediente funzionò tanto che quell’evento fu commemorato tutti gli anni per molto tempo a Granada, anche se i più ostinati si ritirarono sulle montagne a sud-est della città, le Alpujarras, dove risiedevano ancora delle popolazioni musulmane che si davano anche al saccheggio dei luoghi circostanti. La sollevazione dell’anno seguente di questi ultimi portò al rischio di perdere di nuovo il sud della Spagna in favore del Califfo del Marocco e fu sventata grazie all’efficace e tempestivo intervento del re Ferdinando per mezzo del nostro Cardinale che rivelò, così, anche una non comune abilità di stratega, riuscendo a conquistare in breve tempo una fortezza ritenuta fino ad allora imprendibile. A questo punto anche le altre roccaforti musulmane della zona si arresero. Secondo il diritto di guerra del tempo il vincitore aveva il diritto di passare per le armi tutti gli sconfitti, ma il Cardinale dimostrò anche in questo caso di volere imitare la mansuetudine di Cristo, imponendo solo l’esilio e concedendo a chi si faceva battezzare anche il permesso di rimanere in quei luoghi. Pochissimi scelsero la via dell’esilio, preferendo il Battesimo ed il giogo di Cristo a quello del Califfo che risultava assai più pesante anche da un punto di vista meramente economico.
La conversione di queste popolazioni, però, dettata com’era da un mero calcolo di convenienza, non fu mai sincera e diede origine al problema dei “Moriscos”, i discendenti dei Mori che erano convertiti al Cristianesimo solo di facciata, creando numerose complicazioni di ordine pubblico e lavorando per una nuova invasione della Spagna. La questione fu risolta, poi, soltanto con la loro definitiva espulsione nel 1609. Questo episodio, purtroppo, è stato travisato da molti, compreso il celebre storico protestante americano Prescott che, nel suo libro sui re cattolici, accusa il Nostro di aver violato le condizioni del trattato di pace precedentemente stipulato ed obbligato gli islamici alla conversione. In realtà il trattato di pace, che aveva delle condizioni favorevolissime ai musulmani, era stato violato da loro stessi che si erano sollevati in armi contro i re cattolici a cui avevano promesso obbedienza e sottomissione. Se, dopo essere stati sconfitti, gli furono applicate delle condizioni diverse – e per le condizioni del diritto di guerra del tempo più che favorevoli – non si può certo incolpare il card. Cisneros. Ma tanto è bastato per gettare fango sulla figura di questo grande Vescovo cattolico per molti decenni, tanto che ancora l’enciclopedia britannica, nel secolo scorso, riportava la calunnia.
Lo sguardo al Nuovo Mondo
Un altro campo in cui la moderazione e la prudenza di Cisneros furono, però, di fondamentale importanza fu quello riguardante gli abitanti delle terre appena scoperte da Colombo. Le popolazioni indigene infatti, per esplicito comando della regina Isabella, dovevano essere trattate con ogni riguardo e rispetto ed attratte alla Religione di Cristo tramite il buon esempio ed in modo pacifico. I coloni che disobbedivano andavano incontro a gravi sanzioni ed anche al rimpatrio forzato con il divieto di ritornare nelle colonie. Purtroppo, appena morì la Regina nel 1497, l’interesse aiutato dalla lontananza prese il sopravvento e ben presto le popolazioni autoctone furono ridotte allo stato di schiavitù da molti colonizzatori che non avevano scrupolo a considerarli alla stregua degli animali. Si dava così il caso di maltrattamenti e vessazioni che però, essendo appoggiate direttamente dagli ufficiali regi, non erano segnalate. Le veementi proteste – a volte forse un po’ esagerate – del celebre domenicano Padre de Las Casas e dei suoi confratelli sarebbero andate perdute perché nessuno a corte aveva interesse ad ascoltare.
Il Cardinale di Spagna, però, che ormai era divenuto, per la morte anche del re sopravvenuta nel 1514, il reggente (in attesa dell’arrivo del successore designato dal Belgio), non voleva certo tollerare questi abusi così contrari al Vangelo. Non appena venne a conoscenza delle condizioni effettive agì, facendo proclamare apertamente tutti gli abitanti indigeni delle colonie, sudditi liberi del re di Spagna con tutti i diritti che avevano gli altri. Unica eccezione erano gli indigeni antropofagi dei Caraibi che, data la loro efferata crudeltà, potevano ancora essere ridotti in schiavitù, pur avendo diverse garanzie come il riposo festivo, il mantenimento dei nuclei familiari ed una istruzione religiosa con l’intento di guadagnarli a Cristo. Questa dichiarazione aveva un valore sorprendente se si pensa che nessuna delle altre grandi potenze colonizzatrici fino a tutto il XIX secolo concesse mai una cosa del genere, nemmeno in teoria. I “protestantissimi” Stati Uniti consideravano gli indiani alla stregua degli animali e, ancora a fine Ottocento, si potevano vendere e comprare liberamente i cosiddetti “scalpi” (il cuoio capelluto asportato dalla testa degli indiani), senza contare le condizioni degli afroamericani nel sud-est fino almeno agli anni Sessanta del secolo scorso. Gli inglesi non erano da meno non avendo mai concesso la cittadinanza britannica agli abitanti delle colonie che rimanevano sempre “altro da sé” anche quando, ed accadeva molto raramente, avevano la sorte di poter studiare in una delle sue prestigiose università (erano i cosiddetti troused africans: gli “africani con i pantaloni”). Permettevano la schiavitù e non riconoscevano agli schiavi né il diritto al matrimonio né quelli legati alla paternità o maternità (i nuclei familiari potevano essere smembrati in qualsiasi momento) né il riposo festivo. Ancora nel XIX secolo trasformarono la carestia delle patate (Great Famine) in tentativo di genocidio degli irlandesi, chiamati spregiativamente “white negroes” cioè “negri bianchi” anche dal prestigioso e compassato Times, come già affrontato da altri su questo Settimanale qualche numero addietro. L’Olanda non fu da meno (si pensi all’Apartheid in Sud Africa durato fino agli anni Ottanta del secolo scorso) e nemmeno la Francia, almeno dopo la Rivoluzione (prima il retaggio cattolico funse da guida alle autorità e da freno alle brame disordinate di guadagno presenti negli uomini) nonostante gli altisonanti – ma vuoti e falsi come tutto ciò che proviene dalla scimmia di Dio – richiami alla “Fratellanza universale”. Questi i frutti del “vangelo puro” calvinista e della “filantropia” giacobina. Un importante spunto di meditazione.
Il tradimento del giusto
Oltre a questa importante acquisizione, però, il Cisneros non perse tempo: nominò il de Las Casas “Protectór de todos los Indios” e creò una commissione composta da religiosi con il compito di assicurare l’applicazione delle norme e informarlo direttamente dell’attuale situazione. Il de Las Casas ricopriva il ruolo di consigliere esterno a questa commissione, a causa della forte ostilità che avevano i coloni spagnoli verso di lui. Il Cardinale, infatti, agì sì con zelo e determinazione, ma anche con prudenza, sapendo che non si poteva ottenere tutto e subito e che spesso il “meglio” finisce col divenire nemico del “bene”. Per questo scelse i religiosi di san Girolamo che erano completamente estranei alle questioni del “Nuovo Mondo” e soprattutto alle grandi polemiche tra Francescani e Domenicani in merito proprio alla questione degli indigeni. Dopo attento esame, infatti, questi religiosi scelsero un programma intermedio e molto adeguato alla situazione concreta che prevedeva la possibilità di mantenere uno stato di tutela per gli indigeni già ridotti in schiavitù e dipendenti da spagnoli residenti in America, però, con forti limitazioni ed espliciti doveri per il “tutelante”. Tra questi il divieto di far lavorare donne e bambini, di scambiare gli indigeni con altri coloni ed un orario di lavoro ridotto che prevedeva anche il riposo in tutte le domeniche e feste di precetto. Inoltre il “tutelante” aveva l’obbligo di favorire l’uscita di tutela di tutti quegli indigeni che avevano la capacità per farlo, donandogli la libertà. Così facendo, evitavano le imprudenze di chi, come il de Las Casas, per eccesso di zelo avrebbe voluto eliminare immediatamente ogni stato di soggezione degli Indios, cosa a cui invece si opponevano strenuamente i coloni spagnoli. Aveva, però, il piano di Cisneros il merito di migliorare immediatamente le condizioni non solo materiali, ma anche spirituali degli stessi indigeni in quanto andava loro garantita un’istruzione ed una assistenza religiosa. Per chi avesse tentato di schiavizzare le popolazioni pacifiche ancora libere o passava “alle vie di fatto” con gli indios, erano previste, inoltre, pene severissime come la pena di morte eseguibile sul posto (cioè senza la possibilità di appello al re) dal nuovo delegato regio che diveniva plenipotenziario anche per i processi criminali.
Il Padre de Las Casas, purtroppo non si diede per vinto e, tornato in Spagna, si batté fortemente per la liberazione totale degli Indios. Il nostro Cardinale era sul letto di morte e il novello imperatore Carlo V che era un Flamenco (cioè proveniente dalle Fiandre, l’attuale Belgio), decise di dare ascolto al de Las Casas perché aveva ricevuto delle informazioni tendenziose sull’operato del Cisneros come reggente. L’Imperatore, dunque, ebbe l’onore indiscutibile di proclamare l’emancipazione completa degli Indios anche se grava, però, su di lui l’onere di aver concesso come “risarcimento” per i coloni spagnoli che – di colpo – perdevano l’accesso alla manodopera semigratuita, l’“Asiento de negros” cioè “tratta dei negri” a cui il Cardinale si era sempre coraggiosamente opposto perché la riteneva – giustamente – in diretta opposizione con i valori del Vangelo. Anche in questo caso, però, la Fede cattolica professata dal Sovrano fece imporre delle limitazioni e delle mitigazioni per lo sfruttamento dei poveri africani, come l’obbligo di rispettare il risposo domenicale, il rispetto dei vincoli familiari ove possibile (quando venivano catturati non si badava certo a questo) e l’obbligo per il loro “custode” di istruirli nella Fede cristiana.
Uomo di cultura e di fede
Dopo aver accennato a grandi tratti ad alcune delle opere più grandi del “Santo Cardinale” non ci resta che considerare le sue qualità di studioso. Abbiamo già detto come fin dai primi anni si era dato allo studio dell’Aramaico e dell’Ebraico proprio per avvicinarsi meglio alla Parola di Dio. Oltre allo studio però, da buon figlio di san Francesco, si era dato anche alla meditazione intensa e profonda delle stesse Scritture e ad una vita di orazione, conscio com’era che la scienza, da sola, gonfia, seguendo quell’atteggiamento tipico di tutti i grandi Dottori francescani e che fu ben riassunto dal motto coniato dal beato Bernardino da Portogruaro, il creatore, nell’800, dei “Seminari serafici”, che ai giovani frati studenti raccomandava soprattutto “occhi e ginocchi”.
Appena ne ebbe la possibilità, essendo divenuto primate di Spagna, fece costruire – tutto a sue spese – il Colegio Mayór San Ildefonso che divenne poi noto come “Università di Alcalà” dal nome del sobborgo di Madrid in cui era situata. La prima pietra fu posta dal medesimo Cardinale il 14 marzo 1498 e vi collaborarono i migliori architetti del tempo. Ottenne dal papa Alessandro VI l’autorizzazione a procedere con la costruzione di questo grande edificio e dai suoi successori, Giulio II e Leone X, la conferma e l’elargizione di numerosi privilegi e riconoscimenti che le davano la garanzia di poter accogliere e formare studenti secondo gli “standard” europei del tempo e con un titolo di studio riconosciuto in tutta Europa grazie all’approvazione papale. La grande Università divenne ben presto una delle più importanti di tutta la Spagna e fu frequentata anche dagli studenti degli Istituti religiosi che facevano a gara per avere una casa presso la nuova istituzione.
La Poliglotta Complutense
Proprio a questa Università è legata una delle opere più celebri del Cardinale e cioè la Bibbia Poliglotta Complutense così chiamata dal nome latino della cittadina di Alcalà e cioè Complutum. L’idea che stava alla base di quest’opera grandiosa era quella di presentare, sull’esempio dell’antica opera di Origene (purtroppo quasi interamente perduta a causa del rogo che gli islamici fecero di essa e di tutta la biblioteca di Cesarea in cui era contenuta), un’opera in cui tutte le varie versioni (latina, greca, ebraica ed aramaica) dell’Antico e del Nuovo Testamento erano poste su colonne parallele in modo che per la prima volta i lettori potessero avere uno sguardo d’insieme di tutte le traduzioni e del testo originale. Non risparmiò né fatica né denaro per ottenere da tutta Europa i migliori manoscritti e radunando anche i maggiori esperti dell’epoca per ottenere la prima edizione a stampa di questa tipologia. Anche il Pontefice garantì il libero acceso a tutti i manoscritti conservati nella rinomata Biblioteca Vaticana ed incoraggiò esplicitamente e pubblicamente l’iniziativa. Il lavorò durò dal 1502 al 1517 e fu dedicato al Papa regnante, cioè Leone X, anche se il Cardinale morì prima di poterne vedere la fine.
Tra gli altri pregi ebbe quello di identificare per prima – e con trecento anni di anticipo sulla critica moderna – il Codice Vaticano come appartenente al gruppo testuale più antico e più affidabile. La causa di questo sviamento dei critici fu data sostanzialmente dall’influenza che ebbe la quasi contemporanea versione greca della Bibbia del celebre umanista Erasmo da Rotterdam che, però, identificava un altro codice come testo più antico. In ogni caso è una chiara dimostrazione della falsità dell’accusa protestante che rinfacciava ai cattolici di non conoscere la Bibbia e di tenere occultati i “testi originali” per fidarsi solo della “loro bibbia” cioè la Volgata latina di san Girolamo. Anche quest’ultima, poi, con il tempo dimostrò la sua grandissima affidabilità e scientificità come oggi è ormai universalmente riconosciuto perfino dagli studiosi ebrei. Quella che oggi invece tutti riconoscono essere tutt’altro che scientifica e frutto – di fatto – di una più o meno esplicita manipolazione della Scrittura a suo uso e consumo è la celebre “Deutsche Bibel”, la Bibbia Tedesca, cioè la traduzione fatta da Martin Lutero. Non si può, quindi, non interpretare come un segno della provvidenza di Dio il fatto che proprio in concomitanza con le prime avvisaglie della rivolta protestante, che faceva della Sacra Scrittura – misinterpretata e mal tradotta – il proprio vessillo, vedesse la luce un’opera di questa importanza e levatura, frutto del lavoro e dell’amore alla Parola di Dio di questo grande figlio di san Francesco!
La santa morte
Il Cardinale, però, giaceva sul suo letto di agonia e non poté vedere la pubblicazione della sua opera. Ormai il suo unico pensiero era prepararsi al tanto atteso incontro con il Giudice Supremo ed a questo voleva prepararsi con ogni cura. Ricevette i santi Sacramenti tra le lacrime e con un fervore non comune. Ai religiosi che gli facevano compagnia e pregavano per la salvezza della sua anima esprimeva come poteva i suoi sentimenti esortandoli a considerare l’infinita misericordia di Dio e la vanità delle cose del mondo. Le ultime sue parole, recitate con un fil di voce, furono quelle del santo profeta Davide tratte dal Salmo 30: «In te Domine speravi non confundar in aeternum» (In te Signore ho sperato, non sarò confuso in eterno).
Come erede universale designò la sua amata Università che aveva raccomandato al re Carlo V appena prima di morire. Fu esposto alla venerazione dei fedeli rivestito dei solenni abiti pontificali per più giorni e poi, dopo i solenni funerali, la sua salma fu traslata presso Alcalà come egli aveva richiesto. La fama delle sue virtù e il gran servizio che rese alla Spagna furono ricordati nei secoli successivi tanto che divenne presto noto come “il Santo Cardinale” per antonomasia e più volte si pensò di iniziare il processo di canonizzazione. Finora la Chiesa non ha ritenuto che fosse il caso di procedere, ed in assenza del suo verdetto ovviamente non possiamo esprimerci sull’effettiva santità del Nostro, attenendoci a quanto prudentemente essa ha stabilito a questo riguardo nel corso dei secoli. Questo non ci vieta tuttavia di ammirare le virtù, fossero anche soltanto umane, di quello che in ogni caso fu un grande uomo di, Stato cattolico ed un ammirevole figlio di san Francesco a cui volle essere sempre fedele anche se in una posizione “un po’ scomoda” come quella di uomo di Stato e primate di Spagna e che offre moltissimi spunti di riflessione nel periodo di decadenza così ampia e profonda sotto tutti i punti di vista in cui versiamo allo stato presente.
NOTE
1) Una rendita di un terreno o altro che era destinata al mantenimento di una determinata chiesa o parrocchia. Questo sistema è rimasto in vigore fino alla promulgazione del nuovo Diritto canonico negli anni Ottanta del secolo scorso.
2) M. Lutero, Contro le frotte di contadini che assassinano e rubano, citato in: H. Grisar, Lutero. La sua vita e le sue opere, Torino 1934, pp. 265-267.
3) Ibidem.
4) H. Grisar, Lutero. La sua vita e le sue opere, p. 277.
5) Ibidem.
6) Ibidem.
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale