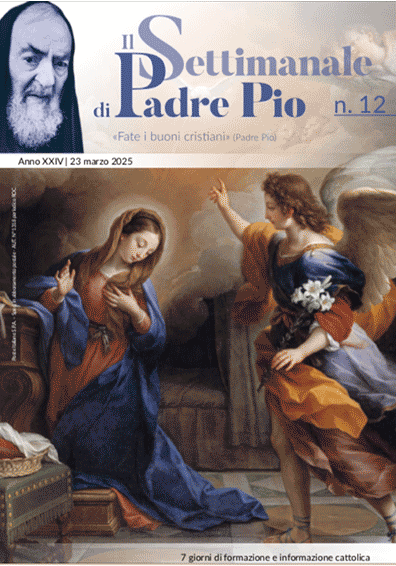“Veritatis splendor”: lo splendore di una enciclica
dal Numero 42 del 29 ottobre 2017
di Suor M. Gabriella Iannelli, FI
L’enciclica “Veritatis splendor” è un intervento magisteriale di teologia morale tra i più completi e filosoficamente fondati della tradizione cattolica e rimane di immutata attualità. Leggerla e assimilarla è quanto mai utile per chi vuol permanere “nello splendore della verità”.

La Veritatis splendor è una lettera enciclica che porta la firma del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, e la data del 6 agosto 1993, decimoquinto anno del pontificato del grande Papa. È un gioiello di particolare splendore tra le preziose e numerose encicliche da lui lasciateci, che offre delle chiarificazioni quanto mai necessarie nell’attuale contesto storico ed ecclesiastico. Il motivo che spinge il Papa a scrivere questa enciclica è proprio quello di offrire una chiarificazione su questioni morali di primaria importanza per «custodire la “sana dottrina” (2Tm 4,3), con l’intenzione di precisare taluni aspetti dottrinali che risultano decisivi per far fronte a quella che senza dubbio è una vera crisi, tanto gravi sono le difficoltà che ne conseguono per la vita morale dei fedeli e per la comunione nella Chiesa, come pure per un’esistenza sociale giusta e solidale» (Veritatis splendor, n. 5). Il Santo Padre parla dunque di una «vera crisi» che comporta «gravi difficoltà per la vita morale dei fedeli».
Egli spiega che, sebbene sempre i Sommi Pontefici abbiano sviluppato e proposto un insegnamento morale relativo ai molteplici e differenti ambiti della vita umana, contribuendo così ad una migliore comprensione delle esigenze morali negli ambiti della sessualità umana, della famiglia e della vita sociale, «oggi sembra necessario riflettere sull’insieme dell’insegnamento morale della Chiesa, con lo scopo preciso di richiamare alcune verità fondamentali della Dottrina cattolica che nell’attuale contesto rischiano di essere deformate o negate.
Si è determinata, infatti, una nuova situazione entro la stessa comunità cristiana, che ha conosciuto il diffondersi di molteplici dubbi e obiezioni, di ordine umano e psicologico, sociale e culturale, religioso e anche propriamente teologico, in merito agli insegnamenti morali della Chiesa. Non si tratta più di contestazioni parziali e occasionali, ma di una messa in discussione globale e sistematica del patrimonio morale, basata su determinate concezioni antropologiche ed etiche. Alla loro radice sta l’influsso di correnti di pensiero che finiscono per sradicare la libertà umana dal suo essenziale e costitutivo rapporto con la verità. Così si respinge la dottrina tradizionale sulla legge naturale, sull’universalità e sulla permanente validità dei suoi precetti; si considerano semplicemente inaccettabili alcuni insegnamenti morali della Chiesa; si ritiene che lo stesso Magistero possa intervenire in materia morale solo per “esortare le coscienze” e per “proporre i valori”, ai quali ciascuno ispirerà poi autonomamente le decisioni e le scelte della vita» (n. 4).
Il Papa ci offre un quadro alquanto completo e incisivo della situazione di crisi che si è venuta a creare «entro la stessa comunità cristiana»: dubbi, obiezioni di ordine umano e psicologico, sociale e culturale, religioso e teologico che mettono in discussione in maniera sistematica tutto il patrimonio morale, facendo arrivare a respingere la dottrina morale tradizionale e la permanente validità dei suoi precetti e a limitare la funzione del Magistero a quella di esortare le coscienze e proporre dei valori, senza alcun valore vincolante per il popolo di Dio, perché alcuni insegnamenti morali della Chiesa «si considerano semplicemente inaccettabili»! In altri termini si potrebbe dire che alla perenne morale cristiana, che ha accompagnato la vita della Chiesa fino ad ora, si è sostituita una morale “fai da te”, dal momento che alla semplice proposta ed esortazione del Magistero possono seguire decisioni e scelte di vita autonome.
Per questo il Papa, nel suo zelo e amore di Pastore universale, si sente in dovere di correggere una tale pericolosissima deviazione richiamando i principi inalienabili della morale basati sulla legge naturale e sulla legge positiva dei Comandamenti e del Vangelo. Egli comincia andando all’origine della domanda morale: “Cosa devo fare?”, e presenta il dialogo tra il giovane ricco e Gesù del Vangelo di Matteo (19,16-21). «Nel giovane – afferma il Papa – possiamo riconoscere ogni uomo che coscientemente o no, si avvicina a Cristo, Redentore dell’uomo, e gli pone la domanda morale [...]. Dalla profondità del cuore sorge la domanda che il giovane ricco rivolge a Gesù di Nazareth, una domanda essenziale e ineludibile per la vita di ogni uomo: essa riguarda, infatti, il bene morale da praticare e la vita eterna. L’interlocutore di Gesù intuisce che esiste una connessione tra il bene morale e il pieno compimento del proprio destino» (n. 7).
In ogni uomo, dunque, dalla profondità del cuore sorge la domanda morale, perché in ogni uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, vi è la coscienza che, quando non è ottenebrata, ha la funzione di discernere ciò che è bene e ciò che è male, e che tende, quindi, a ricercare il bene e ad evitare il male. A chi volgere questa domanda morale? Il giovane ricco aveva intuito che nel Cristo c’era qualcosa di diverso dagli altri rabbini della sinagoga e fu sicuramente questa intuizione ad indirizzarlo a Lui. «Occorre che l’uomo di oggi si volga nuovamente verso Cristo, per avere da Lui la risposta su ciò che è bene e ciò che è male. Egli è il Maestro, il Risorto che ha in sé la vita e che è sempre presente nella sua Chiesa e nel mondo. È Lui che schiude ai fedeli il libro delle Scritture e, rivelando pienamente la volontà del Padre, insegna la verità sull’agire morale» (n. 8). Infatti: «La luce del volto di Dio splende in tutta la sua bellezza sul volto di Gesù Cristo, “immagine del Dio invisibile” (Col 1,15), “irradiazione della sua gloria” (Eb 1,3), “pieno di grazia e di verità” (Gv 1,14): Egli è “la via, la verità e la vita” (Gv 14, 16)» (n. 2).
- 1 San Massimiliano M. Kolbe e “le patate dell’umiltà”
- 2 Maria è mia Madre
- 3 Una pedagogia per il Paradiso L’oratorio di don Bosco
- 4 Alla ricerca del treno bianco
- 5 I dolori di Maria Santissima Amore e dolore
- 6 Degni più del Cielo che della terra
- 7 Francesco e Giacinta: due pastorelli, due grandi Santi
- 8 San Massimiliano e una devozione speciale