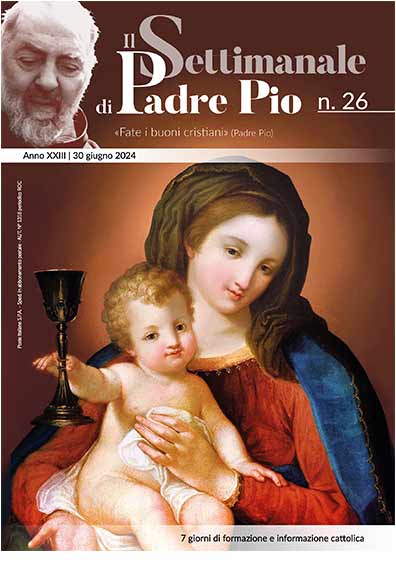Con Gesù nel Getsemani | riflessioni sull’agonia di Gesù
dal Numero 13 del 26 marzo 2023
a cura di Anastasia Domini
Non è un paradosso: la morte di Gesù ci ha dato la vita. Nell’oscurità di un orto in cui l’uomo-Dio agonizza, il calice della nostra salvezza sta per riempirsi. In quello sguardo sofferente è la nostra vera vita... Lo lasceremo solo nella sua agonia?

INTRODUZIONE
È stato scritto, ben a ragione, che i Vangeli sono “racconti della Passione preceduti da una lunga introduzione”. Con queste parole si vuole sottolineare l’importanza fondamentale che nella narrazione evangelica ha il racconto della Passione del Signore. Purtroppo, però, con profonda amarezza bisogna constatare che questa, che pure è la parte più importante dei Vangeli, è anche la più dimenticata nel corso dell’anno liturgico. Infatti la lettura della Passione è riservata soltanto alla Domenica delle Palme e al Giovedì Santo, giorni in cui – essendo letta per intero – risulta assai difficile soffermarsi sui singoli momenti che la caratterizzano. Il risultato è che, purtroppo, molti cristiani giungono alla fine della loro terrena esistenza senza essere mai “saliti sul Calvario”.
Eppure sappiamo bene che l’elemento essenziale della nostra fede è la Passione di Cristo, che fa unità inscindibile con la sua Risurrezione. «Non è gran cosa credere che Gesù è morto – scrive infatti sant’Agostino –; questo lo credono anche i pagani e i reprobi; tutti lo credono. Ma la cosa veramente grande è credere che Egli è risorto. La fede dei cristiani è la Risurrezione di Cristo». Tuttavia, se ciò è verissimo da un punto di vista oggettivo, dobbiamo riconoscere che, dal punto di vista soggettivo, è la Passione l’elemento che per noi si presenta primariamente attuale e concreto: «Delle tre cose che costituiscono il sacratissimo triduo – Crocifissione, sepoltura e Risurrezione del Signore, noi – afferma ancora il Santo d’Ippona – realizziamo nella vita presente il significato della Crocifissione, mentre teniamo per fede e speranza ciò che significano la sepoltura e la Risurrezione». Per la nostra quotidiana esistenza, dunque, è certamente più importante la Passione. Noi, infatti, dobbiamo vivere la passione e attendere la risurrezione. La passione appartiene a questa vita, mentre la risurrezione ci sarà svelata solo al termine dell’esilio terreno.
Tutti noi siamo stati «battezzati nella sua [di Cristo] morte – come afferma san Paolo –, [...] sepolti insieme con lui» (Rm 6,3.4): paradossalmente la morte di Gesù ci ha dato la vita, perché «dalle sue piaghe siamo stati guariti» (Is 53,5). Se noi viviamo, è grazie alla di Lui morte. Essa dunque deve esserci particolarmente familiare, visto che da essa dipendiamo vitalmente. «Mi seppellii nella Passione di Cristo – scrive sant’Angela da Foligno –, e mi fu data speranza che in essa avrei trovato la mia liberazione». «Sola, ai piedi del mio crocifisso Signore – esclama la beata Elia di San Clemente –, lo guardai lungamente e in quello sguardo vidi che era tutta la mia vita». Sì, la nostra vita è nel Crocifisso, anzi, è il Crocifisso stesso, ed è per questo che vogliamo stare un po’ con Lui nel Getsemani, vogliamo fargli compagnia nella sua penosissima agonia, cercando di scandagliare – pur nei nostri inevitabili limiti – il mistero abissale della sua inarrivabile sofferenza.
IL GETSEMANI SECONDO I VANGELI
L’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi è narrata con dovizia di particolari dai tre Evangelisti sinottici, i quali riportano l’episodio ciascuno con dettagli diversi, rispondenti – evidentemente – ai bisogni della comunità per cui scriveva. Il fatto che tutti e tre gli Evangelisti riportino tale episodio – nel quale Gesù si mostra in tutta la sua umanità e anche nella debolezza che di essa è propria, dopo il peccato –, è indice che esso ebbe una forte eco nel cuore degli Apostoli e nella prima comunità cristiana.
Siamo all’episodio iniziale della Passione, e già contempliamo, in sintesi, tutto il dramma della Passione: Gesù che si separa dai suoi Discepoli per pregare; la sua anima angosciata in atteggiamento di supplica al Padre perché “il calice si allontani da Lui” (cf Mt 26,39; Mc 14,36; Lc 22,42); il Padre che gli invia un angelo per sostenerlo (cf Lc 22,43). Ma il Maestro è solo perché per tre volte i suoi Discepoli, invece di pregare con Lui, si addormentano. L’episodio si conclude col coraggio espresso nella risoluzione finale di andare incontro al traditore che viene (cf Mc 14,42).
«Restate qui, mentre io prego» (Mc 14,32)
Ne Getsemani Gesù «portò con sé solamente i tre Discepoli che avevano contemplato la sua gloria sul monte Tabor – scrive Teofilatto–, affinché coloro che videro la sua potenza mirassero anche la sua tristezza e scoprissero in questa afflizione che Egli era vero uomo. E poiché aveva assunto tutta quanta l’umanità, assunse anche i tratti caratteristici dell’uomo: il timore, l’angoscia, la naturale tristezza; è infatti logico che gli uomini vadano alla morte contro la propria volontà».
Il Signore si allontana «un tiro di sasso» (Lc 22,41) forse per non scoraggiare con la sua sofferenza atroce i già deboli e vacillanti Apostoli. Quanta delicatezza in tale gesto di Gesù!
È questo uno dei dettagli riportati dai Sinottici. Viene spontaneo chiedersi donde li abbiano desunti, visto che... dormivano, o comunque non erano fisicamente vicini a Lui. Si era in tempo di plenilunio. Gli Apostoli certamente poterono scorgere in parte il Maestro e forse udirne qualche parola, ma ciò non basta a spiegare tanta abbondanza di particolari. Si potrebbe ritenere allora che il Signore, dopo la Risurrezione, abbia raccontato ai discepoli le angosce dell’agonia, come pure li abbia informati delle tentazioni nel deserto.
«Inginocchiatosi» (Lc 22,41), «si gettò a terra e pregava» (Mc 14,35), «con la faccia a terra» (Mt 26,39).
È questo l’unico passo del Vangelo in cui si afferma che Gesù pregava in ginocchio. I tre Sinottici si sono premurati di farci sapere – ciascuno con accenti diversi – quale sia stata non solo la preghiera di Gesù nell’agonia, ma anche il suo atteggiamento esterno. Quale il fine se non quello di descrivere in tutto, anche nei dettagli, il nostro divino Modello affinché noi in tutto potessimo imitarlo?
È commovente contemplare il Redentore in questa posizione di supplica, di richiesta che manifesta la tremenda angoscia della sua anima gravata di tutti i peccati – uno per uno – dell’umanità da redimere.
E noi, come preghiamo? Anche l’atteggiamento esterno è importante per favorire il raccoglimento interiore. Se la nostra preghiera deve essere continua (cf Lc 18,1), cioè non limitarsi al tempo in cui si sta in chiesa, ma estendersi a tutta la nostra giornata, è evidente che anche il nostro atteggiamento esterno deve esser conforme a queste disposizioni interiori. Non si tratta di pura esteriorità, ma di conformità del corpo al lavorio dell’anima.
Che dire allora delle molte chiese in cui non si fa più uso degli inginocchiatoi? Il Signore Gesù – vero Dio e vero uomo – prega in ginocchio e addirittura prostrato a terra, e noi, misere creature, ci rivolgiamo a Lui – nostro Creatore – comodamente seduti? Ripugna alla fede e alla ragione!
LA PREGHIERA DI GESÙ
Gesù è solo, profondamente solo dinanzi all’abisso del dolore senza pari che sta per abbattersi su di Lui.
I suoi gesti sono quelli propri di una persona in preda ad un’angoscia mortale: si getta “con la faccia a terra”, si alza per andare dai suoi Discepoli, torna a inginocchiarsi, poi si leva di nuovo... suda gocce di sangue (cf Lc 22,44). Poi supplica il Padre: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice!» (Mc 14,36). La “violenza” della preghiera di Gesù nell’orto è ben descritta dalla lettera agli Ebrei, dove si legge che Cristo, «nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte» (Eb 5,7).
Il demonio, dopo avere tentato Gesù nel deserto, «si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato» (Lc 4,13).
È giunta dunque la sua “ora”, l’ora lungamente attesa, l’ora per la quale il Figlio dell’uomo è venuto sulla terra. Ma la causa dell’angoscia di Gesù risiede nel fatto che Egli si è voluto caricare di tutto il male e di tutti i peccati del mondo. Male e peccati che Egli non ha commesso, ma che ha voluto liberamente assumere su di sé: «Egli portò i nostri peccati nel suo corpo» (1Pt 2,24), al punto da divenire l’uomo «fatto peccato» (2Cor 5,21), come afferma icasticamente san Paolo.
Ora, durante la Passione, il demonio torna all’attacco – come fa di solito prima di momenti importanti nella nostra vita –, facendo leva sulla ripugnanza che la natura umana ha della sofferenza, poiché questa è la sua ora, è «l’impero delle tenebre» (Lc 22,53).
In quest’ora suprema di dolore, Gesù svela tutta la realtà e la straordinaria sensibilità della sua natura umana. Strettamente parlando, Egli, grazie al dominio che aveva di sé, avrebbe potuto trattenere la commozione delle sue facoltà sensibili. Ma, mostrando la sua angoscia, il mistero della sua umanità emerge più intensamente e diventa per noi più imitabile.
L’interpretazione dei primi secoli
Alcuni Padri della Chiesa hanno interpretato l’episodio dell’agonia nel Getsemani accentuandone oltremisura il fine “pedagogico”. Secondo costoro, Gesù non avrebbe provato veramente angoscia e paura, ma – con la sua agonia e la sua preghiera – avrebbe soltanto voluto insegnare a noi come superare le tentazioni. Nel Getsemani, scrive ad esempio sant’Ilario di Poitiers, «Cristo non è triste per sé e non prega per sé, ma per coloro che ammonisce a pregare con attenzione, affinché non incomba su di loro il calice della passione».
Questa interpretazione si spiega con la preoccupazione che avevano i Padri di dirimere le eresie dilaganti a quel tempo, le quali mettevano in dubbio la divinità di Cristo (basti pensare a quella ariana, per fare solo un esempio). Superate tali eresie, non occorreva più ricorrere a siffatta spiegazione e, allora, si dimostrò che Gesù nel Getsemani non pregava soltanto per esortare noi a pregare. Pregava perché, essendo vero uomo, in tutto simile a noi fuorché nel peccato, sperimentava la nostra stessa lotta di fronte a tutto ciò che ripugna alla natura umana.
È evidente, tuttavia, che se l’intenzione pedagogica non esaurisce né la spiegazione dell’episodio né l’intento degli Evangelisti, essa è comunque presente nella finalità della narrazione. San Pietro lo afferma chiaramente quando scrive: «Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme» (1Pt 2,21).
Gesù e Giacobbe
Nella Sacra Scrittura si rinviene un significativo episodio che presenta diverse assonanze con quello del Getsemani. Si tratta della lotta con Dio di Giacobbe (cf Gn 32,23-33). La scena è molto simile. La lotta di Giacobbe si svolge di notte, al di là di un torrente, così anche quella di Gesù: si svolge di notte, oltre un torrente, il Cedron. Giacobbe allontana da sé tutti – mogli, figli e schiave – per rimanere solo, e Gesù si allontana anche dagli ultimi tre Discepoli per pregare. Ma perché Giacobbe lotta con Dio? «Non ti lascerò – dice –, se non mi avrai benedetto», cioè se non avrai fatto quanto ti chiedo. E ancora: «Svelami il tuo nome» (Gn 32,27.30) [1]. Dio lo benedice, ma non gli rivela il suo nome. Giacobbe lotta dunque per piegare Dio alla sua volontà; Gesù, invece, lotta per fortificare la sua volontà umana e conformarla a quella divina.
Viene spontaneo, a questo punto, domandarsi: a chi somigliamo noi, quando preghiamo? Somigliamo a Giacobbe, cioè all’uomo dell’Antico Testamento, quando, nella preghiera, lottiamo per indurre Dio a cambiare decisione invece che per cambiare noi stessi e accettare la sua volontà; quando preghiamo perché ci tolga quella croce, invece di chiedere la grazia di poterla portare con Lui. Somigliamo a Gesù se, pur nel dolore dell’anima che suda sangue, cerchiamo di fare la volontà del Padre. Quante volte la nostra preghiera non è altro che una lotta con Dio! Ossia un pregare non per fare la volontà di Dio (come Gesù), ma perché Dio faccia la nostra (come Giacobbe). Se nella preghiera somigliamo a Giacobbe, è segno che siamo ancora... nell’Antico Testamento! Siamo come il terreno sassoso della parabola... il seme, anche se gettato, non porta frutto (cf Mt 13,20).
Ma è bene anche evidenziare che i risultati delle due preghiere – quella di Gesù e quella di Giacobbe – sono molto diversi. A Giacobbe Dio non rivela il proprio nome, ma a Gesù darà il nome che è al di sopra di ogni altro nome (cf Fil 2,11).
Non pregare “male, mala, mali”
Quando nella preghiera non ci conformiamo alla volontà di Dio, accade spesso che le parti s’invertano: Dio diventa Colui che prega e noi coloro che sono pregati. Nel momento in cui preghiamo Dio perché allontani da noi una sofferenza, una croce, una difficoltà, una responsabilità, una persona, avviene spesso che “Dio ci prega” di accettare quella sofferenza, quella croce, quella difficoltà, quella responsabilità, quella persona. In pratica è Dio che si piega a noi. Che vergogna! Il Signore che prega noi!
E poiché tante volte noi non ascoltiamo la voce di Dio che con tenerezza di Padre ci esorta – per il nostro bene – ad accettare la croce, si spiega perché molto spesso la nostra preghiera non è esaudita. Sant’Agostino afferma che, se le nostre preghiere non sono ascoltate, è perché preghiamo – per dirla col più efficace latino – male, mala, mali.
Male: preghiamo male.
Mala: chiediamo cose cattive o almeno sconvenienti per noi.
Mali: noi che chiediamo siamo cattivi, ossia non abbiamo le disposizioni giuste per esser ascoltati.
L’elemosina del figlio del Re
Una poesia di Rabindranath Tagore ci può aiutare a comprendere con efficacia e concretezza quale sia, dunque, la pedagogia divina nell’esaudire le nostre preghiere.
Un povero andava mendicando di porta in porta, quando in lontananza vide un cocchio d’oro. Era il cocchio del figlio del Re. Pensando che fosse l’occasione della sua vita, si sedette spalancando la bisaccia, in attesa della cospicua elemosina che poteva giustamente attendersi da una persona così illustre. Ma quale non fu la sua sorpresa, quando, avvicinatosi a lui, il cocchio si fermò, il figlio del Re discese e, stendendo la mano, gli chiese: «Che cos’hai da darmi?». Qual gesto regale fu quello di stendere la sua mano!
Confuso ed esitante, il mendicante prese dalla bisaccia un chicco di riso, uno solo, il più piccolo, e glielo diede. E quale fu la sua tristezza, quando, a sera, frugando nella bisaccia, trovò un chicco di riso d’oro, ma uno solo, e il più piccolo. Pianse allora amaramente per non aver avuto il coraggio di dare tutto.
Il caso più sublime ed eloquente di questa trasposizione delle parti è proprio la preghiera di Gesù nel Getsemani. Egli prega il Padre perché passi da Lui il calice della Passione, e il Padre gli chiede di berlo fino in fondo, per la salvezza del genere umano. Gesù dona non una, ma tutte le gocce del suo Sangue, e il Padre lo ricompensa costituendolo Signore dell’universo, a tal segno che di quel Sangue «ne basta una sola goccia per salvare il mondo intero da ogni colpa» [2].
«In preda all’angoscia, pregava più intensamente» (Lc 22,44)
Queste parole, scritte dall’evangelista Luca, hanno un chiaro intento pastorale, ossia quello di mostrare alla Chiesa del suo tempo, sottoposta a lotte e persecuzioni, ciò che il Maestro aveva insegnato a fare in tali frangenti.
Anche la vita d’ogni uomo è costellata di tante piccole notti come quella del Getsemani. Le cause possono essere molteplici e diverse. Gesù ci insegna qual è la prima cosa da fare in questi casi: ricorrere a Dio con la preghiera. Su questo non bisogna ingannarsi. Se Gesù nel Getsemani ricerca la compagnia dei suoi amici, non è per farsi consolare, ma perché lo affianchino nella preghiera, perché preghino con Lui: «Non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate» (Mt 26,40-41). Quanto ciò è importante nella vita d’ogni cristiano: i problemi non si risolvono ricorrendo ad umane compensazioni, a svaghi e divertimenti, seppur leciti. L’esempio di Gesù è anche in questo eloquentissimo. Solo Dio può colmare il nostro cuore, fatto per Lui.
Nelle difficoltà, dunque, nelle tribolazioni, nelle prove d’ogni genere, l’unico vero sostegno è la preghiera, l’intensa preghiera, come è stato per Gesù che nel Getsemani «in preda all’angoscia, pregava più intensamente» (Lc 22,44). Non la semplice preghiera vocale, ma quella preghiera che vuole bere il calice fino alla feccia, pur di compiere la volontà del Padre.
«Abbà! Padre! Tutto è possibile a te» (Mc 14,36)
È importante, a questo punto, notare che la preghiera di Gesù nel Getsemani, nella sua fonte più antica che è Marco, inizia con l’invocazione: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te» (Mc 14,36).
Gesù aveva dato in anticipo ai suoi Discepoli il mezzo e le parole per unirsi a Lui nella prova, quando aveva insegnato loro il Padre nostro (cf Lc 11,1-4). Qualsiasi sentimento si riflette in questa preghiera: la lode, l’adorazione, il ringraziamento, il pentimento. Ma il Padre nostro è anzitutto la preghiera dell’ora della prova.
La preghiera di Gesù nel Getsemani inizia, come il Padre nostro, con il grido: «Abbà! Padre!» (Mc 14,36); prosegue, come il Padre nostro, chiedendo che sia fatta la sua volontà, e che passi da Lui il calice, come quando nel Padre nostro chiediamo di essere “liberati dal male”; esorta poi i Discepoli a pregare per non entrare in tentazione, come a chiusura del Padre nostro chiediamo: «Non ci indurre in tentazione». C’è una somiglianza evidente tra la preghiera che Gesù lasciò ai suoi Discepoli e quella che egli stesso innalzò al Padre nel Getsemani. Egli – anche nel Getsemani – ci ha lasciato, in realtà, la sua preghiera.
La nostra grande risorsa
Sembrerebbe però che la preghiera di Gesù nel Getsemani non sia stata ascoltata dal Padre, visto che il calice della Passione non è stato allontanato.
Dio, notava sant’Agostino, ascolta anche quando... non ascolta! Quando, cioè, non otteniamo quello che gli stiamo chiedendo. Il suo stesso ritardo nell’esaudirci è già un esaudire, per poterci dare di più di quello che gli chiediamo. Se, nonostante tutto, continuiamo a pregare, è segno che ci sta elargendo la sua grazia. Se Gesù terminata la preghiera pronuncia il suo risoluto: «Alzatevi, andiamo!» (Mt 26,46), è perché il Padre «gli ha ispirato – dice san Tommaso d’Aquino – la volontà di soffrire per noi, infondendogli l’amore». Anche santa Teresina di Lisieux si riteneva più fortunata quando la sua preghiera non era esaudita. Perché? Perché era il chiaro segno che Dio si comportava con lei con la massima liberalità, come un padre che sa di potersi fidare ciecamente del figlio fedele, ben sapendo che quel figlio rimarrà tale anche se non è esaudito poiché il suo amore valica i confini di tutte le umane aspettative.
La capacità di pregare è dunque la nostra grande risorsa. Quante volte abbiamo sperimentato nella nostra vita l’efficacia e la potenza della preghiera! La possibilità di pregare è sempre a portata di mano. Pregare, per il vero cristiano, è come respirare. E se la preghiera non è ascoltata, bisogna pregare ancora, “pregare più intensamente”.
Nella preghiera inoltre dobbiamo unirci al nostro divino modello. Specie nell’ora della prova, deve elevarsi al Padre unita a quella di Gesù nel Getsemani. I «gemiti inesprimibili» (Rm 8,26) con cui lo Spirito Santo intercede per noi devono salire al Padre uniti alle «preghiere e suppliche con forti grida e lacrime» (Eb 5,7), che il Figlio elevò a Lui quando giunse la “sua ora”.
«Padre, se vuoi...» (Lc 22,42)
Gesù prega nell’orto: «Abbà! Padre!» (Mc 14,36). Dio è nostro Padre anche se ci manda sofferenze. Ci ama con tenerezza, anche se ci ferisce. Gesù soffre per compiere la volontà del Padre... «E noi, che vogliamo compiere la santissima volontà di Dio, seguendo le orme del Maestro – scrive san Josemaría Escrivá nelle sue meditazioni sulla Via Crucis –, potremmo sorprenderci e lamentarci se troviamo la sofferenza come compagna di strada?
Al contrario, la sofferenza è un segno certo della nostra filiazione divina, perché Dio ci tratta come ha trattato il suo divin Figlio. E, allora, come Lui, potremo gemere e piangere da soli nel nostro Getsemani, ma, prostrati a terra, riconoscendo il nostro nulla, salirà fino al Signore un grido sgorgato dall’intimo dell’anima: “Padre mio... Fiat”».
«...allontana da me questo calice» (Lc 22,42)
La preghiera del Getsemani ci mostra, come nessun’altra testimonianza nei Vangeli, che la preghiera di Gesù era anche preghiera di domanda. È un caso unico nel racconto evangelico, e perciò stesso è di fondamentale importanza. Egli pregava non soltanto per gli altri, ma anche per se stesso. Poiché nell’unità della sua Persona divina vi erano due nature, la natura umana e quella divina, e poiché la volontà umana in se stessa non possedeva l’onnipotenza, era conveniente che Gesù chiedesse aiuto al Padre per fortificare tale volontà, come insegna luminosamente san Tommaso d’Aquino.
I Vangeli, ispirati dallo Spirito Santo, ci hanno lasciato sia la preghiera di Gesù, sia il comando di pregare. Non si tratta evidentemente di un racconto occasionale, ma di un episodio che è paradigma per la vita dei cristiani: la preghiera è il mezzo insostituibile per mantenersi fedeli a Dio.
«Il suo sudore diventò come gocce di sangue» (Lc 22,44)
Che cosa angosciava Gesù? Ovviamente l’imminenza della Passione di cui conosceva tutti i dettagli. Gravavano su di Lui tutti i peccati del genere umano, nel loro insieme e singolarmente. Ma anche il pensiero dei Discepoli atterriti, dei giudei perduti, della morte disperata di Giuda e l’indicibile strazio della sua amatissima Madre.
Come scrive con efficacia san Tommaso Moro, «Cristo sapeva che molti, per la loro stessa debolezza fisica, si sarebbero lasciati atterrire dalla sola idea del supplizio. E perché – mettendo a confronto la loro misera mancanza di coraggio con l’arditezza dei più intrepidi martiri – non si sentissero soccombere, e per timore di non saper resistere alle violenze si arrendessero spontaneamente, ne volle confortare l’animo con l’esempio del suo dolore, la sua tristezza, la sua angoscia e la sua ineguagliabile paura. E a chi sarebbe stato fisicamente costituito a quel modo, volle dire quasi parlandogli direttamente: “Fatti coraggio, tu che sei così debole; per quanto ti senta stanco, triste, impaurito, e assillato dal terrore di crudeli tormenti, fatti coraggio: perché anch’Io che sono il vincitore del mondo, al pensiero dell’amarissima e dolorosa Passione che si avvicinava, mi sono sentito ancora più stanco, triste, impaurito e piegato d’intima angoscia. I forti possono trovare mille intrepidi martiri di cui seguire con gioia l’esempio: ma tu, debole pecorella spaurita, pensa che ti basterà camminare dietro a me, che sono il tuo pastore e il tuo condottiero. Affidati a me, se non puoi avere fiducia in te stesso. Vedi: Io cammino innanzi a te per questa via che ti fa tanta paura, aggrappati all’orlo della mia veste e da lì attingerai la forza che tratterrà il tuo sangue dal disperdersi in vani timori, e terrà saldo il tuo animo al pensiero che stai camminando sulle mie orme. [...] Questo lieve e temporaneo tuo fardello di sofferenza si trasformerà un giorno in un carico immenso di gloria [...]. Riprendi intrepido il cammino, e attraversa tutte le avversità con fiduciosa fermezza: nel combattimento Io sarò al tuo fianco, e avrai la vittoria; nella premiazione sarò tuo giudice, e avrai l’alloro”».
Non v’è dunque nulla di colpevole nella paura della morte e della sofferenza. Al contrario «vi è qualcosa di affine alle sofferenze che patì – senza sottrarsene – lo stesso Cristo». Per tal ragione, non è giusto – continua san Tommaso Moro – «tacciare sbrigativamente di viltà chi abbia timore e orrore dei supplizi; e neppure chi, quando gli sia lecito, sfugge prudentemente i pericoli. Nell’etica militare è infamia fuggire per paura delle sofferenze e della morte, e consegnarsi al nemico dandosi per vinto ancor prima di combattere; ma per quanta paura agiti e sconvolga il cuore del soldato, se questi, al comando del capitano, si mette in marcia, avanza e affronta vittoriosamente il nemico, non ha alcun motivo di pensare che quella sua paura prima della battaglia lo renda meno degno del premio per la vittoria. Anzi, il suo merito sarà maggiore perché, oltre al nemico, avrà saputo vincere anche se stesso; una battaglia spesso più difficile di quella sul campo».
«Apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo» (Lc 22,43)
Gesù, pur essendo Dio e Signore degli angeli, gradisce questo conforto. Egli – in quanto Dio – non ha bisogno di alcuna delle sue creature, ma – in quanto uomo – desidera ricevere l’aiuto e il conforto che esse possono dargli. Questo è un conforto per noi, non per Lui. Per noi, perché il Signore si degna di desiderare il nostro conforto. E quale non dovrebbe allora essere la consolazione che noi diamo a Gesù! Da questo episodio del Vangelo è scaturita un’intera spiritualità che identifica l’anima cristiana (e specialmente l’anima consacrata) con quell’angelo che consola il Signore. I cristiani (e specialmente i consacrati), infatti, dovrebbero essere i primi consolatori di Gesù agonizzante.
E noi lo consoliamo o, forse, sonnecchiamo come gli Apostoli, ignari delle sofferenze del Redentore?
«Li trovò che dormivano» (Lc 22,45)
Tornato per la terza volta, Gesù trovò i suoi Discepoli addormentati, invece che desti in orazione, come aveva loro raccomandato. Giuda, nello stesso tempo, tutto intento ad ordire il tradimento, non fu sfiorato neppure per un istante dall’idea di dormire.
«Nel comportamento così diverso del traditore e degli Apostoli – scrive ancora san Tommaso Moro – non contempliamo, come in uno specchio, l’immagine chiarissima e desolante di quanto è accaduto nei secoli successivi fino ad oggi? [...] Molti infatti dormono, quando dovrebbero seminare le virtù tra i fedeli; dormono, quando dovrebbero confessare la fede. E intanto i nemici di Cristo passano la notte vegliando per seminare i vizi e sradicare la fede; cioè fanno il possibile per catturare di nuovo Cristo e crocifiggerlo crudelmente un’altra volta. Tanto più avveduti dei figli della luce – come dice Cristo – i figli delle tenebre».
IN AGONIA FINO ALLA FINE DEL MONDO
San Leone Magno afferma che «la Passione di Cristo si prolunga sino alla fine dei secoli». Gli fa eco il filosofo Blaise Pascal nella celebre meditazione sull’agonia di Gesù: «Cristo – scrive – sarà in agonia fino alla fine del mondo. Durante questo tempo, non bisogna dormire. “Io pensavo a te nella mia agonia: quelle gocce di Sangue le ho versate per te. Vuoi costarmi sempre Sangue della mia umanità, senza che tu versi una lacrima? Io ti sono più amico del tale e del talaltro, perché ho fatto per te più di loro ed essi non soffrirebbero mai quel che ho sofferto da te, non morirebbero mai per te nel tempo della tua infedeltà e delle tue crudeltà, come ho fatto Io e come sono pronto a fare nei miei eletti e nel Santo Sacramento”».
Ciò che Pascal afferma è misteriosamente vero. Gesù è anche ora nel Getsemani, nel pretorio, sulla Croce. E non solo nel suo Corpo mistico – ossia nelle sue membra sofferenti – ma, in modo misterioso, anche nella sua stessa persona. E ciò – è stato giustamente osservato – è vero non “nonostante” la Risurrezione, ma proprio “a causa” della Risurrezione che ha reso il Crocifisso “vivente nei secoli”. L’Apocalisse ci presenta l’Agnello in cielo, “ritto”, cioè risorto e vivo, ma con i segni tuttora visibili della sua immolazione (cf Ap 5,6).
Getsemani ed Eucaristia
Il luogo privilegiato dove possiamo incontrare Gesù “in agonia fino alla fine del mondo” è l’Eucaristia. Gesù la istituì immediatamente prima di recarsi nell’orto degli ulivi – v’è dunque anche una vicinanza, per così dire, “temporale” tra Eucaristia e Getsemani, poiché l’istituzione del Santissimo Sacramento è l’ultimo atto di Cristo prima dell’agonia –, perché i suoi Discepoli potessero, in ogni epoca, diventare “contemporanei” della sua Passione. Quando siamo davanti all’Eucaristia, dunque, noi diveniamo, in modo misterioso ma reale, contemporanei alla Passione di Cristo. Quale non deve essere allora l’amore, l’affetto, la riverenza con cui dobbiamo circondare quest’augustissimo Sacramento! In nessun altro luogo come dinanzi all’Eucaristia, possiamo consolare Gesù nella sua agonia, possiamo divenire per Lui quell’angelo che, solo, gli diede conforto nell’ora della prova.
Questo non deve, evidentemente, farci dimenticare l’altro modo con cui Cristo “è in agonia fino alla fine del mondo”, e cioè nelle membra del suo Corpo mistico.
La parola “Getsemani” è spesso usata come metafora per indicare il dolore morale d’ogni specie. Infatti, benché nel Getsemani Gesù non abbia ancora subito alcun supplizio fisico, suda Sangue solo qui, quasi a mostrare che il dolore del Getsemani è il maggiore per intensità. E ciò non dovrebbe sorprendere, se è vero – com’è vero – che quanto l’anima è superiore al corpo, tanto il dolore dell’anima è più tremendo di quello del corpo. È, questa, una verità che i santi hanno sperimentato e tramandato unanimemente.
Ai nostri giorni, col dilagare d’una filantropia senza regole – e talvolta senza “perché” – tutta incentrata sull’uomo nella sua realtà fisica, sui poveri, sugli ammalati, ecc., si è dimenticato che il male morale causa spesso assai più vittime del male fisico.
Quanti “getsemani” disseminati nel mondo, lontani e vicini. Quanti “getsemani” forse sotto lo stesso tetto in cui viviamo, magari nel cuore di chi è a noi più vicino, e noi... dormiamo!
CONCLUSIONE
Viviamo, dunque, da veri cristiani. Viviamo intensamente questo ultimo scorcio di Quaresima, tempo privilegiato di riflessione e conversione. Destiamoci dal nostro torpore spirituale e cerchiamo di consolare Gesù nel Getsemani con la devota adorazione del Santissimo Sacramento e con l’attenzione vigile e fraterna verso chi, accanto a noi, sta attraversando il suo “getsemani”. Viviamo in modo che Gesù – quando giungerà la nostra “ora” – non debba dirci: «Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati» (Sal 69,21), ma possa, al contrario, sussurrare al nostro cuore la sua parola eterna che tutto vivifica e ricompensa: «Quello che avete fatto a uno solo di questi miei più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).
Note
1 «Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: “Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora”. Giacobbe rispose: “Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!”. Gli domandò: “Come ti chiami?”. Rispose: “Giacobbe”. Riprese: “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!”. Giacobbe allora gli chiese: “Svelami il tuo nome”. Gli rispose: “Perché mi chiedi il nome?”. E qui lo benedisse» (Gn 32,26-30).
2 Così recita il famoso inno eucaristico Adoro te devote di san Tommaso d’Aquino [ndr].
- 1 Maria Bambina: gioia di tutta la terra
- 2 Halloween-mania. E i cattolici?
- 3 Una santa da scoprire. Santa Dulce de Souza Britto Lopes
- 4 Il santo segno della Croce di Cristo
- 5 Convertire le anime con il santo Rosario
- 6 I segni dell’Amore
- 7 Fedele figlio del Serafico Padre
- 8 Nella “gloria” di padre Pio